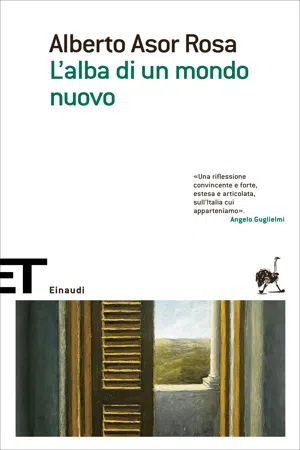![]()
A quelli che sono stati e a quelli che saranno.
«– and it is for readers such as these that we write – …»
V. WOOLF
![]()
Mi muovevo freneticamente per casa da una stanza all’altra, e i mobili mi sovrastavano, alti e un po’ misteriosi, con tutti i loro sportelli e cassetti chiusi, rinserrati, ostili, e con le maniglie lontanissime, del tutto fuori dalla mia portata. Anche se lo avessi voluto, in quella parte del mondo non avrei potuto penetrare e, a dir la verità, non mi veniva neanche in mente di provarci: quello era il mondo dei grandi. Io mi limitavo a esserci.
Il corridoio si allungava fino alla porta massiccia, da cui entravano improvvisamente, quando si spalancava, le luci e i suoni della scala: verso il fondo, vicino alla porta, quando era chiusa, c’era una zona d’oscurità, in cui non osavo addentrarmi, e dove i muri, invece di correre paralleli l’uno all’altro, sembravano restringersi e far corpo fra loro. La massima prova di coraggio era questa: «Vai ad aprire la porta», diceva sorridendo mia madre, quando si sentiva scampanellare, e mi spingeva dolcemente per la schiena verso quel buio. Avanzavo tutto contratto in quel breve spazio oscuro, trattenendomi a forza dal chiudere gli occhi, perché mi rendevo già conto che questo avrebbe reso vana la dolorosa prova di coraggio: ma guardavo fisso innanzi a me con occhi sbarrati per scoprire il piú presto possibile il pomello della serratura, che avrei tirato un istante dopo con tutte le mie forze, emettendo un sospiro di sollievo. Dietro le mie spalle, in quei momenti, avvertivo fisicamente il buio richiudersi inesorabile ad ogni passo che facevo.
Nei pomeriggi dei giorni d’inverno mio padre tirava una grande tavola di compensato davanti ai vetri di una vecchia libreria e giocavamo insieme a palla nel corridoio illuminato dalla luce un po’ stenta di uno di quei lampadari di ferro battuto con i vetri colorati. Mio padre mi stava di fronte all’altra estremità del corridoio, alto e calvo, con i baffi scuri appena accennati, e lanciava la palla con mosse goffe nella ristrettezza di quello spazio. La palla si muoveva in maniera magicamente rapida, rimbalzava a terra, batteva talvolta sonoramente sulla tavola di compensato, faceva tintinnare i vetri nascosti della libreria e schizzava veloce e lucida dalle mie parti: un bizzarro essere mobile e saltellante, dotato di un’anima propria, difficile da catturare e da governare, tanto diverso dagli altri oggetti che mi fronteggiavano, immobili e indifferenti, nel corso della giornata, i tavoli, i mobili, i piatti in cui mangiavo, le mura di casa. Ogni volta che mi riusciva di afferrarla, la stringevo trionfante a me e mi rifiutavo di tirarla di nuovo a mio padre. La sentivo morbida e docile fra le mie mani, ma non riuscivo a persuadermi che la sua natura mobile si fosse acquietata. Perciò la tenevo forte, per il timore che mi balzasse di nuovo dalle mani. Mio padre non mi aveva convinto che ciò che facevamo fosse ciò che, poco piú tardi, anch’io avrei chiamato gioco: «Alberto, io ti tiro la palla, tu la tiri a me, e io poi la ritiro a te…» Per me quello non era un gioco, ma una cosa estremamente seria: mi sembrava giusto che, quando m’era riuscito di catturare quello spirito folletto, che danzava irridente fra noi, quell’estenuante, saltellante tir’e molla finisse. Piuttosto trovavo divertente correre a mostrare la palla a mia madre che, in cucina, sbrigava le faccende di casa, e che ogni volta manifestava l’intuito amoroso e terribile di complimentarsi con me: «Bravo Alberto, l’hai presa…»
Quando piangevo o facevo capricci, venivo rinchiuso nella stanza da letto. La mia testa si aggirava sospesa nel vuoto della stanza, assai piú bassa della spalliera del letto dei miei genitori: mi dovevo alzare sulla punta dei piedi per sbirciare al di là di essa la coperta colorata e le immagini sacre appese alla parete.
In uno degli armadi, davanti al letto, era incastonato uno specchio molto grande, di quelli ad altezza d’uomo. Ci trotterellavo davanti piú e piú volte senza farci caso, fino al momento in cui lo sguardo mi cadeva all’improvviso su quell’immagine gemella, che ripeteva con fedeltà prodigiosa tutti i miei movimenti e il mio pianto. All’inizio non riuscivo a rendermi conto di chi fosse l’individuo che mi fissava con uguale intensità al di là di quella superficie liscia di cui saggiavo la consistenza, appoggiandovi ambedue le mani. Restavo lí a guardarmi per minuti lunghi come un’era: ogni volta che muovevo le mani, le mani al di là anch’esse si muovevano e tornavano a piantarsi solidamente proprio là dove avevo nuovamente piantato le mie. Solo a poco a poco riuscii a persuadermi che l’altro fosse io: ma anche prima, e sia pure del tutto oscuramente, intuivo che fra noi due c’era un’affinità, una somiglianza, che, senza neanche volerlo, rendeva possibile quell’automatica, stolida ripetizione. Della mia forma non ricordo nulla, se non lo sguardo che mi lanciavo, misteriosamente, oltre quella cortina trasparente e pure cosí compatta di cristallo: i miei occhi non guardavano la mia faccia e il mio corpo, i miei occhi guardavano i miei occhi, i miei occhi si affascinavano e si perdevano guardando i miei occhi, sprofondando senza fine, per un tempo incalcolabile, gli uni negli altri, gli uni negli altri…
Non c’è traccia dei miei pensieri di allora: forse non ce n’erano. So per certo che c’era una porta chiusa, alla cui maniglia non riuscivo ad arrivare, che mi separava dolorosamente da mio padre e da mia madre, e che costituiva una punizione per qualcosa che non avrei dovuto fare ma che mi era piaciuto fare. Per fortuna, essa non tratteneva del tutto i rumori e i suoni: le voci, per quanto smorzate, arrivavano a me dalle altre stanze e io mi consolavo pensando che mio padre e mia madre non erano scomparsi per sempre, che c’erano ancora (consolazione di cui ci si rende pienamente conto solo quando non se ne può piú approfittare). Del resto, arrivava sempre il momento in cui la porta s’apriva e la solitudine finiva. Sgusciavo rapido fuori della porta socchiusa, colmo di una riconoscenza infinita. Ma per vedere che faccia avessero mia madre e mio padre, dovevo guardare in alto, molto in alto.
Piú indietro, s’apre un buio senza fine, da cui provengono (forse) le sensazioni imprecise e inquietanti, che ancora costellano la mia vita: il modo d’incrociare i piedi e di stringermi tenacemente le braccia al petto mentre dormo, un’improvvisa, inspiegabile sensazione di paura, una voglia di piangere che non si sa donde venga, l’angoscia serotina, l’impulso misterioso ad alzarmi di colpo e a correre impetuosamente verso una meta che non esiste, una voce, un rumore, un suono, una luce, che destano quando meno te l’aspetti l’eco di qualcosa che non c’è piú, e di cui si continua ad avvertire la risonanza, ma senza piú sapere di cosa. L’eco c’è ancora, continua a vibrare, ripetendo monotonamente i suoi indecifrabili messaggi, sempre gli stessi, ma l’esperienza originaria che ha dato loro la vita è scomparsa in una lontananza troppo grande. Ai piedi di questa muraglia oscura, – che però, forse, è soltanto un vuoto sconfinato, il luogo della perdita della memoria, dove non c’è niente, se non il colore perso di ogni cosa perduta, – talvolta mi accoccolo stanco, stringendomi come faccio di solito le braccia al petto, implorando di essere ammesso là dove nessuno è mai potuto ritornare; altre volte vago senza meta, irrequieto e scontento, cercando ogni tanto d’infilare la testa in un punto qualsiasi in cui un indizio inesistente sembra segnalarmi la presenza di un varco. Possibile non sia sopravvissuto nulla di me alle dure necessità della crescita? Mi sposto lentamente lungo quella tenebrosa linea di confine, in questa desolata periferia del vuoto, raccolgo pazientemente e catalogo entomologicamente segnali, indizi, reperti, frammenti, barlumi, – o, meglio, m’illudo di farlo. L’inizio è scivolato via per misteriose, profonde linee di fuga ed è tornato a immergersi là dove la vita originariamente era scaturita. Nelle notti insonni esploro la tenebra notturna con gli occhi spalancati per rendermi conto se, buio nel buio, lí s’apre in qualche punto la strada del ritorno: quella che porta cosí lontano da essersene persa ogni memoria. Snervato dall’attesa, riprecipito nel sonno, pensando, per consolarmi, che un giorno la fine dei tempi coinciderà con il loro inizio (tenebre con tenebre, naturalmente).
![]()
Guardavo dal basso verso l’alto una corona di teste che mi osservavano sorridendo. Mia madre andava a prendere mio padre che usciva verso le quattro, le cinque del pomeriggio dal suo ufficio (il Ministero dei Trasporti, mio padre era ferroviere, anche se di specie impiegatizia, cosa che avrebbe avuto qualche influenza sul mio destino futuro), e poi, insieme con un gruppo di amici e colleghi, si riunivano al Caffè Rosati, a Porta Pia. Osservavo il mondo e i grandi da una prospettiva decisamente sfavorita: per vederne qualcosa di piú che le scarpe o gli stinchi infilati in ben curati pantaloni ministeriali, dovevo alzare la testa fino a toccarmi le spalle con la nuca, mentre loro, per accorgersi che c’ero, dovevano abbassarla fino a toccarsi il petto con il mento. Il mondo cosí era veramente disuguale, e la cosa presentava per me qualche scomodità, soprattutto perché a lungo ho pensato che quella fosse una condizione naturalmente insuperabile, che io non mi sarei mai sollevato dal livello in cui ero stato posto e di cui in quel momento avevo coscienza. Chi ha detto che i bambini sanno che cresceranno? Io non lo sapevo. Forse «pensare» e «sapere» è dir troppo. Probabilmente mi limitavo a constatare quanto fossimo diversi: per stabilire dei rapporti, che tenessero conto di quelle enormi disuguaglianze, dovevo continuamente arrangiarmi, sforzare il piú possibile le mie embrionali capacità inventive, scavare nell’immaginazione per riuscire a impormi.
Con quella compagnia, come ho detto, potevamo guardarci negli occhi solo salendo e scendendo contemporaneamente da ambedue i lati lungo una linea retta piantata verticalmente in mezzo a noi. Allora non immaginavo che, per raggiungere davvero la loro altezza, avrei dovuto arrampicarmi faticosamente su quella lunga pertica che, in quel momento, piú che congiungerci, ci separava. Se qualcuno, alla mia età di allora, sapesse quanta fatica costa quest’esercizio, probabilmente vi rinuncerebbe ancor prima di cominciare. Ma allora c’era in me un impulso irresistibile a rendere visibile la mia presenza, a imporla, se necessario, – movimento fisico, naturale, prima che mentale, vera e propria eruzione di energie in ogni Pinocchio che si rispetti, forza di crescita interiore insostituibile, – e per raggiungere tale risultato non disdegnavo di ricorrere ai piú banali e buffoneschi espedienti. Avevo presto imparato che per attirare l’attenzione di quegli occhi e di quelle teste cosí distanti dovevo fare o dire qualcosa di diverso e possibilmente di divertente, altrimenti non sarei uscito dalla mia trascurabile marginalità. Sembrava che lo fosse pronunciare al momento giusto parole poco comuni o che per lo meno a me tali apparissero: per esempio «Baccalà», che in un italiano famigliare significava, e per molti ancora significa (il perché non lo so), scemo, cretino, ma detto scherzosamente, anzi con un certo affetto (e infatti con questo spirito me lo ripeteva spesso mia madre, quando commettevo una di quelle balordaggini, che da allora costituiscono uno dei tratti distintivi piú rilevanti della mia personalità). Io sceglievo accuratamente il mio soggetto, fissavo intensamente una delle teste che di lassú mi fissava e, dopo un istante di calcolata sospensione, prorompevo con la mia vocina: «Baccalà!» Vedevo la fila delle teste in alto rovesciarsi istantaneamente, come se un colpo secco le avesse spinte tutte insieme all’indietro, e al tempo stesso sentivo uno scroscio di risate piovermi addosso. Capivo di aver fatto bene e provavo la soddisfazione di ogni spettacolo ben riuscito. La mano della mamma, che scendeva ad accarezzarmi lievemente la nuca, mi confortava in questa gioiosa persuasione.
![]()
Quando andai a scuola per la prima volta, non sapevo cosa volesse dire, e perciò non ero né contento né spaventato. Entrai direttamente in prima elementare, poiché allora, se Dio vuole, non si era mai sentito parlare né di scuola materna né di asilo e dunque l’inerme, indifesa creatura dell’uomo, – questo bambolotto in carne e ossa, a cui non si vede l’ora d’insegnare come si fa a stare dentro le norme, – poteva trascorrere qualche anno in piú nella calda cavità materna, fra il seggiolone, il romito spazio dei giocattoli e il lettino protettore. Era un giorno del mese di settembre, dai colori vividi e accesi, ultimo prolungamento di una bella estate. Davanti all’ingresso della Scuola Mario Guglielmotti (un povero ignoto, martire non so come della Rivoluzione fascista), costruita da poco in una zona non brutta della periferia romana, a breve distanza dal punto dove le Mura Aureliane dispiegano la loro piú maestosa bellezza, con i volumi squadrati e geometricamente piacevoli dell’architettura razionalistica del Regime, verso le otto di mattina, c’era una grande calca: bambini e mamme formavano una massa formicolante e inestricabile. Molti dei miei compagni piangevano abbracciati alle gonne materne: io, anche se sentivo piegarmisi le ginocchia, reprimevo un analogo turbamento, fedele al severo comando materno: «Non farti vedere», che piú o meno voleva dire: nascondi il piú accuratamente possibile i tuoi sentimenti, soprattutto se di genere lamentevole e querimonioso, non è bello «farsi vedere» per quel che si è e tanto meno per quel che si prova, bisogna stringere i denti e mostrare un volto tranquillo e sorridente, anche se si è angosciati nella peggior maniera.
Gli scolari di sesso maschile delle classi elementari erano allora ottimamente addobbati, con sventolanti grembiuli blu larghi come palandrane, l’alto solino inamidato (che segava ferocemente il collo), un grande fiocco bianco di cotone o, per i piú raffinati, di seta sotto il mento, i numeri romani cuciti sulla manica a indicare la classe di appartenenza. Le bambine erano vestite piú o meno nello stesso modo, ma con i colori invertiti: i grembiuli bianchi, i fiocchi blu, ecc. Sotto il grembiule sia ai maschi sia alle femmine spuntavano le tenere gambe nude, come a dei pulcini totalmente implumi. Se uno tirava un calcio a un compagno, – e ciò accadeva assai frequentemente, – poteva esser certo di lasciare un bel segno.
La maestra Chiarinelli era grigia, dolce e molto materna: per il momento dello strappo costituí un surrogato assai efficace di quelle presenze apparentemente insostituibili, che con un tuffo al cuore vedemmo sparire all’improvviso al di là della porta che un Cerbero bidello impietosamente ci sbarrava davanti al naso. All’inizio della giornata dicevamo innanzitutto le preghiere, poi stendevamo le nostre mani accuratamente aperte sul banco: la maestra ci faceva la «rivista», se uno aveva le unghie o le dita sporche gli scriveva una nota sul quaderno, qualche volta gli tirava uno scapaccione sulla nuca. Accanto a me s’era seduto spontaneamente il figlio di un giardiniere di Villa degli Scipioni: era poco curato e mandava cattivo odore; mia madre, in uno dei suoi ricorrenti soprassalti piccolo-borghesi, ottenne che fossi accoppiato con il giovane Sabbatini, il quale, quanto a lindore e buona educazione, avrebbe dato dei punti al Derossi del libro Cuore.
In alto, sulla parete dietro la maestra Chiarinelli, stavano appesi il ritratto fotografico di Vittorio Emanuele III, ovverosia Sua Maestà il Re d’Italia, Imperatore d’Etiopia e d’Albania, in elmetto militare con gli asprí in bella mostra, e quello del Presidente del Consiglio e Duce del Fascismo, Benito Mussolini: in mezzo a loro penzolava, appeso alla sua croce, Gesú, con l’aria di uno abituato a stare fra i ladroni. Guardavo meditabondo le fotografie, guardavo compunto il Crocefisso, ma soprattutto guardavo e ascoltavo senza stancarmi mai la maestra Chiarinelli: non mi perdevo una battuta, mi abituavo a pensare in sintonia con lei, mi sarebbe dispiaciuto dispiacerle, – visto che era cosí buona e dolce con noi. L’ideologia del Primo della classe aveva cominciato a produrre i suoi effetti devastanti. La classe, dietro e davanti a me, era un fondale vasto e brulicante, un mare di volti e di voci diversi, sempre in movimento, sempre in mutazione, una specie di scena collettiva, squadrata dalle due fasce di vernice, lucida e blu sul basso, bianca e calcinata verso l’alto, su cui ognuno di noi era tenuto a recitare la propria parte: e la mia fu da subito, non so perché, fare di meglio e di piú in tutto. Mi piacevano sommamente in certi casi le grandi ammucchiate, quando, ad esempio, nei giardinetti davanti alla scuola, all’uscita, dieci-venti bambini, spingendosi e urtandosi a catena, potevano finire tutti gambe all’aria, con borse, righe e righelli, libri e quaderni, in una sola grande catasta (e allora la cravatta, attorcigliandosi intorno al collo sotto il solino inamidato, poteva davvero tirare fino a toglierti il respiro). Ma nella mia aula, seduto al banco, provavo il bisogno di guardare davanti a me, attento alla spiegazione: la concentrazione, in quei momenti, mi dava molto piú piacere di qualsiasi motivo di distrazione. Frutto della lunga preparazione materna? Non lo so. Il fascino dell’apprendimento e della lettura non sono stati per me, almeno apparentemente, la conseguenza di un lungo, paziente lavoro di avvicinamento: di colpo fui risucchiato, e piacevolmente risucchiato, nell’eterno, mostruoso meccanismo dell’apprendimento: se sarai buono, se farai il bravo, saprai cose meravigliose, e sarai premiato. Spingevo il mio desiderio di un rapporto diretto e confidenziale con l’autorità da cui promanava il sapere fino al punto di prestarmi a fare per lei il sovrintendente e la spia: quando la maestra doveva assentarsi dalla classe per un qualche motivo, venivo messo a sorvegliare la disciplina e scrivevo sulla lavagna i nomi dei miei compagni cattivi. Quel che accadeva quando la maestra era fuori, è difficile descriverlo: la classe diventava una bolgia, praticamente solo i deficienti e i rachitici restavano fermi ai loro posti. Una volta arrivai a scrivere sulla lavagna i nomi di tutti i componenti della classe: evidentemente anche i deficienti e i rachitici si erano mossi. Incapace di fronteggiare quell’assoluta rivolta, sconvolto dalla clamorosa impossibilità di garantire in qualsiasi modo l’ordine, feci un decisivo giro di boa: aggiunsi per ultimo il mio nome al fittissimo elenco e tornai al mio posto, ingaggiando una lotta furiosa con il mio vicino di banco. Quando la maestra Chiarinelli rientrò in classe, non credeva ai suoi occhi: disse che non le era mai capitata una cosa del genere in vita sua e biasimò fortemente la mia condotta, di cui, del resto, non aveva affatto colto la disperata ironia.
Qualche settimana dopo l’inizio della scuola fu organizzata la cerimonia del nostro primo giuramento al Duce. In quanto allievo di una scuola pubblica italiana, ero ipso facto un Figlio della Lupa, il primo gradino di una scala gerarchica, che, senza soluzioni di continuità, avrebbe dovuto negli anni successivi metamorfosarmi in Balilla, Moschettiere del Duce, Avanguardista e infine Giovane della Pre-Militare, ormai in grado a quel punto di maneggiare perfettamente le armi e di servire a pieno titolo la Patria nelle azioni di guerra, che, immancabilmente, avrebbero caratterizzato il nostro glorioso futuro. Io, nonostante le ottimistiche previsioni, mi sono fermato a quel primo gradino, ma, accanto a me, il sabato pomeriggio, sul campo della Gil (Gioventú Italiana del Littorio) adiacente alla mia scuola, e diventato poi piú modestamente un terreno di gioco per il calcio rionale, marciavano apparentemente spavaldi e da noi molto ammirati gli squadroni delle categorie piú anziane, vestiti con monture che stavano a metà fra le divise militari della Prima Guerra Mondiale e i costumi dei Tre Moschettieri.
Per accedere a tale iniziazione era necessario dotarsi dell’armamentario richiesto. Mio padre, iscritto tardivamente al Fascio nel 1933, l’anno della mia nascita, costretto dall’imprescindibile necessità di garantire il pane alla sua famiglia, si teneva dignitosamente in disparte. Fu dunque mia madre ad accompagnarmi in lungo e in largo per Roma, alla ricerca di magazzinetti e rivenduglioli specializzati, dove s’accalcava una vera folla di acquirenti alla ricerca degli elementi fondamentali del travestimento, che comprendevano: il fez nero sulla testa, con il pon pon ciondolante sulle spalle, la camicia nera d’un tessuto lucido, pesante, le bandoliere bianche strette sul petto da un fermaglio metallico che riproduceva la M vibrante della firma di Mussolini, un fazzoletto azzurro stretto intorno al collo, chiuso da un medaglione fint’argenteo con il profilo imperioso del Duce, un’ampia fascia elastica, anch’essa nera, alla cintura, calzoncini corti neri, calzettoni grigioverdi di tipo militare, e infine scarpe arrangiate in casa con la tintura nera, per sembrare anch’esse d’ordinanza, quando erano quelle scalcagnate e un po’ strette dell’anno prima, siccome doverne comprare delle nuove apposta, tenendo conto delle ristrettezze economiche famigliari, avrebbe costituito un vero problema. Il bambino italiano di allora si era abituato a pendolare fra un rispettabile grembiule blu, – alquanto grazioso, se vogliamo, e un poco femmineo, – e questa camuffatura guerriera, sabbatica e domenicale.
Il giorno prestabilito, tutti in divisa, affidati non piú ai maestri e alle maestre ma ai capisquadra e ai capimanipolo, fummo inquadrati nel cortile della scuola, arrivò un tale in stivaloni e divisa nera, con un enorme berretto su cui spiccava l’aquila d’oro del regime, ci lesse con voce scandita e vibrante una formula di totale, incondizionata fedeltà al Duce, e poi ci chiese: «Lo giurate voi?» Noi gridammo in coro, con tutto il fiato di cui eravamo capaci: «Lo giuro!» Da quel momento entrammo a far parte tutti, d’un colpo solo, del Fascismo, come in una di quelle cerimonie medievali di massa in cui interi popoli barbarici si convertivano con i loro sovrani al Cristianesimo. Io ero combattuto fra un certo naturale disagio, – c’era qualcosa nella cerimonia che andava al di là del mio senso del piacere, – e l’impulso imitativo. Di fatto giurai, sputando fuori le parole con tutta l’aria che avevo nei polmoni. Per quanto possa apparire strano, a lungo poi, fino all’adolescenza, fui tormentato dal problema morale se, avendo comunque giurato, benché del tutto indipendentemente dalla mia volontà, non sarebbe stato piú giusto mantener fede all’impegno preso, e mi rammaricavo con me stesso di non essermi limitato a spalancare la bocca, come alcuni dei miei compagni accanto a me misteriosamente avevano fatto.
Ogni tanto capitava di partecipare in divisa a raduni, cerimonie, ricorrenze, sfilate. Una volta fummo portati a Cinecittà per prestare le nostre immagini alle nuove sequenze introduttive del film documentario Luce, che fino a quel momento erano consistite in una specie di aquilotto starnazzante, appollaiato su di un fascio. Fummo fatti sfilare per finta dentro un immenso capannone: alzavamo ritmicamente le gambe, simulando la marcia, senza spostarci di un centimetro da dove eravamo, mentre le cineprese ci riprendevano. Ripetemmo la scena infinite volte, sotto la luce accecante e caldissima dei riflettori. Non sapevamo piú come fare, le ginocchia ci si piegavano per la stanchezza, ogni tanto uno di noi fuggiva negli angoli bui del capannone per orinare. Quando il cinegiornale Luce fu proiettato nelle sale nella nuova veste, mia madre decise che io ero il bambino che, in terza o quarta fila, invece di marciare con la testa diritta verso l’imminente futuro imperiale d’Italia, la muove indisciplinatamente a destra e a sinistra, senza essersi res...