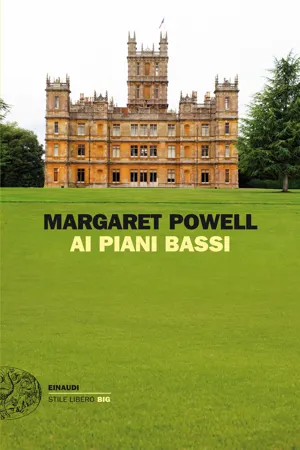![]()
Margaret Powell
Ai piani bassi
Traduzione di Carla Palmieri e Anna Maria Martini
![]()
a Leigh (Reggie) Crutchley
con gratitudine e affetto
![]()
Sono nata nel 1907 a Hove, seconda di sette figli. Il mio primo ricordo è che gli altri bambini sembravano tutti piú ricchi di noi. Però i nostri genitori ci volevano un gran bene. Ogni domenica – non lo dimenticherò mai – papà ci regalava un giornalino e un sacchetto di dolci. Il giornalino con i disegni in bianco e nero costava mezzo penny, quello a colori un penny. A volte mi domando come facesse, specialmente quand’era senza lavoro e in casa non entrava neanche un soldo. Mio padre era imbianchino e decoratore. Una specie di tuttofare, in realtà. Riparava i tetti, intonacava i muri: quasi tutto, insomma, anche se il suo vero mestiere era dipingere pareti e incollare tappezzerie. Ma d’inverno, nel quartiere dove abitavamo, non si batteva chiodo. Nessuno voleva farsi ristrutturare la casa nei mesi freddi: lavori all’esterno non se ne potevano fare, e rimettere a nuovo gli interni era una bella rogna. Perciò d’inverno era piú dura.
Mia madre faceva la donna delle pulizie, lavorava dalle otto del mattino alle sei di sera per due scellini al giorno. A volte tornava a casa con qualche piccolo tesoro: una ciotola di sugo d’arrosto, una mezza pagnotta, un po’ di burro, una scodella di zuppa. Fosse stato per lei, non avrebbe accettato mai niente. Detestava la carità. Noi invece eravamo contenti come pasque, e quando tornava con qualcosa in mano correvamo fuori a vedere cos’era.
Forse oggi vi sembrerà strana, questa antipatia per la carità, ma in effetti quando eravamo bambini non c’era il sussidio di disoccupazione. Tutto quel che ti davano era una specie di elemosina.
Se avevamo solo un paio di scarpe ciascuno, e per giunta erano rotte, mia madre andava in comune e chiedeva qualche soldo in piú per noi. Le toccava rispondere a un’infinità di domande, e si sentiva guardata con disgusto, solo perché non aveva abbastanza soldi per tirare avanti.
A quei tempi trovare un posto per vivere era tutt’altra faccenda rispetto a oggi. Bastava guardarsi intorno: per strada era pieno di cartelli che dicevano «affittasi stanze». Quando eravamo in bolletta nera ci accontentavamo di una o due camere in subaffitto, ma quando papà lavorava andavamo a cercare un appartamento da condividere. Una casa tutta nostra, non l’abbiamo mai avuta. A quei tempi non erano in molti a potersi permettere una casa intera. Comprarsela, poi, neanche per sogno!
Io non riuscivo a capire perché la mamma continuasse a fare bambini, visto che per noi era già cosí dura, e ricordo che lei si arrabbiava moltissimo quando le due vecchie zitelle per le quali lavorava continuavano a dirle di non fare piú figli, che non poteva permetterseli. Anch’io le chiedevo: «Perché hai tanti bambini? È difficile fare i bambini?» E lei: «No, no, per niente! È facile come bere un bicchier d’acqua!»
Ma per i poveri, sapete, era l’unico piacere. Non costava niente, almeno nel momento in cui mettevi in cantiere il bambino. Certo, piú avanti le spese c’erano, ma quelli come noi non erano abituati a guardare avanti. Non ne avevano il coraggio. Vivere alla giornata era già abbastanza.
Nessuno si preoccupava di controllare le nascite. Sarà stata un’eredità dell’epoca vittoriana, ma l’idea era che le famiglie dovessero essere numerose. Piú bambini avevi, piú si pensava che tu facessi, diciamo cosí, il tuo dovere di buon cristiano. Non che la Chiesa contasse un granché nella vita dei miei genitori. Probabilmente non avevano tempo di pensarci; o meglio, forse il tempo ce l’avevano, ma gli mancava la voglia. Alcuni di noi non erano neanche battezzati. Io, per esempio, non lo ero e non lo sono neanche adesso. Alla scuola domenicale, però, dovevamo andarci tutti, e non perché i miei fossero religiosi: era semplicemente un modo per tenerci alla larga. La domenica pomeriggio si faceva l’amore, perché nelle famiglie dei lavoratori non c’era mai abbastanza intimità. Se abitavi in due o tre stanze, doveva per forza esserci qualche bambino che dormiva con mamma e papà. A quel punto, se avevi un briciolo di pudore – e i miei ce l’avevano di sicuro, perché da bambina non mi sono mai accorta che facessero l’amore – aspettavi che i figli dormissero sodo o fossero in giro. A dire il vero non li ho mai visti neppure darsi un bacio, perché davanti agli altri mio padre era piuttosto austero: poi un giorno la mamma mi disse che invece era molto passionale, e io ci rimasi di stucco. E quindi, capirete, potevano lasciarsi andare solo quando i bambini erano fuori dai piedi. Cosí la domenica pomeriggio, dopo un bel pasto abbondante (per quanto possibile ci provavano tutti, a cucinare un bel pasto abbondante) si andava a letto a fare l’amore, e magari anche un pisolino come Dio comanda. Perché se fai l’amore, diceva la mamma, tanto vale stare comodi. Ecco perché a quei tempi la scuola domenicale era frequentatissima.
Dei primi giorni di scuola non ho questo gran ricordo. Mio fratello e io abbiamo cominciato la scuola insieme. A quei tempi si iniziava a quattro anni, ma mia madre decise di mandare anche me, perché stava per sfornare un altro bambino e le faceva comodo togliersi dai piedi i due piú grandi.
Bisognava tornare a casa per il pranzo. Non c’era ancora la mensa, e nemmeno ti davano il latte gratis. Partivi da casa con una fetta di pane imburrato avvolta in un pezzo di carta, e la davi da custodire alla maestra perché molti bambini avevano una fame da lupi, e invece di stare attenti alle lezioni passavano la mattina a mordicchiare il pane. Alle undici, poi, la maestra distribuiva le fette di pane. Siccome me la cavavo abbastanza bene, mi è sempre piaciuto andare a scuola. Non avevo problemi in nulla, fuorché nel disegno, nel lavoro a maglia e nel cucito. Anche a cantare ero un disastro. Roba di cui non m’importava un bel niente. Il cucito, poi, lo odiavo con tutto il cuore. Facevamo cose orrende: sottovesti e calzoncini a sbuffo in tela di cotone. Le sottovesti erano ampie, lunghe fino al ginocchio e con le maniche ad aletta. I calzoncini, anche loro piuttosto voluminosi, si allacciavano dietro con dei bottoni. Chi mai comperasse quella roba orrenda, non riesco proprio a immaginarlo. Forse la regalavano a qualche ospizio: io di certo non ho mai portato a casa niente.
Ma la cosa piú bella dell’andare a scuola a quei tempi era che si doveva imparare. Per me non c’era niente di piú bello: imparare a leggere, a scrivere e a far di conto. Le tre cose indispensabili a chiunque debba lavorare per vivere. Allora ci costringevano a imparare, e secondo me è giusto che i bambini siano obbligati a farlo. Io non credo a quel che dicono adesso: «Se non vogliono imparare, forzarli non serve a niente». Altroché se serve. La nostra maestra girava tra i banchi, e se ti beccava a perdere tempo ti mollava un bello scappellotto sul collo o un ceffone sulle orecchie. Alla fine della scuola ci avevi guadagnato di sicuro. Sapevamo quel che bastava per cavarsela nella vita. Non che pensassimo a cosa ci sarebbe piaciuto fare da grandi. Tutti sapevamo che bisognava trovarsi un mestiere, ma non credo che avessimo particolari ambizioni.
A sette anni compiuti ho capito, in un certo senso, qual era il mio posto nel mondo. Mia madre usciva di casa prestissimo per andare a fare le pulizie: io ero la figlia maggiore, quindi toccava a me dare la colazione ai piccoli. Intendiamoci, non c’era bisogno di cucinare niente. Mai che ci fossero uova e pancetta, e i cereali erano roba inaudita. D’inverno mangiavamo il porridge, d’estate pane e margarina con un’ombra di marmellata, se per caso ce n’era. Potevamo mangiarne tre fette, non di piú. E poi preparavo il tè, un tè leggerissimo fatto con quella polvere che si chiamava «scopatura» – la meno cara che c’era – e dopo sparecchiavo, lavavo le tazze e mi preparavo per andare a scuola.
I due piú piccoli me li portavo dietro e li lasciavo all’asilo infantile. Costava sei pence al giorno, e per quella cifra ti davano anche il pranzo. Li accompagnavo prima di entrare a scuola e passavo a prenderli al pomeriggio, appena uscita. A mezzogiorno correvo a casa, mettevo a cuocere le patate e la verdura, apparecchiavo la tavola e facevo quel che ero capace di fare, cosí quando mia madre arrivava di corsa dal lavoro doveva soltanto servire in tavola.
Mangiavamo quasi sempre stufato, perché era la cosa che riempiva di piú. A volte la mamma preparava il pasticcio di carne. A ripensarci adesso, è una faccenda buffa, questa del pasticcio di carne. Andavo dal macellaio e compravo sei pence di ritagli. Allora non ci si preoccupava tanto dell’igiene come oggi: fuori dalle macellerie c’erano grossi tavolacci di legno sui quali erano esposti i vari tagli, a beneficio dei clienti e delle mosche. Il macellaio affettava la carne e gettava via i pezzettini che avanzavano. «Pizzi del tagliere», si chiamavano. Con sei pence di ritagli e un penny di sugna mia madre faceva certi pasticci di carne che neanche v’immaginate. Ma appena finito di pranzare doveva correre subito al lavoro, perché aveva solo mezz’ora di pausa. E quindi i piatti li lavavo io, e dopo tornavo a scuola. Al pomeriggio andavo a prendere i due piccoli all’asilo e li portavo a casa, poi cominciavo a fare le pulizie e rassettavo i letti. Non mi è mai passato per la mente che fosse un’ingiustizia. Era cosí e basta. Era quel che ci si aspettava da te, se eri la figlia maggiore in una famiglia di lavoratori. Certo, alla sera era la mamma a occuparsi di tutto. Tornava alle sei e preparava la cena, che era uguale alla colazione: pane e margarina.
Diversamente da molte persone che ho conosciuto, a scuola non ho mai fatto grandi amicizie. Però avevo la mia famiglia, quindi la cosa non mi preoccupava; e poi, insomma, la città era tutta per noi.
![]()
Hove era un posto bellissimo, specialmente per i bambini, in particolare per quelli senza soldi. Non c’erano tante case, all’epoca. C’erano tutti quei prati liberi; solo erba e una tettoia, e intorno ai prati c’erano arbusti meravigliosi per giocare a nascondino. Laggiú si poteva andare a far merenda, apparecchiare sull’erba pulita. Nessun custode del parco veniva a tormentarti.
E alle spalle della città c’era subito la campagna. Non avevamo che da camminare pochi minuti ed ecco la campagna e le fattorie. I contadini erano molto cordiali; ti lasciavano andare in giro, affacciarti sul porcile, grattare la schiena ai maiali, fare il verso ai polli, guardare la mungitura delle vacche. Spesso la moglie del contadino usciva a portarci un bicchiere di limonata. C’erano alberi su cui arrampicarsi, alberi fantastici che parevano stare lí apposta per i bambini.
Giú in spiaggia c’erano i teatrini sul mare, gli spettacoli di Pierrot. Con una moneta da sei pence o uno scellino ci si poteva sedere su una sdraio a guardarli, ma inutile dire che noi non avevamo mai tutti quei soldi. Perciò stavamo dietro, in piedi. Arrivava un soprano e cantava una canzone appassionata sul perduto amore, sul suo innamorato che se n’era andato per via di un equivoco e lei sperava con tutto il cuore che sarebbero tornati insieme. Metà del pubblico era in lacrime, e anche noi bambini giú al fondo. All’epoca la gente ci credeva, in quella roba: morire per amore e sentirsi traboccare di passione, il rimpianto, le occasioni perdute e via di seguito. Nessuno aveva quell’atteggiamento alla «non mi fa un baffo». Poi c’era il baritono, che cantava canzoni sull’amicizia, l’Inghilterra e la marcia Hands Across the Sea.
Oggi quella roba sarebbe considerata estremamente banale, ma per noi, e per tutto il pubblico, era meravigliosa.
Poi c’erano gli asini, e l’asinaio che se ne occupava. Ho sentito dire che chi passa molto tempo con gli animali finisce per assomigliargli, nell’aspetto e nelle abitudini, e l’asinaio somigliava alle bestie che custodiva. Era vecchio, piccolo, curvo, grigio e pelosissimo. Non è che avesse proprio la barba; sembrava che i peli gli spuntassero da tutto il corpo. Un sacco di volte mi capitava di pensare: se si mettesse a quattro zampe uno potrebbe montargli in groppa senza neanche accorgersi che non è un asino.
Quanto erano disgraziati quei poveri asinelli! Probabilmente avevano da mangiare a sufficienza, ma gli asini hanno sempre un’aria tanto patetica se non sono ben curati, e non credo che quelli lo fossero. Però i bambini ricchi non dovevano mai sedersi sulla groppa di un asino come i bambini comuni. Certo che no! C’era il rischio di qualche infezione. Loro sedevano in un calessino tutto foderato di pelle rossa, a due posti. Quei bambini con le tate al seguito arrivavano in pompa magna, su grandi carrozzini.
Il padrone del calessino doveva accompagnarli camminando da una parte, e anche la tata camminava dall’altro lato, perché a quei tesorucci non doveva accadere nulla. Invece non importava a nessuno che a noi venissero le piaghe sul sedere, ballonzolando sul dorso di quei vecchi asini.
Ai figli dei ricchi non era mai permesso giocare con bambini di basso ceto come noi: potevano giocare soltanto con quelli ricchi quanto loro. Non andavano mai in nessun posto da soli, senza tata. Certi ne avevano due, la bambinaia e la vicebambinaia. Tutti avevano libero accesso ai prati e non potevano tenerci a distanza, ma se uno di quei marmocchi si avventurava verso di noi, la bambinaia interveniva: «Vieni via! Immediatamente! Torna qui». Non lasciavano mai che ci rivolgessero la parola.
Noi, comunque, provavamo per loro una sorta di disprezzo. Non potevano fare le cose che facevamo noi, non avevano il permesso di sporcarsi i vestiti, di correre dentro e fuori dai cespugli, di arrampicarsi sulle panchine e camminare in equilibrio sul bordo sottile. Non potevano fare niente di emozionante. Non era colpa loro.
Sicché non legavamo mai, proprio mai. Loro giocavano soavemente con grandi palloni colorati, spingevano le carrozzine delle bambole e andavano in monopattino. Noi non avevamo niente, a parte forse una vecchia palla da tennis, ma pur senza avere assolutamente nulla riuscivamo a fare i giochi piú meravigliosi. Anche se abitavamo vicino al mare, giocavamo perlopiú in strada. Era fantastico perché non c’era soltanto il marciapiede a nostra disposizione, ma anche la via. Non c’era molto traffico, allora. A Pasqua, per esempio, si saltava la corda, poi si giocava ai bottoni oppure a campana; ma tutti quanti impazzivamo per le biglie. A forza di calci si faceva un buco per terra a circa due metri dal canale di scolo (all’epoca si poteva fare); l’idea era mandare le biglie nel buco. Poi c’erano i cerchi: mia zia mi aveva comprato il cerchio piú grande che si potesse trovare. Aveva una guida di ferro per agganciarlo, e con quello correvo per tutte le strade. Il traffico non era mai un problema. Oggi, un bambino che volesse farlo non durerebbe molto.
Forse, se avessimo potuto socializzare con i figli dei ricchi, avremmo fatto amicizia; ma non credo, perché loro crescevano con l’idea radicata di appartenere a una classe di persone completamente diversa da noi.
Per esempio, ricordo che una volta giocavo su un prato e avevo un cappotto che era appartenuto a mia nonna. Era di un tessuto felpato. Arrivò una bimba ricca e si mise a fare commenti sul mio cappotto, e la tata le disse: – Oh, non bisogna dire queste cose, cara; in fondo sono bambini poveri. La loro mamma non ha soldi –. E la bambina: – Ah, ah, ma non è buffa? Chissà se la mia mamma ha qualche vestito da darle –. Mi fece infuriare, perché prima non avevo badato al mio cappotto. Non pensavo che ci fosse qualcosa di male a indossarlo solo perché era stato di mia nonna. Quell’episodio mi rimase impresso, però superai presto il risentimento: c’era sempre qualche cosa da fare o da pregustare, come la visita annuale al circo.
![]()
Il circo di Lord George Sanger era il migliore di tutti. In realtà credo che il suo vero nome fosse George Lord, e che avesse invertito nome e cognome per darsi un tono, ma a noi piaceva credere che fosse un nobile vero. Non sempre avevamo i soldi per il biglietto, ma facevamo di tutto per non perderci lo spettacolo. In mancanza di meglio si poteva comunque fare un giro tra i carrozzoni e andare a vedere gli animali: gli elefanti, i leoni, le tigri. Quello era gratis.
Un anno misero in cartellone un numero speciale: un tale veniva sparato da un cannone, attraversava tutto il tendone del circo e atterrava su una rete. Ogni sera si sentiva il boato del cannone, un’esplosione tremenda. A quel punto eravamo ancora piú smaniosi di andarci, ma era uno dei periodi in cui papà era senza lavoro. I soldi per il biglietto non li aveva proprio. Per i bambini l’ingresso costava sei pence, e potevi sederti nei posti in fondo. Cosí decidemmo di darci da fare per trovare i soldi.
Bussavamo a tutte le porte e chiedevamo alle persone se avevano vecchi barattoli per la marmellata che non servivano piú, li prendevamo e li portavamo dal rigattiere. Per sei barattoli ti davano, credo, un penny. Poi andammo a raccogliere letame. Ci davano tre pence per ogni carriola. Era facile, perché c’erano i carri del comune. Passavano ogni giorno a innaffiare le strade con una specie di spruzzatore che stava sul retro. Siccome la nostra casa era alla fine del suo percorso, il carrettiere scendeva e se ne andava al caffè. Non so se fosse per la stanchezza o perché il giro era finito, fatto sta che ogni volta i cavalli scodellavano un bel po’ di letame. Prima di entrare nel caffè il carrettiere gli attaccava le borse del fieno, e un attimo dopo arrivavano stormi di piccioni a beccare quel che cadeva dai sacchi. Mentre noi giravamo attorno alle zampe per raccogliere il letame, i piccioni volavano intorno ai cavalli e li spaventavano. Come siamo riusciti a non farci accoppare da un calcio, proprio non lo so. A volte seguivamo anche i carri dei traslochi, aspettando che si fermassero e che i cavalli offrissero il loro contributo. In sostanza, non ci voleva granché a fare una carriolata di letame.
Dopo parecchi giorni di vendita barattoli e raccolta letame, avevamo raggranellato la mezza corona che serviva a comprare i cinque biglietti da sei pence.
Venne il gran giorno. Tutto ci sembrava una favola. Una ragazza in calzamaglia luccicante si presentò sulla pista con quattro o cinque elefanti. Si fece sollevare in aria dalle loro proboscidi, si sdraiò a terra mentre quei bestioni la scavalcavano. Poi entrarono i leoni, ruggendo come è giusto che facciano. A un certo punto il domatore mise la testa dentro le fauci di uno di loro. Io non riuscivo a guardare. E neanche i trapezisti riuscii a guardarli.
Ma per noi il clou della serata era l’uomo cannone. La sera prima avevamo sentito la mamma raccontare a papà che, quando era andato in America a fare il suo numero, l’uomo cannone era atterrato malamente nella rete e si era spezzato il collo. I bambini, si sa, sono spietati, perciò a noi non sembrava affatto una tragedia. Pensate se fosse successo davanti ai nostri occhi. In fondo faceva quel numero da parecchie sere, era ora che avesse un infortunio.
L’uomo cannone arrivò per ultimo. Lo guardammo infilarsi dentro la boc...