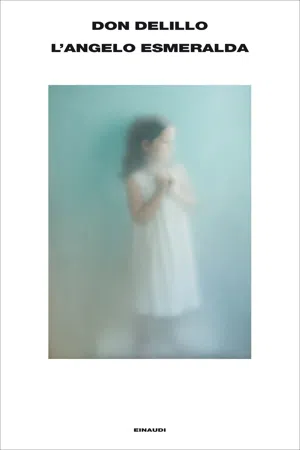![]()
![]()
Sapeva che c’era qualcun altro nella sala. Non era un vero e proprio rumore, solo un vago indizio alle sue spalle, un lieve spostamento d’aria. Era sola da un po’, seduta su una panchina nel bel mezzo della galleria, circondata dai quadri, un ciclo di quindici tele, ed ecco la sua sensazione: le pareva di star seduta in una cappella mortuaria, a vegliare la salma di un parente o di un amico.
Vegliare la salma, si diceva cosí.
Guardava Ulrike, la testa e il busto, il collo con i segni di corda, anche se non sapeva che cosa esattamente fosse stato utilizzato per l’impiccagione.
Sentí l’altra persona che andava verso la panchina, un uomo dal passo pesante e strascicato, e lei si alzò e andò davanti all’immagine di Ulrike, una di tre immagini correlate dove Ulrike appariva morta, distesa per terra nella sua cella, con la testa di profilo. Le tele erano di varie dimensioni. La realtà della donna, la testa, il collo, il segno della corda, i capelli, i tratti del viso, erano stati dipinti, quadro dopo quadro, in varie sfumature di oscurità e vaghezza, con qualche dettaglio piú chiaro, ogni tanto, la bocca in un dipinto era sfocata mentre in un altro appariva quasi naturale, e niente di tutto questo era sistematico.
– Secondo te perché l’ha fatta in questo modo?
Lei non si girò a guardarlo.
– Cosí in ombra. Senza colore.
Lei rispose: – Non lo so, – e passò alla serie successiva di immagini, intitolata Erschossener. Era Andreas Baader. Per lei era nome cognome o anche solo il cognome. Se pensava a Meinhof, la vedeva col suo nome proprio, Ulrike, e lo stesso valeva per Gudrun.
– Sto cercando di capire cosa gli è successo.
– Si sono suicidati. Oppure li ha uccisi lo stato.
Lui disse: – Lo stato –. Poi lo ripeté, con voce profonda, con tono di melodrammatica minaccia, provando a recitare quella battuta in un modo piú consono.
Lei avrebbe voluto esserne infastidita, ma quello che avvertiva era solo un vago disappunto. Lei non era tipo da usare quelle espressioni – lo stato – nell’inflessibile contesto del supremo potere pubblico. Quello non era il suo lessico.
I due dipinti di Baader morto in cella erano della stessa grandezza, ma affrontavano l’argomento in maniera alquanto diversa; a un certo punto ecco cosa fece, si concentrò sulle differenze: braccio, camicia, oggetto sconosciuto quasi a ridosso della cornice, la disparità o l’incertezza.
– Non so cosa sia successo, – disse lei. – Sto solo ripetendo le cose a cui crede la gente. Sono passati venticinque anni. Io non posso sapere com’era all’epoca, in Germania, con le bombe e i rapimenti.
– È stato fatto un accordo, non credi?
– Alcune persone sono convinte che siano stati uccisi in cella.
– Un patto. Erano terroristi, no? Se non ammazzano altra gente, si ammazzano da soli, – disse lui.
Lei guardava Andreas Baader, prima un quadro, poi l’altro, poi di nuovo il primo.
– Non so. Forse in un certo senso è anche peggio. È una cosa molto piú triste. C’è tanta tristezza in queste immagini.
– C’è una che sorride, – disse lui.
Si trattava di Gudrun, in Gegenüberstellung 2.
– Non so se è un sorriso. Potrebbe essere un sorriso.
– È l’immagine piú nitida in tutta la sala. Se non in tutto il museo. Sta sorridendo, – disse lui.
Lei si voltò a guardare Gudrun dall’altra parte della galleria e vide l’uomo sulla panchina, mezzo girato verso di lei, indossava un completo con la cravatta slacciata, aveva una calvizie prematura. Riuscí solo a intravederlo. Lui la guardava, ma lei guardava piú in là, la sagoma di Gudrun con addosso una divisa carceraria, in piedi contro un muro, e con molta probabilità stava sorridendo, sí: nell’immagine di mezzo. Tre dipinti di Gudrun, che forse sorrideva, sorrideva e probabilmente non sorrideva.
– Bisogna essere allenati per poter guardare questi quadri. Io non riesco a distinguere le persone.
– Sí che ce la fai. Basta guardare. Bisogna guardare.
Lei sentí una nota di leggero rimprovero nella sua stessa voce. Andò alla parete di fondo per osservare il dipinto di una delle celle della prigione, con alti scaffali che coprivano quasi la metà della tela e una sagoma scura, spettrale, che poteva anche essere un cappotto appeso a un attaccapanni.
– Stai facendo un dottorato. Oppure insegni arte, – disse lui. – Io, sinceramente, sono qui tanto per passare il tempo. Vengo fra un colloquio di lavoro e l’altro.
Lei non voleva dirgli che andava lí da tre giorni di fila. Si spostò verso la parete adiacente, avvicinandosi di poco alla panchina dov’era seduto lui. E glielo disse.
– Un sacco di soldi, allora, – ribatté lui. – A meno che tu non abbia l’abbonamento.
– Non ho l’abbonamento.
– Allora sei tu che insegni arte.
– Non insegno arte.
– Tu vuoi che io stia zitto. Sta’ un po’ zitto, Bob. Solo che non mi chiamo Bob.
Guardando il quadro delle bare trasportate in mezzo a una grande folla, inizialmente lei non si era accorta che si trattasse di bare. Ci mise diverso tempo a distinguere la folla stessa. C’era la folla, perlopiú una cinerea macchia indistinta con alcune figure sulla destra, in primo piano, si capiva che erano persone che stavano in piedi con le spalle all’osservatore, e poi c’era un’interruzione verso la parte superiore della tela, una striscia chiara di terra o una strada, e poi un’altra massa di persone o di alberi; le ci volle un po’ di tempo per capire che i tre oggetti biancastri in prossimità del centro dell’immagine erano bare che venivano trasportate in mezzo alla folla o che forse erano semplicemente appoggiate su dei catafalchi.
Ecco i corpi di Andreas Baader, Gudrun Ensslin e un uomo il cui nome non riusciva a ricordare. Gli avevano sparato in cella. Baader era morto allo stesso modo. Gudrun era stata impiccata.
Sapeva che questo episodio si era verificato circa un anno e mezzo dopo la vicenda di Ulrike. Ulrike era morta a maggio del 1976, questo lo sapeva.
Due uomini entrarono nella galleria, seguiti da una donna con un bastone. Tutti e tre si fermarono davanti al pannello con il materiale esplicativo, per leggere.
Il dipinto delle bare aveva qualcos’altro di sfuggente. Un particolare che lei aveva notato solo il secondo giorno – quello era il terzo giorno che andava al museo – e una volta visto succedeva qualcosa di sorprendente, non potevi fare a meno di vederlo: era un qualcosa nella parte superiore del dipinto, leggermente sulla sinistra rispetto al centro, un albero forse, nella forma grezza di una croce.
Si avvicinò al quadro e sentí la donna con il bastone che camminava verso la parete opposta.
Sapeva che quei dipinti prendevano spunto da fotografie, ma le fotografie in questione lei non le aveva viste e quindi non sapeva se in una delle foto si vedesse fuori dal cimitero un albero spoglio, un albero morto che consisteva di un tronco esile con un solo ramo, o due rami che formano un pezzo trasversale vicino alla parte superiore del tronco.
Nel frattempo lui, l’uomo con cui stava parlando, le si era avvicinato.
– Dimmi cosa vedi. Sul serio, ci tengo a saperlo.
Entrò un gruppo di persone, capitanato da una guida; lei si voltò un momento e li vide che si radunavano davanti al primo quadro del ciclo, il ritratto di Ulrike da giovanissima, praticamente una ragazzina, con un’espressione lontana e malinconica, la mano e la faccia che quasi galleggiavano nella tetra oscurità che la circondava.
– Capisco ora che il primo giorno io guardavo solo per modo di dire. Credevo di guardare, ma avevo solo una vaghissima idea di ciò che c’è in questi dipinti. Sto cominciando solo ora a guardare.
E rimasero a guardare, insieme, le bare, gli alberi, la folla. La guida cominciò a dire qualcosa al gruppo che accompagnava.
– E cosa provi quando guardi? – le chiese.
– Non lo so. È complicato.
– Perché io non provo niente.
– Penso che mi sento indifesa. Questi dipinti mi fanno sentire indifesa come non mai.
– È per questo che sei venuta qui tre giorni di fila? Per sentirti indifesa? – le chiese.
– Sono qui perché amo questi quadri. Sempre di piú. All’inizio ero confusa, e un pochino lo sono ancora. Ma adesso so che queste tele io le amo.
Era una croce. Per lei era una croce e questo le dava l’impressione, giusta o sbagliata che fosse, che c’era un elemento di perdono nell’immagine, che i due uomini e la donna, i terroristi, e Ulrike prima di loro, terrorista, non erano indegni di perdono.
Ma non indicò la croce all’uomo che stava lí accanto a lei. Non le andava di affrontare una discussione su quell’argomento. Non pensava che quella croce se la stesse solo immaginando, non pensava di vedere una croce in qualche colpo di pennello, e non le andava di sentire qualcuno sollevare dubbi elementari in merito.
Andarono in uno snack-bar e si accomodarono su sgabelli disposti davanti a uno stretto bancone lungo quanto la vetrina del locale. Guardò la folla sulla Settima Avenue, mezzo mondo che correva, e le parve di non avvertire il sapore di quello che mangiava.
– Mi sono perso il boom del primo giorno, – disse, – quando i titoli salgono in modo vertiginoso, tipo del quattrocento percento nel giro di un paio d’ore. Sono arrivato per il mercato finanziario secondario, che si è rivelato essere debole, e poi sempre piú debole.
Quando non ci furono piú sgabelli dove sedersi la gente si mise a mangiare in piedi. Lei aveva voglia di tornare a casa e controllare i messaggi in segreteria.
– Ora fisso appuntamenti. Mi faccio la barba, sorrido. La mia vita è un inferno, – disse senza enfasi, continuando a masticare.
Quell’uomo occupava uno spazio notevole, aveva qualcosa di fiacco, di sbrigativo e dinoccolato. Una persona si allungò sopra di lei per afferrare una salviettina dal distributore. Non sapeva nemmeno lei cosa ci faceva lí a parlare con quell’uomo.
Lui disse: – Nessun colore. Nessun significato.
– Quello che hanno fatto loro un senso ce l’aveva. Era sbagliato, ma non era cieco e vuoto. Penso che il pittore abbia cercato di rendere quest’idea. E perché è finita come è finita? Credo che il pittore se lo sia chiesto. Tutti morti.
– Come poteva finire altrimenti? Dimmi la verità, – disse lui. – Insegni arte ai bambini handicappati.
Non sapeva se la cosa fosse interessante o crudele, ma si vide nel vetro della finestra con un sorriso a denti stretti.
– Non insegno arte.
– Anche se siamo in un fast food io sto cercando di mangiare lentamente. Il prossimo appuntamento è soltanto alle tre e mezza. Mangia lentamente. E dimmi cosa insegni.
– Io non insegno.
Non gli disse che anche lei era senza lavoro. Si era stancata di descrivere le sue mansioni amministrative presso un editore scolastico, quindi pensò che tanto valeva non fare quello sforzo ora che il lavoro e la compagnia non esistevano piú.
– Il fatto è che mangiare lentamente è contro la mia natura. Se non sto attento me lo scordo. Solo che non riesco comunque ad adattarmi.
Ma non era quello il motivo. Non gli disse che non aveva un lavoro, perché li avrebbe accomunati. E non voleva questa cosa, l’inflessione di una comprensione reciproca, una forma di cameratismo. Meglio che il tono rimanesse scollegato.
Lei beveva il succo di mela e guardava la gente che passava, volti che per mezzo secondo apparivano del tutto conoscibili e ancor piú velocemente venivano dimenticati per sempre.
Lui disse: – Saremmo dovuti andare in un vero ristorante. Qui non si riesce a parlare. Tu non sei a tuo agio.
– No, non c’è problema. Solo che ora dovrei proprio andare.
L’uomo sembrò riflettere su questa cosa, poi la mise da parte, per nulla scoraggiato. Lei pensò di andare al bagno e poi decise di no. Pensò alla camicia del morto, la camicia di Andreas Baader, piú sporca o piú insanguinata in uno dei due quadri.
– E ne hai uno alle tre, – gli disse.
– Tre e mezza. Ma ci manca ancora tanto tempo. È un altro mondo, quello dove mi sistemo la cravatta, entro in una stanza e dico chi sono –. Fece una breve pausa, poi la guardò. – A questo punto tu dovresti dire: «Ma tu chi sei?»
Lei si vide sorridere. Non disse nulla. Pensò che forse il segno di corda di Ulrike non era affatto un segno, ma la corda stessa, se si trattava di una corda e non di un filo, una cintura o qualcos’altro.
Lui disse: – Questa è la tua battuta. «Ma tu chi sei?» Te l’ho servita su un piatto d’argento e tu non te ne sei nemmeno accorta.
Avevano finito di mangiare, ma i bicchieri di carta non erano ancora del tutto vuoti. Parlavano di affitti e locazioni, delle varie zone della città. Lei non voleva dirgli dove abitava. Abitava a soli tre isolati da lí, in un edificio di mattoni sbiaditi i cui limiti e malfunzionamenti ormai era giunta a comprendere come la tessitura della sua vita, la trama di fondo da cui si stagliavano i normali problemi di ogni giorno.
Ma alla fine glielo disse. Stavano parlando di posti dove poter fare jogging o andare in bicicletta, e lui le disse dove abitava e dove andava a correre, e lei gli disse che le avevano rubato la bici che teneva in cantina, e quando lui le chiese dove viveva lei rispose, piú o meno con disinvoltura, e lui bevve un sorso della sua bevanda gassata dietetica e guardò fuori dalla finestra,...