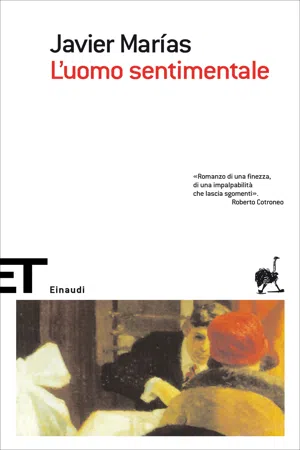![]()
Javier Marías
L’uomo sentimentale
Traduzione di Glauco Felici
Einaudi
![]()
A Daniella Pittarello,
che magari1 continuerà a esistere
![]()
![]()
«Non so se raccontarvi i miei sogni. Sono sogni vecchi, passati di moda, piú adatti a un adolescente che a un uomo fatto. Sono pieni di dettagli e allo stesso tempo precisi, piuttosto lenti anche se molto colorati, come quelli che potrebbe fare un animo fantasioso ma in fondo semplice, un animo molto ordinato. Sono sogni che finiscono per stancare un po’, perché chi li sogna si sveglia sempre prima della loro conclusione, come se l’impulso onirico si esaurisse nella rappresentazione dei particolari e si disinteressasse del risultato, come se l’attività di sognare fosse l’unica ancora ideale e senza scopo. Non conosco, perciò, la fine dei miei sogni, e può risultare avventato riferirli senza essere in grado di proporre una soluzione né un insegnamento. Ma a me sembrano inventivi e molto intensi. La sola cosa che posso aggiungere a mia discolpa è che scrivo in base alla forma di durata – quel luogo della mia eternità – che mi ha scelto.
Tuttavia, quel che ho sognato questa mattina, quando ormai era giorno, è qualcosa che è accaduto realmente e che accadde a me quando ero un po’ piú giovane, o meno anziano di adesso, anche se non è ancora finito.
Quattro anni fa viaggiai, a causa del mio lavoro e proprio prima di superare miracolosamente la paura dell’aereo (sono un cantante), numerosissime volte in treno durante un periodo di tempo abbastanza esiguo, in totale circa sei settimane. Quegli spostamenti brevi e continui mi portarono nella parte occidentale del nostro continente, e fu nel penultimo della serie (da Edimburgo a Londra, da Londra a Parigi e da Parigi a Madrid in un giorno e una notte) che vidi per la prima volta i tre volti sognati questa mattina, che sono peraltro gli stessi che hanno occupato parte della mia fantasia, molto del mio ricordo e la mia vita intera (rispettivamente) da allora fino a oggi, o per quattro anni.
La verità è che impiegai molto prima di guardarli, come se qualcosa mi mettesse sull’avviso o io, senza saperlo, volessi ritardare il rischio o la gioia che avrebbe comportato il farlo (ma temo che questa idea appartenga piú al mio sogno che alla realtà di allora). Mi ero dedicato a leggere un libro di fatue memorie d’uno scrittore austriaco, ma a un determinato momento, e dato che mi irritava molto (a dire il vero all’alba m’aveva fatto uscire dai gangheri), lo chiusi e, contrariamente a quella che è mia abitudine quando viaggio in treno e dato che non stavo conversando, leggendo, ripassando il mio repertorio né richiamando alla mente fallimenti o successi, non guardai “direttamente” il paesaggio, ma i miei compagni di scompartimento. La donna dormiva, gli uomini erano svegli.
Il primo uomo, lui sí, guardava il paesaggio, seduto proprio di fronte a me, con la voluminosa chioma di capelli canuti e increspati rivolta verso la sua destra e con una mano singolarmente piccola – tanto che non sembrava potesse appartenere a un corpo davvero umano – che accarezzava la guancia con lentezza. Potevo vederne le fattezze soltanto di profilo, ma nell’essenziale ambiguità della sua età – uno di quei fisici un po’ féeriques che danno l’impressione di voler contrastare piú del dovuto le pressioni del tempo, come se la minaccia di una morte vicina e la speranza di rimanere fissati per sempre in un’immagine incolume li compensasse dello sforzo – appariva come piú che maturo in virtú di quell’abbondante vegetazione brinata che lo coronava e di due fenditure – incisioni legnose in una pelle liscia – che, da entrambi i lati della bocca sfumata e in linea di principio inespressiva, facevano pensare, tuttavia, a una personalità incline a sorridere nel corso dei lustri sia quando era opportuno sia quando non lo era. In quel momento dei suoi anni indefinibili lo si indovinava tranquillo e lo si vedeva insignificante e danaroso, con dei pantaloni eleganti ma un po’ logori e leggermente corti – gli stinchi quasi allo scoperto – e una giacca sgargiante la cui stoffa mescolava troppi colori. Un uomo al quale la ricchezza doveva essere arrivata tardi, pensai; forse un uomo della media impresa, indipendente ma che ha faticato per avere quel che ha. Mancandomi il suo sguardo, che concentrava all’esterno, non avrei saputo dire se si trattava di un individuo vivace o spento (anche se era molto profumato, rivelando una vanità sfiorita ma ancora indomita). In ogni caso, guardava con straordinaria attenzione, si sarebbe detto con loquacità, come se stesse assistendo all’istantanea realizzazione di un disegno o come se ciò che si offriva ai suoi occhi fosse acqua o anche fuoco, dai quali è tanto faticoso a volte distogliere lo sguardo. Ma il paesaggio non è mai drammatico, come lo è la realizzazione di un disegno o l’acqua mobile o il fuoco vacillante, e questa è la ragione per cui osservarlo fa riposare gli affaticati e annoia coloro che non si stancano. Io, malgrado il mio aspetto robusto e una salute di cui non posso lamentarmi considerato che la mia professione la esige di vero ferro, mi stanco moltissimo, ragion per cui scelsi di guardare il paesaggio a mia volta, “indirettamente” e attraverso gli occhi invisibili dell’uomo dalle mani piccole, dai pantaloni eleganti e dalla giacca audace. Ma poiché ormai stava calando il buio non vidi quasi nulla – soltanto bassorilievi –, e pensai che forse quell’uomo stava guardando se stesso nel vetro. Almeno io, nel giro di alcuni minuti, quando alla fine si verificò il delicato cedimento della luce dopo il minimo fulgore vacillante di un tramonto ancora settentrionale, lo vidi duplicato, sdoppiato, ripetuto, quasi con identica nitidezza nel vetro del finestrino come nella realtà. Indubbiamente, decisi, quell’uomo scrutava i propri tratti, guardava se stesso.
Il secondo uomo, seduto in diagonale rispetto a me, manteneva lo sguardo immobile di fronte a sé. Era una di quelle teste che solo a guardarle suscitano inquietudine nell’animo di chi ha ancora davanti a sé un sentiero tutto da aprire, o, per dirla in altri termini, di chi dipende ancora dal proprio sforzo. La calvizie che doveva essere stata prematura non era riuscita a indebolire la sua soddisfazione di sé e neppure la convinzione della sua sete di dominio, né aveva stemperato – tanto meno offuscato – l’espressione pungente di quegli occhi abituati a passare rapidamente attraverso le cose del mondo – abituati a essere carezzati dalle cose del mondo – e che erano del colore del cognac. La sua insicurezza si era concessa di pagare soltanto il tributo di un curatissimo paio di baffi neri che nascondesse le sue fattezze plebee e mascherasse un po’ l’incipiente grassezza – che a occhi da lui sottomessi sarebbe potuta passare ancora per robustezza – della sua testa e del suo collo e del suo torace tendente alla convessità. Quell’uomo era un soverchiatore, un ambizioso, uno compíto, uno sfruttatore, e i suoi indumenti, soprattutto la giacca smagliante e la cravatta con l’anello scorrevole, sembravano provenire dal lato di là dell’oceano, o anzi da una ricercata concessione europea allo stile che si ritiene elegante oltremare. Poteva avere dieci anni piú di me, ma una vena convulsa immediatamente riconoscibile nell’abbozzo di sorriso che di tanto in tanto provavano in silenzio le sue rigonfie labbra – come chi cambia posizione o accavalla e disaccavalla le gambe – mi fece pensare che quel soggetto cosí prepotente doveva avere nella sua personalità un elemento infantile che, in unione al suo fisico tondeggiante, poteva far oscillare la reazione di quanti lo coglievano tra l’irrisione e il terrore, con alcune gocce di irrazionale compassione. Forse era proprio questo che gli era mancato nella vita: che i suoi desideri venissero intesi e soddisfatti senza che ci fosse bisogno di farli conoscere. Pur nella certezza di vederli realizzati, forse si sentiva in obbligo di ricorrere di volta in volta a inganni, minacce, imprecazioni, deliqui. Ma forse soltanto per divertirsi, forse per mettere periodicamente alla prova le sue doti di istrione e per non perdere flessibilità. Forse per soggiogare meglio, dal momento che so bene che non c’è sottomissione piú efficace né piú durevole di quella che si costruisce su ciò che è finto, o addirittura su ciò che non è mai esistito. Quest’uomo che nel mio sogno ho giudicato dall’inizio tanto pusillanime quanto tirannico non mi guardò – come neppure l’altro – una sola volta, almeno finché potevo accorgermene, cioè, mentre io guardavo lui. Quell’uomo di cui adesso so troppo guardava, come ho detto, impassibile di fronte a sé, come se nel sedile vuoto che di sicuro non vedeva fosse scritta la relazione dettagliata di un futuro a lui già noto e che si limitava a verificare.
Allo stesso modo in cui questo soggetto sfruttatore lasciava vedere per intero la sua figura e l’individuo un po’ féerique niente di piú che il profilo, la donna seduta tra loro, insieme alla quale forse erano in viaggio o forse no, era priva di volto per il momento. Teneva la testa diritta, ma le coprivano il viso i capelli castani e lisci mandati deliberatamente in avanti, forse per proteggere dalla luce il leggero sonno ferroviario, forse anche per non offrire invano l’immagine di intimità e di abbandono che lei stessa non avrebbe riconosciuto, la sua immagine dormiente e senza vita. Teneva le gambe accavallate, e gli stivaletti invernali dal tacco bassissimo lasciavano vedere soltanto la parte superiore del polpaccio, che, prolungata in un ginocchio su cui il lieve lucido delle calze s’intensificava, concludeva al limitare di una gonna nera che mi sembrò di pelle scamosciata. Tutta la figura, escluso il volto, suscitava una sensazione di impeccabilità, di fermezza, di compimento e di adeguatezza, come se in lei non potessero piú esservi cambiamenti né correzione né negazione – come i giorni ormai conclusi, come le leggende, come la liturgia delle religioni irremovibili, come i quadri di secoli passati che nessuno oserebbe toccare. Le mani, appoggiate in grembo, riposavano a loro volta l’una sull’altra, la destra con il palmo aperto, la sinistra – perpendicolarmente abbandonata – con il pugno semichiuso. Ma il pollice di questa mano – lunghe dita, dita un po’ nodose, come di chi sente prima del tempo la tentazione di dire addio alla giovinezza – si muoveva intermittentemente con levità, come sono a volte i movimenti involontari e di carattere spasmodico di coloro che dormono senza volere. Portava un’anacronistica collana di perle; portava un nastro rosso attorno al collo; portava un doppio anello d’argento al medio. I capelli, che di certo aveva disposto in quel modo con un solo gesto del capo molte volte praticato, non consentivano neppure d’immaginare l’insieme dei suoi lineamenti sulla base di un solo tratto visibile, ricadevano tanto densamente come un velo opaco. Per questo osservai a lungo le mani. A parte il movimento del pollice, c’era un’altra cosa che attrasse la mia attenzione: non tanto le unghie – solide, bianchicce, curate – quanto la pelle che le circondava sembrava atrocemente morsa o bruciata, al punto che quella degli indici – infatti lo era soprattutto quella degli indici – si poteva dire che non esistesse e dubitare che fosse mai esistita. I contorni di quelle unghie avevano sofferto un’alterazione epidermica grave che vi aveva lasciato come traccia un colore arrossato e sgradevole, tipico di un’infiammazione, o erano di carne viva. Pensai che, se fosse stata vera la seconda ipotesi (dato che non riuscivo a distinguere bene), doveva essere opera non tanto degli incisivi non visti della donna che dormiva e della bambina che era stata quanto del tempo stesso, dato che l’atrofia – ed era di questo che sembrava trattarsi – ha bisogno non meno della mancanza d’uso e di attività, non meno della volontà di soppressione sistematica che della piú temporale delle cose che esistono e di quella che ugualmente meglio distrae tutte le cose dalla loro temporalità: l’abitudine (o la sua figlia sempre tardiva, la legge, che insieme è quella che annuncia che il tempo dell’abitudine sta ormai passando e la fine della distrazione). Stavo cominciando a divagare un po’ su quelle questioni di cui non capisco nulla né in realtà non so nulla, quando una forte scossa laterale del treno fece sí che all’improvviso quei capelli castani e luminosi e lisci mettessero momentaneamente allo scoperto il volto che custodivano. Quel volto non si svegliò, e passarono pochi secondi prima che tutto tornasse alla sua posizione, ma nelle labbra grandi e strette e tese, nelle palpebre strette e percorse da minuscole vene rossicce (negli occhi chiusi non visti), vidi che la donna che dormiva era, come dire?, afflitta. Forse vidi che era afflitta da dissoluzioni malinconiche.
![]()
– Io non voglio morire come un imbecille, – ho detto poco tempo dopo a quella donna in una camera d’albergo stretta e scura e di una sordidezza che allora non seppi cogliere, con le pareti spoglie e le coperte grigie o forse luttuose o semplicemente trascurate gettate sul pavimento dalla moquette pulita ma annerita e in cui non c’era neppure lo spazio per camminare, con due valigie disfatte a metà che occupavano lo spazio su cui si sarebbe potuto camminare fino a un bagno cosí vuoto e cosí bianco che due spazzolini da denti – rosso scuro e verde – messi in uno stesso bicchiere, il cui cellophane scomparve senza che sapessimo in quale momento né chi lo aveva fatto scomparire, attiravano la vista come la mano è attratta dal pugnale o il ferro dalla calamita, al punto che quando uno degli spazzolini mancò l’ultima notte che ho passato lí l’aspetto della maiolica e delle piastrelle e delle mattonelle si tinse del rosso scuro dello spazzolino che era rimasto, e quel colore finí per incorporare il nero del nécessaire che appoggiai sulla mensola di vetro affinché dopo quella partenza ci fosse qualche cambiamento o ci fosse del lutto in quel bagno cosí vuoto e cosí bianco e al quale si poteva arrivare a stento attraverso le valigie disfatte a metà e le coperte trascurate e gettate sul pavimento quando in una camera d’albergo dissi o ho detto poco tempo dopo a quella stessa donna: – Io non voglio morire come un imbecille, e dato che un giorno o l’altro dovrò morire irrimediabilmente, piú di tutto voglio curarmi nel mio tempo dell’unica cosa che è certa e irrimediabile, ma voglio soprattutto curare la forma della mia morte perché è la forma ciò che invece non è cosí certa e irrimediabile. È la forma della nostra morte ciò di cui dobbiamo curarci, e per curarcene dobbiamo curare la nostra vita, perché sarà questa, senza essere nulla in sé quando finirà e verrà sostituita, l’unica cosa che tuttavia sarà capace di farci sapere alla fine se moriamo come un imbecille o se moriamo in modo accettabile. Tu sei la mia vita e il mio amore e la mia vita di conoscenza, e poiché sei la mia vita non voglio avere al mio fianco nessun’altra persona se non te quando morirò. Ma non voglio che arrivi di corsa al mio letto di morte dopo aver saputo che sto agonizzando, né che partecipi al mio funerale per congedarti da me quando io non potrò piú vederti né potrò annusarti né potrò baciare il tuo viso, tanto meno che tu accetti o cerchi di accompagnarti a me nei miei ultimi anni perché tutt’e due siamo sopravvissuti alle nostre rispettive e compassionevoli o separate vite, perché non mi basta. Voglio invece che all’ora della mia morte quel che sarà lí presente sia l’incarnazione della mia vita, che non sarà altro che ciò che questa sia stato, e perché tu lo sia stata è necessario che sia stata al mio fianco anche da adesso e fino a quel mio momento definitivo. Non potrei sopportare che in quell’ora tu fossi soltanto ricordo e fossi mescolata, e appartenessi a un tempo lontano e confuso che è il nostro nitido tempo di adesso, perché è il ricordo e il tempo lontano e il rimescolamento quel che piú detesto e quel che sempre ho cercato di ridurre e negare, e sotterrare man mano che si andavano formando, nella misura in cui ogni presente stimato ed esaltato cessava di esserlo per essere passato, e veniva vinto da ciò che non so come chiamare se non lo chiamo la sua stessa e impaziente posterità o il suo non-adesso. Per questo non devi andartene adesso, perché se adesso te ne vai ti porterai via non soltanto la mia vita e il mio amore e la mia vita di conoscenza, ma anche la forma della mia morte scelta.
Ricordo ancora perfettamente come lei mi stava ad ascoltare distesa sul letto di una camera d’albergo: era scalza ma ancora vestita, appoggiata sui gomiti e con le gambe piegate; la gonna grigia un po’ sollevata lasciava vedere parte delle cosce, i capelli castani e luminosi e lisci mandati verso il lato opposto a quello dove mi trovavo; e il dolce sguardo ironico e grave cosí fisso sulle mie incessanti labbra da far sentire a me stesso che ero soltanto labbra e che le mie labbra erano le uniche responsabili e artefici di ciò che da esse usciva.
– E se muoio prima io?
– Tutto può essere, – risposi immediatamente. Ma credo di averlo fatto per nascondere o rinviare un po’ (l’ho fatto per guadagnare tempo) l’unica altra risposta comune e accettabile che arrivò subito dopo, quella che lei aspettava e parimenti avrebbe aspettato qualunque mortale che in quel momento fosse stato, come lei stava, disteso su quel letto: “Ma la tua morte sarà anche la mia”. – Ma la tua morte sarà anche la mia, – dissi a quella stessa donna, e cosí, allo stesso modo in cui succede nell’opera, gliel’ho ripetuto diverse volte nel mio sogno di questa mattina.
![]()
La mia professione mi costringe a condurre spesso una vita molto solitaria nelle grandi capitali del mondo, e Madrid, la città in cui trascorsi buona parte della mia infanzia e della mia adolescenza, non costituí un’eccezione quattro anni fa. Anzi, dopo che per molto tempo non vi ero piú passato, la città mi sembrò solitaria e triste come ne ho visto poche nei miei numerosissimi viaggi all’estero. Ancora piú delle città inglesi, che sono le peggiori del mondo, le piú malsane e le piú ostili; ancora piú di quelle della Germania dell’Est, nelle quali vi è tanta disciplina e tanta mortificazione che andarsene fischiettando per la strada produce l’effetto di un cataclisma; ancora piú di quelle svizzere, che se non altro sono pulite e quiete e lasciano possibilità aperte alla fantasia per il fatto stesso che non dicono niente.
Madrid, invece, sembra aver fretta di dire tutto, come se fosse cosciente che la sua sola possibilità di conquistare il viaggiatore consiste nello sbalordimento e nell’impetuosità sfrenata. Non si concede, perciò, nessuna aspettativa duratura, nessuna avvertenza né nessuna riserva, e con ciò non permette neppure al visitatore (per non parlare del residente eternamente perseguitato) la minima speranza immaginativa o immaginaria circa il fatto che possa esistere qualcosa di piú – occulto, non espresso, omesso o soltanto contingente – di quel che gli si offre impudicamente non appena muove qualche passo per le sue strade sporche e asfissiate. Madrid è rozza e sboccata e non ha mistero, e non c’è nulla di cosí triste e cosí solitario come una città senza enigma apparente o apparenza di enigma, nulla di cosí dissuasivo, nulla di cosí opprimente per il visitatore. Io, tanto nel mio sogno come quattro anni prima, ero un visitatore di questa città nonostante avessi vissuto in essa o nei suoi dintorni quando non ero che un bimbo e dipendevo interamente dal mio padrino, che mi accolse e mi fece trasferire lí da Barcelona alla morte di mia madre. (Io sono stato durante diversi lustri quel che si dice un parente povero: lo sono stato letteralmente, e fu in quell’epoca che risiedetti a Madrid. Viceversa, sebbene quattro anni fa era già da molto che avevo smesso di essere un parente povero e mi guadagnavo la vita comodamente, allora, in virtú della mia prolungatissima assenza e degli scarsissimi contatti intrattenuti con il mio vecchio benefattore dopo la mia emancipazione, ero un visitatore di Madrid quanto lo ero stato di Venezia e di Milano e di Edimburgo qualche settimana prima).
In tutte quelle città, come ho detto, mi portava e ancora continua a portarmi la mia professione, una delle piú tristi e solitarie che esistano nonostante ciò che la maggior parte delle persone – che ci vedono soltanto sul palcoscenico, sulle copertine dei dischi, nei manifesti o in qualche gala trasmesso per televisione: cioè, sempre truccati – crede di noi. Perché la verità è che essenzialmente non siamo molto diversi dai rappresentanti di commercio, con l’eccezione che quest’ultimo mestiere sta cessando di esistere, è in via di estinzione, senza dubbio perché i responsabili delle aziende, essendo in generale molto pragmatici e poco umanitari, si sono resi conto del fatto che nessuno può condurre una vita cosí dispersa e dura. Ho saputo di rappresentanti di commercio che sono finiti al manicomio, o hanno assassinato un cliente ai primi contatti, o si sono suicidati in un albergo di lusso ben sapendo che gli insoliti extra (piscina coperta, sauna, massaggi, hard drinks, ma soprattutto la tintoria) sarebbero stati inutilmente detratti da uno stipendio postumo che avevano ben badato a oltrepassare e che in ogni caso nessuno avrebbe percepito. Almeno morire con il vestito stirato.
Noi cantanti d’opera andiamo sempre in alberghi di lusso e gli extra non sono insoliti e non sono nemmeno extra, ma la norma e addirittura un’esigenza, eppure la nostra vita nella città in cui andiamo a lavorare non è molto diversa da quella di un rappresentante di commercio. In ogni albergo in cui ho preso alloggio – in ogni albergo in cui perciò c’era un cantante – c’era per lo meno un viaggiatore di commercio che, durante i giorni della mia permanenza, si tagliava le vene in una vasca da bagno piena di schiuma o accoltellava senza pietà un commesso dell’albergo, si spogliava velocemente nella hall o tirava su le gonne in ascensore alla moglie di qualche membro di qualche governo, dava fuoco a un tappeto o distruggeva a colpi di estintore gli specchi della sua camera di lusso. E sempre, prima o dopo quelle loro esplosioni, mi si è presentata una qualche modalità di identificazione con loro sulla base di questo o quel particolare, di questo o quel tratto, di un gesto di stanchezza cronica che ho sorpreso nel rappresentante quando ci siamo incrociati in ascensore a notte alta, con la cravatta storta e gli occhi mansueti; di uno sguardo condiviso e obliquo di pazienza o di sconfitta; del modo di lisciarci nascostamente i ca...