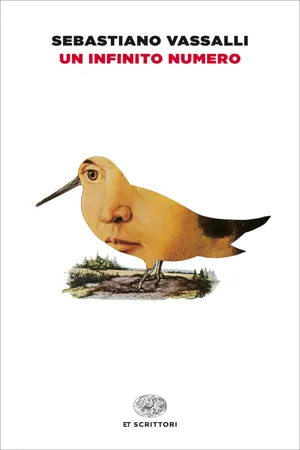![]()
![]()
Mi chiamo Timodemo e sono nato in Grecia, in una piccola città di nome Nauplia, a poche miglia da Argo. Nauplia è il nome di un borgo in riva al mare; e io, quando vado indietro con la memoria fino ai giorni della mia infanzia, rivedo una strada che scende verso una spiaggia piena di scogli, e un grappolo di case imbiancate a calce, con le porte e le finestre verniciate nei colori dell’arcobaleno: il rosso, il giallo, l’azzurro, il viola, il verde smeraldo… Anche le barche dei pescatori che ci sono giú al porto sono dipinte con gli stessi colori e, in piú, mostrano sulle fiancate immagini di draghi, di arpie, di divinità infernali o celesti. In quel posto c’è sempre il sole, e non piove mai. (Io, almeno, non ricordo di aver visto piovere). Ci sono molti bambini e molti cani che gironzolano da una casa all’altra e poi ritornano sul molo del porto, i bambini per giocare tra le reti e le barche tirate in secco, e i cani per disputarsi qualche carogna di gabbiano o per stendersi al sole. Ogni tanto si sentono delle grida e si vedono delle donne che corrono verso gli scogli, dove altre donne scarmigliate indicano un punto nell’acqua: «È lí! No, è lí!» Queste cose succedono quando cade in mare un bambino; ma, in genere, nel momento in cui le donne gridano non c’è piú niente da fare, perché il bambino, dopo avere annaspato per un tempo ragionevole, è andato sott’acqua. I bambini, a Nauplia, sono poco piú numerosi e poco meno randagi dei cani. L’unica differenza fra le due tribú, quella dei bambini e quella dei cani, è data dal fatto che i cani, di notte, dormono dove capita, mentre i bambini dormono dentro alle case. Quasi tutti (bambini e cani) hanno dei genitori. Io ho una madre, Pasitea, con due poppe grandi ciascuna come la mia testa, e i capelli neri tenuti sciolti che le arrivano fino in vita. Attorno a mia madre ci sono uomini sempre diversi che le portano roba da mangiare o vestiti, si sdraiano sul suo letto e qualche volta prendono in braccio anche me. (Fine del ricordo). Soltanto dopo qualche anno che sono andato via da Nauplia ho poi capito cosa faceva mia madre per vivere, e perché io non avevo un padre. Pasitea era una prostituta e gli uomini che venivano nella nostra casa erano marinai. Nauplia è il porto di Argo, una città importante e con molti traffici; e chissà, forse quelle case sopra il molo erano tutte abitate da prostitute. Forse i bambini con cui io giocavo erano i loro figli. Anche se non posso esserne sicuro, credo che l’ipotesi che ho appena fatto sia accettabile e, anzi, verosimile.
Con mia madre, ci sono rimasto finché ho incominciato a crescere e ad avere dei ricordi piú nitidi: diciamo, fino all’età di cinque anni. (Ma potrebbero anche essere stati sei). Un giorno che eravamo in casa noi due soli, Pasitea mi disse che non potevo continuare a vivere in mezzo alla strada, e che mi avrebbe mandato a scuola «come i figli dei ricchi». Mi promise: «Imparerai a leggere, a scrivere e ad andare a cavallo. Diventerai un giovane per bene, e poi un uomo rispettato e importante». In realtà, la maledetta mi aveva appena venduto a un allevatore di schiavi. La mattina del giorno successivo mi fece indossare il mio unico vestito decente e mi mise sul carro di un venditore di terraglie, che doveva accompagnarmi dal mio nuovo padrone. Io riuscii a piangere per tutta la durata del viaggio, cioè per tutto il giorno. Quando finalmente il mercante di terraglie mi disse di scendere dal suo carro, perché ero arrivato, mi guardai attorno attraverso le lacrime e vidi alcune casupole di pietra e alcune catapecchie di legno, riunite in un brutto villaggio sotto il cocuzzolo di una montagna. Seppi poi che quel posto, dove dovevo trascorrere il resto dell’infanzia e una parte della giovinezza, si chiamava Dorikranos (che significa, piú o meno, «sormontato da una punta»), e che perfino le cornacchie e gli avvoltoi lo evitavano. Soltanto i ratti, fra tutti gli animali selvatici che ci sono nel mondo, ci vivevano volontariamente, e soltanto le vipere si beavano al sole tra le pietraie della rupe che sovrastava il villaggio.
![]()
Qualche anno fa, quando sono ritornato in Grecia insieme a Virgilio, ho chiesto notizie di Dorikranos: c’era ancora? E che genere di schiavi ci venivano allevati? Ma non ho incontrato nemmeno una persona, fra le tante a cui ho rivolto quella domanda, che ci fosse stata o che ne avesse sentito parlare. Forse oggi Dorikranos non esiste piú. All’epoca della mia infanzia, invece, era un villaggio popolato da alcune decine di persone e da alcune centinaia di animali; ed era il regno di Musodoro. Tutti noi che vivevamo lassú, comprese le vipere della pietraia, eravamo i suoi sudditi. Musodoro era un uomo di mezza età, tarchiato, con una grande testa pelata e lucida, una gran barba che gli arrivava a metà del petto e un certo modo di camminare dondolandosi sui fianchi che lo rendeva riconoscibile anche da lontano e anche al buio. Pretendeva che tutti quelli che gli rivolgevano la parola lo chiamassero con il titolo di maestro, ma in realtà non sapeva leggere né scrivere e non era maestro di niente. Era un allevatore di animali, e specificamente di schiavi; ed era cosí orgoglioso di quell’attività, che gli dava un potere assoluto su uomini e bestie, da considerarsi molto piú che una persona normale. Come minimo: un maestro!
Ricordo che, in fatto di schiavi, Musodoro aveva idee molto chiare. Le femmine del suo allevamento, e anche i maschi di seconda scelta (cioè stupidi o deformi), dovevano essere venduti sul mercato locale, o ceduti ai contadini in cambio dei loro prodotti. I maschi di prima scelta, invece, venivano allevati per il mercato romano: che già a quell’epoca richiedeva molti schiavi greci e li pagava piú di quelli delle altre nazionalità, soprattutto se parlavano latino e se sapevano fare qualcosa. Un pantomimo o un medico greco, ci diceva Musodoro, a Roma e a Napoli potevano valere moltissimo («Quasi quanto un gladiatore!»); ma le quotazioni erano alte anche per gli artisti della ceramica e del bronzo e anche per i grammatici, che in Italia venivano impiegati come istitutori, come scrivani, come segretari di uomini importanti e come maestri nelle scuole pubbliche. Perciò, e anche perché l’educazione di un grammatico è meno costosa di quella di un artista del bronzo o di un medico, Musodoro allevava grammatici. Comperava i bambini dalle loro madri o da chi glieli portava, e poi li teneva nella sua fattoria finché non avevano completato la loro istruzione. Li obbligava a studiare la lingua latina e l’arte del calcolo, e a sottostare a una disciplina molto rigida, fatta di regole minuziose e di soprusi inimmaginabili. Chi, a Dorikranos, non riusciva negli studi o non si adattava all’ambiente, veniva venduto per pochi soldi sul mercato di Argo e andava incontro a un’esistenza terribile, di fatiche e di stenti; chi si adattava, lo faceva perché sperava di poter migliorare, un giorno, le sue condizioni di vita. Occorre dire che eravamo infelici? Lo eravamo, anche se il nostro aspetto era quello di ragazzi ben nutriti e ben educati. Le cicatrici le portavamo dentro. La mia anima, se si potesse vederla, ancora oggi apparirebbe segnata dalle ferite di allora, come la faccia della luna nelle notti d’agosto; ma, di solito, chi compra uno schiavo non si preoccupa dell’anima, e non pensa nemmeno che possa averne una. Gli guarda gli occhi, i denti, i testicoli. Lo fa stare in piedi su una sola gamba per controllare il suo equilibrio, e gli fa tendere le mani per vedere se tremano.
![]()
Pur essendo ignorantissimo (l’ho già detto), Musodoro si atteggiava a filosofo. Il suo intercalare preferito era la frase di Diogene: «Cerco l’uomo». Amava i proverbi e i modi di dire che, per la loro banalità, si adattano a ogni circostanza e a ogni discorso; e li ripeteva fino alla nausea. Pretendeva che lo considerassimo, oltre che il nostro padrone, anche il nostro educatore e il nostro migliore amico («Io, per voi, sono piú che un padre! – ci gridava. – Vi mantengo, vi mando a scuola, faccio quello che nessuno dei vostri veri padri si sarebbe mai sognato di fare»); ma, in realtà, la sua scuola era in mano agli istruttori, cioè agli schiavi. Nelle prime classi c’erano due maestri, Pisto e Archias, che insegnavano a leggere e a scrivere ai bambini appena arrivati e badavano a dividere quelli che, secondo loro, erano in grado di continuare gli studi da quelli che non lo erano e dovevano essere venduti sul mercato locale. Il maestro delle classi superiori, invece, si chiamava Quinzione; veniva da un paese della Sicilia orientale ai piedi di una montagna leggendaria, il vulcano Etna, ed era uno degli uomini piú malvagi che io abbia conosciuto. Ricordo che ci perseguitava in ogni momento e in ogni modo possibile: ci spiava, ci castigava e, insomma, spendeva tutto il suo (mediocrissimo) ingegno e tutte le sue (notevoli) energie per renderci insopportabile un’esistenza, che anche senza di lui non sarebbe poi stata tanto piacevole. Siccome questo gli costava un po’ di fatica, credeva anche di avere diritto alla nostra gratitudine. «Dovreste baciare la terra dove appoggio i piedi quando cammino!», era una delle frasi che ripeteva piú spesso. Ci invidiava (e quindi ci odiava), perché in un futuro piú o meno lontano saremmo andati in giro per il mondo. «Grazie a me e alle mie fatiche, – ci gridava, – voi, un giorno, potrete godervi la vita: viaggerete, vedrete le opere dell’uomo e le meraviglie della natura, mentre io rimarrò a Dorikranos finché mi toccherà di creparci, a spezzare il pane del mio sapere con tutti gli ingrati e gli ignoranti che verranno, come l’ho spezzato con voi… Io, Quinzione, che ho scritto la mia prima commedia a soli tredici anni, e che prima di essere venduto come schiavo sul mercato di Argo, sono stato applaudito dal pubblico dei piú grandi teatri, in Sicilia, in Grecia e perfino nella città di Roma!»
(Mi ero dimenticato di dirlo. Il farabutto che piú di ogni altra persona ha contribuito a rovinarmi l’infanzia e la giovinezza, era stato un artista mediocre e perseguitato dai creditori: che, per ripagarsi dei suoi debiti, lo avevano venduto a Musodoro, come già avevano venduto ad altri acquirenti i saltimbanchi e gli istrioni della sua compagnia).
![]()
Cosí, dunque, trascorsero gli anni del mio apprendistato di «grammatico», nella fattoria di Musodoro e sotto la sferza di Quinzione; e cosí si consumò, per me e per i miei compagni di disgrazie, quell’età giovanile che molti considerano la piú bella della loro vita, e che sarebbe la piú bella per tutti se non dipendesse, irreparabilmente, dalla casualità della nascita. (Chi nasce bene, vive bene fino dai primissimi giorni; chi nasce male, ha qualche possibilità di migliorare la sua condizione soltanto dopo che è diventato adulto, o addirittura da vecchio). Noi ragazzi che eravamo a Dorikranos sognavamo in ogni momento di andarcene, per tornare a vivere tra gli uomini liberi; ma quei pochi che avevano provato davvero a fuggire dall’allevamento di Musodoro avevano fatto tutti una brutta fine, perché erano caduti da un dirupo, o erano stati punti da una vipera, o erano finiti in mano a un pastore che se li era tenuti come suoi servi. Fuggivamo nell’unico modo possibile, cioè con la fantasia. Quando riuscivamo a scambiarci le nostre confidenze senza che Quinzione ci ascoltasse, o quando lui, per castigo, ci costringeva a stare un’intera giornata dentro agli stanzini dei maiali, bassi e sudici, la fantasia ci portava lontano da quel luogo e dalla nostra condizione di schiavi, nel piú libero dei mondi possibili: quello delle favole! In quel mondo non esisteva la povertà, perché dappertutto c’erano tesori che attendevano soltanto di essere scoperti; gli schiavi come noi erano principi in incognito, che dopo un certo numero di avventure finivano sempre per incontrare i loro veri genitori; e perfino la morte era una specie di sonno un po’ piú profondo del sonno normale, da cui alla fine ci si svegliava… Cavalcavamo in paesaggi incantati, come i protagonisti delle quattro commedie in lingua latina (Le tessitrici fortunate, I due gemelli, Lo scampato al naufragio e Il buon augurio) che il nostro maestro ci costringeva a imparare a memoria; e vivevamo delle avventure abbastanza simili alle loro. Sognavamo di diventare ricchi e liberi, e di sposare delle donne bellissime. A volte, ci spingevamo ancora piú in là con la fantasia, e cercavamo di immaginare cosa fosse quell’attrazione tra uomini e donne, detta «amore», di cui i poeti parlano sempre nelle loro opere, e che a Dorikranos non si era mai vista. Pensavamo che dovesse avere a che fare con il sesso, ma che fosse anche qualcos’altro. Dicevamo: deve esserci dell’altro, per forza! (Il sesso, noi lo conoscevamo e lo vedevamo ogni giorno in tutte le sue forme, umane e bestiali; e ci sembrava impossibile che le nostre favole finissero in quel modo).
![]()
L’uomo che comperava i grammatici di Musodoro per rivenderli in Italia era una specie di androgino, senza barba e con le mammelle, che veniva a Dorikranos una volta all’anno prima che incominciasse l’estate e che viaggiava dentro una portantina chiusa, circondato da un gran numero di servitori e di guardie. L’arrivo di Acrone (tale era il nome dell’androgino) nella nostra colonia era preceduto da suoni di corni e di trombe e costituiva l’avvenimento piú atteso e temuto di ogni anno: nessun’altra ricorrenza, in quel luogo, era altrettanto importante! Musodoro andava a incontrare l’ospite fino sulla strada e poi lo accompagnava sotto il portico, facendogli aria con un ventaglio di piume di pavone. Si complimentava con lui per il suo aspetto e per i suoi abiti; gli offriva (inutilmente) del vino e dell’uva passita; e soltanto dopo averlo adulato e blandito in tutti i modi possibili si decideva a mostrargli la merce, cioè noi.
Per prima cosa, faceva venire le ragazze. Acrone era il proprietario di tutti i bordelli di Corinto e Musodoro, ogni volta, cercava di rifilargli le femmine piú carine che c’erano nella sua fattoria, giurando che erano vergini. (Gli strappava di dosso i vestiti. Diceva all’androgino, che, di solito, si mostrava poco interessato a questa fase della trattativa: «Ti autorizzo a provarle col dito, ma fai piano, altrimenti le sciupi!») La specialità di Dorikranos, però, eravamo noi, gli schiavi che parlavano latino e che dovevano essere venduti sul mercato di Napoli. Era per rifornirsi di grammatici che un grossista di schiavi come Acrone si prendeva il disturbo di salire in cima alla nostra montagna; e Musodoro, mentre ci schierava in cortile, ci faceva certi segni col viso e certe smorfie, che significavano: «Se qualcuno mi fa andare a monte un affare, lo ammazzo di botte!» Ci spogliava e ci maneggiava come se fossimo stati dei pupazzi, anziché delle persone vive. Gridava all’uomo che doveva comprarci: «Guarda che muscoli, che cosce! Li ho allevati io personalmente al sole e all’aria aperta della mia fattoria, e ti sfido a trovarne di piú sani in tutta la Grecia!»
«Vieni a toccarli con le tue mani! Su, che aspetti?»
Il mercante, allora, si alzava e si avvicinava. Aveva gli occhi piccoli e infossati nella carne come quelli dei maiali e faceva fatica a camminare perché le gambe, muovendosi, sfregavano una contro l’altra. Ci guardava in bocca e sotto le palpebre; ci faceva respirare a lungo e mentre compiva quelle operazioni ci accarezzava i genitali con la mano destra, non so se perché la cosa gli desse piacere o per verificare come reagivamo. Poi tornava a sedersi e ci rivolgeva qualche domanda, in un latino storpiato e approssimativo. Questa era la parte piú facile dell’esame perché le domande di Acrone, anno dopo anno, erano sempre le stesse, e noi che gli stavamo davanti conoscevamo già le risposte a memoria. La cosa difficile, invece, era fingere di essere piú vecchi di quanto fossimo davvero. Musodoro aveva una gran fretta di venderci e cercava di liberarsi di noi prima che il nostro sviluppo fosse completo: gridava che avevamo diciott’anni, e che non era colpa sua se non ci cresceva ancora la barba! Se i nostri testicoli erano cosí striminziti! (Acrone si limitava a guardarlo e a scuotere la testa. Gli diceva con l’espressione del viso: lascia perdere. È inutile che insisti).
Io sono comparso davanti all’androgino per tre anni consecutivi, prima che si degnasse di prendermi in considerazione. Quando finalmente gli sembrò che fosse arrivato il momento di comperarmi, cercò di tirare sul prezzo. Musodoro voleva trecento dracme, che in moneta romana corrispondono, all’incirca, a milleduecento sesterzi; Acrone, «al massimo», ne offriva duecento. Alla fine, i due furfanti si accordarono su duecentocinquanta dracme. Mentre loro gridavano io mi guardavo attorno. Non avevo nemmeno una ragione, una sola!, per amare quel posto, che anzi avevo odiato con tutte le mie forze. Ora però che stavo finalmente per andarmene, mi sentivo in corpo una grande paura: dove andavo? Da quando ero al mondo, la maggior parte della mia vita si era svolta lí. Vidi i miei compagni che mi guardavano da lontano, cercando di capire se ero stato venduto. Nessuno di loro era mio amico (a Dorikranos l’amicizia non poteva esistere, perché ognuno doveva badare a sé), ma tutti insieme erano la mia famiglia: l’unica famiglia che avessi mai avuto! Me ne andai singhiozzando; e l’ultimo ricordo che ho di quel posto è la faccia di Quinzione che dice agli altri ragazzi: «Ecco, vedete? Vi trattiamo cosí bene, qui, che quando dovete lasciarci non potete fare a meno di piangere!»
![]()
A quell’epoca avevo diciotto anni, o forse diciassette o diciannove: chi può dirlo! I miei anni non li ha mai contati nessuno. Della città di Corinto, dove mi portarono, non vidi assolutamente nulla. Rimasi chiuso per circa dieci giorni in una prigione per schiavi e subii ogni genere di violenze, da parte dei guardiani ma soprattutto da parte degli altri detenuti. Temetti, addirittura, di doverci lasciare la vita. (Ancora oggi, se ripenso a quei momenti terribili, mi sembra assurdo che degli esseri umani arrivino a comportarsi con i loro simili peggio di come si comportano gli animali feroci, e senza trarne nemmeno un vantaggio: soltanto per malvagità!) Quando finalmente Acrone mandò qualcuno a riprendermi, ero pieno di ferite e di lividi; e lui, vedendomi in quelle condizioni, si fece una bella risata. «Se dovessi venderti adesso, – mi disse, – perderei un mucchio di soldi; ma il viaggio per Napoli è lungo, e ti rimetterai in sesto prima di arrivarci».
Partii per l’Italia una mattina di giugno, con un gruppo di una ventina di schiavi. C’erano tra noi dei ceramisti, dei fabbri, dei grammatici e dei medici. C’erano anche quattro gladiatori che l’androgino aveva comperato da una...