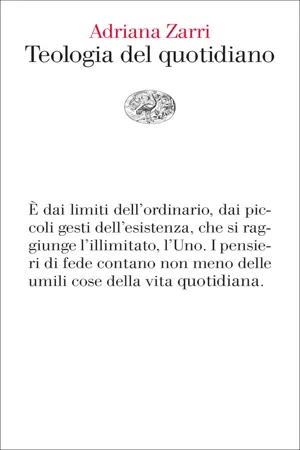
- 112 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile sull'app)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Teologia del quotidiano
Informazioni su questo libro
In una cascina della campagna piemontese, dove Adriana Zarri ha scelto di condurre la sua vita eremitica, ci sono gesti, tempi e mestieri caduti in disuso, dimenticati. La Zarri, proseguendo la sua personale ricerca teologica - da lei definita provocatoriamente «impura» - ci dice che è dalla contemplazione, dall'educazione ai valori antichi e dalla vicinanza con le piccole cose che è possibile vivere ogni giorno il miracolo cristiano. Solo percependo i limiti dell'ordinario si raggiunge l'illimitato, l'Uno. E l'osservazione del piccolo, del'Altro, ci avvicina a Dio. Una lezione attuale e sincera come un abbraccio.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
Al momento è possibile scaricare tramite l'app tutti i nostri libri ePub mobile-friendly. Anche la maggior parte dei nostri PDF è scaricabile e stiamo lavorando per rendere disponibile quanto prima il download di tutti gli altri file. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Base e Completo
- Base è ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un’ampia varietà di argomenti. Accedi alla Biblioteca Base con oltre 800.000 titoli affidabili e best-seller in business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce Read Aloud standard.
- Completo: Perfetto per studenti avanzati e ricercatori che necessitano di accesso completo e senza restrizioni. Sblocca oltre 1,4 milioni di libri in centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specializzati. Il piano Completo include anche funzionalità avanzate come Premium Read Aloud e Research Assistant.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi usare l’app Perlego sia su dispositivi iOS che Android per leggere in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo — anche offline. Perfetta per i tragitti o quando sei in movimento.
Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.
Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.
Sì, puoi accedere a Teologia del quotidiano di Adriana Zarri in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Print ISBN
9788806206208eBook ISBN
9788858406113Capitolo primo
L’impura teologia del topo
Io non so se sono teologa: se questa definizione un po’ ampollosa mi compete. C’è sempre stata una difficoltà d’intesa tra gli accademici e i battitori liberi: i primi rigorosi ultrascientifici (non ironizzo: tanto di cappello), i secondi, spesso, piú originali e creativi (non enfatizzo; ma cappello anche qui). Non soltanto per storia, ma anche per temperamento mi sento piú della seconda razza. Mi rendo conto che il preferire, trasferendolo sul piano dell’elezione, ciò che è un dato reale può venir valutato come un tranello psicologico, messo in atto per consolarsi delle proprie carenze inconfessate. Sebbene le confessi, non ne sottaccio il rischio; non inferiore tuttavia all’altro analogo: di chi preferisce la copertura accademica per consolarsi di un’inconfessata carenza creativa (sempre, s’intende, quando carenza ci sia e non la si confessi). Naturalmente l’ideale sarebbe lo spirito libero e creatore che abbia fatto i suoi studi sistematici, com’è il caso di tanti teologi che stimo. Non è purtroppo il caso mio; e allora il titolo resta lí, in sospeso, tra merito e lacune, tra generosità di chi me lo concede e taccagneria di chi invece me lo nega.
Io, per modestia (ahimè, che perigliosa modestia quella che si dichiara!), non mi definisco teologa, cosí come non mi definisco scrittrice: preferisco dire «pubblicista» e «studiosa di teologia». Il primo titolo sfuma nel vago (pubblicista è chi pubblica: saggista, corrispondente di provincia, magari grafomane che stampa i libri a spese proprie), e il secondo attesta l’indiscutibile diritto alla ricerca, senza chiamare in causa lauree. Poi vengo egualmente definita scrittrice e teologa, e lascio dire perché, a conti fatti, non mi sembra del tutto sbagliato. (Ciò che non amo particolarmente è venir definita giornalista, cosa che a volte capita, e non senza motivo, dato che scrivo pure sui giornali, senza però quella passione che serbo invece per le altre due attività).
Teologa o no, forse sono ciò che si dice «un capo storico», in quanto fui la prima donna che, in Italia, scrisse di teologia, in anni ancora acerbi; e questo, insieme alla mia non piú giovane età, mi procura un certo untuoso rispetto, da parte di chi – pur misurando in base ai titoli – mi guarda tuttavia con distaccata considerazione, come a una nonna che «ai suoi tempi, ebbe pure dei meriti. Magari con scarsa competenza ma, a quei tempi, poveretta, non poteva di piú». Ed è anche vero.
Questo temperamento e questa storia mi hanno felicemente costretta a scrivere pagine originali o nulla. I grandi testi della teologia io li ho avuti in effetti tra le mani, in un secondo tempo; li ho consultati dopo aver meditato, su quei problemi, sola. Tempo perduto – si dirà – quello impiegato per cercare ciò che altri ha già detto. Eppure no: so bene, di sicuro, che no. Perché, quando si scopre da sé, si scopre sempre del nuovo, anche nel vecchio, anche nel già detto e ridetto da secoli; e quell’idea ci resta dentro (e ci balza poi fuori) con una novità, uno scatto, un sapore esaltante d’invenzione che chi l’ha appresa dai libri non potrà mai conoscere; ne è stato defraudato dalla scuola. E anch’io, pensando a questo furto d’inventiva, dico, a mia volta: «poveretto!» Anche questa sarà la vecchia favola esopiana dell’uva acerba? Magari sarà. Ciascuno ha le proprie vigne e le proprie vendemmie.
La passione teologica mi è nata dentro con la vita; anzi, a una svolta precisa della vita. Forse ogni esistenza di credente è teologia fatta, cosí come ogni teologia riflessa porta il sangue e l’umore esistenziale del vissuto. Si dirà forse che questa è una teologia «impura». Sono ben consapevole che lo è e voglio chiaramente che lo sia. Dato e tutt’altro che concesso che una teologia «pura» possa esistere, si tratta di una pessima teologia; e non vorrei mai farla.
La teologia va scavata dalla teologalità della vita di fede. Il teologo di professione è colui che sa fare questo lavoro di lettura sotterranea, dell’esistenza propria e di quella degli altri. Poi gli dà un nome, sensus fidei o qualcosa di analogo e, se è un cattivo teologo, si appaga della formula latina, dimentica il solco terrigno e sanguigno dello scavo e mette tutto in biblioteca, consegnato alla carta. Talvolta la rosicchiano i topi; ed è, di nuovo, il sopravvento della vita, della teologia vissuta. Meglio un topo vivente che una pagina morta. E io, autrice di pagine, so bene quanto esse possano essere vive e generatrici di vita; ma anche morte e portatrici di morte. Una teologia impura, contaminata, compromessa col vivere è una teologia piena di passioni, di eventi, di topi, di tutto; una teologia totale perché il discorso su Dio è il discorso su tutto; tutto ciò che Dio assume in sé, redento e risorto; tutto tranne il peccato che è una sorta di vuoto metafisico; tutto tranne il nulla. Nemmeno un topo è nulla. Anche un topo ha dignità teologica; anche di lui la teologia deve dar conto.
Racconterò, dunque, questa impurità, distillerò la mia esistenza fino a spremere il succo teologico: della teologia «fatta» (veritatem facientes) e di quell’altra, propriamente detta, piú riflessa, anche se non so, delle due strettamente collegate, quale sia la piú propria. Ed è certo, comunque, che l’intreccio tra fede e teologia si annodò lontanissimo negli anni: nei miei primi, quando la fede fu un lampo subitaneo, balenato sulla disperazione di un credere intellettuale che non era la fede teologale e mi portava, anzi, al conflitto con un Dio detestato.
Non amo parlare di conversione, anche se quanto mi accadde in quei giorni è un fatto che va comunemente sotto quel termine; ma la parola – e il parlarne – mi sembra impudico e presuntuoso. E d’altra parte i convertiti non sempre sono i credenti piú maturi. Spesso la loro fede, ancora infante e insicura, li porta a posizioni di difesa oltranzista, leggermente fanatica, sovente clericale e allineata; e occorrono anni per giungere – quando vi giungono – a una matura libertà. Insomma, se anche ne faccio parte, non mi ci ritrovo, in quella categoria di neofiti; e il giorno che mi portò dal conflitto alla fede è cosa che riguarda il mio stretto privato (c’è anche un privato di riserbo che non è chiusura) perché desideri parlarne. Sta tuttavia di fatto che quel giorno ci fu, quell’evento successe e segnò la mia vita. «Là sono le mie sorgenti» potrei dire col salmo: le mie radici cristiane e quindi anche teologiche; una teologia, quella mia prima, ancora non riflessa; intuitiva e mistica, nel senso piú spoglio ed essenziale del termine; una conoscenza «per connaturalità», come avrei poi appreso che si dice, che mi portò a leggere, in seguito, alcuni testi teologici come se rileggessi cose sapute; e altri invece a rifiutarli, come del tutto estranei al mio modo di sentire e di vivere la fede. E quell’intreccio, di cui prima dicevo, tra il credere e il far teologia, cominciò a tessersi in quei giorni lontani e solitari, al solo cospetto dei cieli: cieli astronomici (giorni gonfi di nubi, notti tremanti di stelle) e cieli simbolici (il Padre che abita nei cieli e che parlava dentro, in un mio cielo piccolo e tuttavia piú grande dell’immenso orizzonte). Sconfinatezza della pianura piatta, in cui vedi il globo della terra rotolare nel cielo; e il sole ti viene incontro, la mattina, enorme e come di rame opaco, per la velatura delle nebbie: un paesaggio senza ostacoli che prediligo tra tutti perché ci son nata, perché è mio e impastato con me e che ho poi caricato di valori simbolici: l’illimitato che si raggiunge nei limiti segnati dai filari delle viti, il quotidiano e l’ordinario, rispetto alla grandiosa dimensione romantica ed eroica della montagna, la dolcezza, piú che la forza, di Dio Emmanuele (in ebraico, «che è con noi»). Come si vede la teologia già s’impastava con la terra: un Dio non totalmente altro ma piuttosto parente; e che parla con noi, e noi possiamo incontrare nelle sere, come i mitici due, nel giardino dell’Eden, nell’ora della brezza vespertina.
L’Eden già cominciava a interessarmi, e il tema patristico del ritorno mi appassionava; un ritorno non regressivo che avrei poi formulato nei termini di «ritorno in avanti»: verso un Eden che non è piú il nostro passato ma il nostro futuro; e tuttavia il passato ci aiuta a configurarlo, come un pallido simbolo della pienezza escatologica.
Forse quel po’ di neofitismo che c’era ancora in me mi condusse, in quei tempi, a un istituto secolare dove vissi l’equivoco di quelle istituzioni che, sul filo di un malinteso lessicale e giuridico, ritengono di essere laicali mentre sono, al contrario, il risultato di un certo evolversi della vita religiosa. Mi stavo dibattendo in quella posizione ambigua; e questo mi portò a studi ecclesiologici. Piú vicina a Rahner che a Congar, in quanto a teologia del laicato, volli tornar secolare a pieno titolo, con responsabilità personale, da pagare in proprio. La stagione del convertito neofita era ormai finita e le mie posizioni teologiche non erano sempre ben allineate con Roma; anzi spesso sgarravano parecchio. Il membro di un istituto, anche se in condizione subalterna, impegna sempre piú che se stesso: piú o meno direttamente, a seconda della sua rappresentatività, coinvolge l’intero corpo cui appartiene; come l’intero corpo, in ogni circostanza della vita, con lui solidarizza e lo difende. Questo offre al religioso e alle sue imprese una maggiore sicurezza, solidità e durata nel tempo, ma contemporaneamente, come contropartita negativa, gli sottrae una porzione di scioltezza, di libertà, di responsabilità diretta e personale.
Delle due facce della medaglia scelsi quella piú libera e laicale.
Vivere la vita.
Queste vicende mi avevano portato a battere le strade dell’ecclesiologia. La mia prima pubblicazione impegnativa uscí col titolo emblematico: La chiesa, nostra figlia (ahimè, come la «santa madre chiesa» s’incrinava, componendosi con altre compatibili ma diverse e dialettiche visioni!). Fu considerato da qualcuno uno dei libri anticipatori del clima e dei temi conciliari, nel non esaltante panorama (specie in quei tempi) della saggistica cattolica, in Italia.
A questo ne sarebbe seguito un altro, dal titolo altrettanto provocante: Teologia del probabile, che scalfiva le troppe false sicurezze, smerciate in nome della fede, quand’erano solo teologia, appena probabile e spesso anche improbabile.
Si esaurí in quindici giorni e restò il mio libro piú letto, anche se non il piú profondamente scritto. Non lo ritenni mai di piú di un’onesta raccolta di saggi, probabilmente lucidi ma altrettanto probabilmente peribili e destinati, col tempo, alla saputa scontatezza. Certo – e questo fu il motivo della sua grande diffusione – vi circolavano i problemi piú attuali e scottanti di allora: teologia del laicato, limiti dell’Azione cattolica, magistero, celibato ecclesiastico, divorzio, povertà della chiesa. Il titolo dell’ultimo capitolo – Una corona a Porta Pia – provocava non meno del titolo di copertina.
Di conseguenza si aprí una pagina della mia vita che fu anche una pagina, pur modesta, della vita ecclesiale italiana. Leggende di pianti pontifici alla lettura del libro, messaggi ufficiosi e di mai accertata autenticità che discendevano, dal terzo piano dei palazzi papali, verso il mio appartamento, lunghissime udienze con monsignor Benelli, allora sostituto alla segreteria di Stato, in cui furon discussi i temi piú cruciali del momento, con grande reciproco rispetto ma con grande reciproco dissenso. Passavo, insomma, probabilmente a buon mercato, come un enfant terrible che avrebbe dato dei fastidi a un istituto religioso. E avevo fatto bene a tirarmene fuori in tempo.
Ma per chiarire appieno il mio ritorno allo stato laicale non bastano quelle motivazioni ecclesiologiche. Ce n’erano altre, piú profonde.
La larghezza di disciplina (pur con le limitazioni che s’è detto), il vasto raggio di possibilità concesse dall’istituto facevano sí che mi si domandasse: «ciò che vuoi fare non puoi farlo anche dentro?» Ma io rovesciavo la domanda: «ciò che voglio fare non posso farlo anche fuori?» Un pieno impegno, una totale dedizione non sono forse di tutti i cristiani, senza necessità di «consacrazioni» ulteriori a quella fondamentale del battesimo? E allora perché un «di piú» aggiuntivo che è solo di tipo strutturale, che non aumenta la carità ma solo la disciplina? C’era, in quella domanda rovesciata, il rifiuto della teologia degli «stati di perfezione» e il desiderio di essere come tutti, senza una vita, in qualche modo, separata, senza alcun supplemento istituzionale e disciplinare rispetto all’impegno della sequela del Signore.
E, nell’ambito di questa prospettiva, cos’era poi ciò che volevo fare? Già all’interno della struttura religiosa avevo vissuto la dialettica tra le opere e «la testimonianza»: tra quelli che s’impegnavano per realizzare qualche cosa e quelli che si spendevano, in modo anonimo, confessando la fede, nelle situazioni ordinarie della vita. E mi sentivo tra questi. Poi la stessa testimonianza mi parve dimensione presuntuosa. Ciò che volevo era semplicemente vivere; e, se questa vita a qualcuno diceva qualche cosa, bene: era un fatto suo, che non mi riguardava; e meno mi riguardava, nel senso di coscienza preveduta e riflessa, meglio era per tutti. Non quindi costruire opere né «fare l’apostolato» – come a quei tempi ancora si diceva – perché l’apostolato non si fa: si è, essendo la vita di Dio, rivissuta tra noi. Ma si vive la vita divina, vivendo con pienezza e nudità, la vita umana. Ciò che volevo era sempre meno e sempre piú: sempre meno catalogabile e piú scarnito. E dirò poi quanta teologia implicita e via via esplicitata c’era in questo cammino.
Quando, molto tempo piú tardi, scelsi una via monastica di tipo eremitico, la volli ancora laica, secondo l’antica tradizione motivata da una nuova coscienza ecclesiologica. E volli ancora viverla nella maniera piú ordinaria e comune. In un libro (Erba della mia erba), ne concludevo il resoconto (non «testimonianza», ma resoconto: un termine volutamente dimesso e notarile) in questo modo: «Se ora volessi chiudere con un congedo edificante vi potrei dire: ricordatevi che, in una cascina, in mezzo alla campagna, c’è un’eremita che prega. Ma mi parrebbe estremamente pletorico. Sento il bisogno di semplificare, di ridurre all’essenza: spoglio, nudo, un osso. Lasciamo cadere l’eremitismo, il monachesimo, la cascina, la campagna, perfino la preghiera. Preferisco dire che vivo: mi sembra piú semplice e piú ricco perché la vita comprende la preghier...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Teologia del quotidiano
- Copyright
- Nota editoriale
- Teologia del quotidiano
- Capitolo primo - L’impura teologia del topo
- Capitolo secondo - Il problema della fede
- Capitolo terzo - Il Dio critico
- Capitolo quarto - Non uccidere: teologia e società
- Capitolo quinto - Oltre i limiti del corpo
- Capitolo sesto - Poesia e mistica