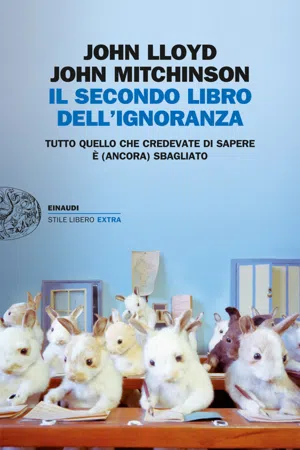![]()
Siamo tutti ignoranti, solo su argomenti diversi.
WILL ROGERS (1879-1935).
![]()
Chi ha fatto il primo volo in aeroplano?
Non ne conosciamo il nome, ma ha battuto i fratelli Wright di cinquant’anni.
Lavorava per Sir George Cayley (1773- 1857), un nobile dello Yorkshire nonché pioniere dell’aviazione, autore del primo studio veramente scientifico sul volo degli uccelli. Aver descritto con precisione i principî di «portanza, spinta e resistenza» che governano il volo portò Cayley a costruire svariati prototipi di macchine volanti. Falliti i primi tentativi con ali che battevano (azionate da motori a vapore e polvere da sparo), si concentrò sugli alianti.
Nel 1804 illustrò il primo modello di aliante al mondo e, cinque anni dopo, ne testò una versione a grandezza naturale, ma senza pilota. Trascorsero piú di trent’anni prima che si sentisse finalmente pronto a far volare un passeggero umano sul suo «paracadute governabile». Nel 1853 a Brompton Dale, nei pressi di Scarborough, l’intrepido baronetto persuase il suo riluttante cocchiere a sorvolare la valle con il marchingegno. Fu questo anonimo dipendente a divenire il primo essere umano ad avere mai volato su una macchina piú pesante dell’aria.
A quanto si narra, il cocchiere non rimase affatto impressionato. Non appena atterrato dette le dimissioni dicendo: «Sono stato assunto per guidare, non per volare». Una riproduzione moderna dell’aliante di Cayley, esposta adesso allo Yorkshire Air Museum, nel 1974 ha ripetuto con successo il volo sopra Brompton Dale.
Le ali non furono però il solo lascito di Sir George, il quale, con i suoi studi sull’apparato di atterraggio dell’aliante, reinventò letteralmente la ruota. Poiché serviva qualcosa di leggero ma resistente che assorbisse l’impatto del velivolo quando toccava terra, gli venne l’idea di utilizzare ruote i cui raggi erano mantenuti in tensione, anziché scavati nel legno massello. L’idea fu poi sviluppata nelle biciclette e nelle automobili ed è largamente in uso ancora oggi.
E non è tutto. Cayley era un inventore straordinariamente prolifico che mise a punto scialuppe di salvataggio in grado di raddrizzarsi da sole, cingoli per bulldozer, segnali automatici per gli incroci ferroviari e cinture di sicurezza. E, cosa ancor piú degna di nota, offrí tutte queste invenzioni per il bene pubblico, senza aspettarsi alcun ritorno economico.
I fratelli Wright compirono i loro famosi voli mezzo secolo dopo, nel 1903, ispirati da Cayley e da un altro misconosciuto eroe dell’aviazione, Otto Lilienthal (1848-1896), un prussiano noto come il Re degli alianti. Fu il primo a volare con continuità: nel decennio che precedette le imprese dei fratelli Wright, compí oltre duemila voli in aliante, prima di morire precipitando nel 1896. Le sue ultime parole furono umili e toccanti: «I piccoli sacrifici vanno accettati».
Quante «gambe» ha un polpo?
Due.
I polpi hanno otto arti che sporgono dal corpo, ma ricerche recenti sul modo in cui li usano ne hanno ridefinito la denominazione. Il polpo, detto anche octopus (dal greco per «otto piedi»), è un cefalopode (dal greco per «testa + piedi») che usa i due tentacoli posteriori per spingersi sul fondo marino e gli altri sei per nutrirsi. Di conseguenza, ora i biologi marini tendono a riferirsi ai polpi come animali con due «gambe» e sei «braccia».
I tentacoli del polpo sono organi miracolosi in grado di irrigidirsi per creare una provvisoria articolazione a gomito o di ripiegarsi in modo da far sembrare l’animale una noce di cocco che ruzzola sul fondo marino. Contengono inoltre due terzi del cervello; circa cinquanta milioni di neuroni; l’ultimo terzo, a forma di ciambella, si trova all’interno della testa, o mantello cerebrale.
Poiché tanta parte del sistema nervoso del polpo risiede nelle sue estremità, ogni arto ha un alto grado d’indipendenza. Un tentacolo reciso può seguitare a strisciare e, in alcune specie, sopravvivrà per diversi mesi. Il braccio (o la gamba) di un polpo ha davvero una mente propria.
Ciascun tentacolo presenta due file di ventose dotate di papille gustative per identificare il cibo. Un polpo assaggia tutto ciò che tocca. I maschi, poi, hanno anche un braccio speciale che contiene lo sperma. Si chiama ectocotile e serve per l’accoppiamento. Per trasferire lo sperma, il maschio infila il braccio in un foro nella testa della femmina. Di solito, durante la copula l’ectocotile si stacca, ma al maschio ne cresce un altro l’anno successivo.
Aristotele (384-322 a.C.) fu il primo a descrivere l’accoppiamento dei polpi, ma per due millenni nessuno volle credergli. Lo zoologo francese Georges Cuvier (1769-1832) riscoprí il processo nel XIX secolo e dette all’ectocotile quel nome, che significa «cento coppette» in greco.
Alcune variazioni genetiche fanno sí che a volte un polpo abbia piú di otto arti. Nel 1998 l’acquario di Marine Land a Shima, in Giappone, esponeva un octopus vulgaris con novantasei tentacoli. Era stato catturato nella vicina baia di Matoya nel dicembre di quell’anno; morí cinque mesi dopo. Prima, però, il cefalopode superdotato era riuscito a deporre le uova, da cui nacquero piccoli con un numero normale di braccia e di gambe, ma nessuno sopravvisse piú di un mese.
Talvolta i polpi si mangiano le braccia. Si credeva che fosse una reazione allo stress, ma adesso si pensa sia colpa di un virus che attacca il sistema nervoso.
Di che colore sono le arance?
Dipende.
In molti paesi le arance sono verdi – anche quando sono mature – e vengono vendute cosí. Lo stesso vale per limoni, manghi, mandarini e pompelmi.
Le arance non esistono in natura. Si ottengono dall’incrocio tra il mandarino e il pomelo o «pompelmo cinese» (che è verde pallido o giallo) e furono coltivate per la prima volta nel Sudest asiatico, dove all’epoca erano verdi e lo sono tuttora. Le arance vietnamite e i mandarini tailandesi sono verde brillante all’esterno e arancioni soltanto all’interno.
Le arance sono frutti subtropicali, non tropicali. Il colore del frutto dipende da dove cresce. Nei climi piú temperati la buccia diventa arancione quando rinfresca, ma nei paesi dove fa sempre caldo la clorofilla non si distrugge e i frutti rimangono verdi. Le arance dell’Honduras, per esempio, sono mangiate verdi in loco ma rese arancioni artificialmente per l’esportazione.
A questo scopo vengono irrorate di gas etilenico, un sottoprodotto dell’industria petrolifera usato principalmente nella produzione della plastica. L’etilene è il composto organico piú diffuso nel mondo: se ne producono cento milioni di tonnellate all’anno. Elimina il naturale strato verde all’esterno dell’arancia facendo affiorare il colore che ci è piú familiare.
Il Brasile è di gran lunga il maggior produttore di arance del mondo (diciotto milioni di tonnellate all’anno), seguito dagli Stati Uniti, che ne coltivano meno della metà. Le arance americane provengono dalla California, dal Texas e dalla Florida. Un tempo le si tingeva con coloranti sintetici, finché la Food and Drug Administration non vietò quella pratica nel 1955.
Non si può giudicare il grado di maturazione di un’arancia dal colore, quale che sia la sua provenienza. Se nessuno la coglie, un’arancia può rimanere sull’albero fino alla stagione successiva e in quel periodo le fluttuazioni nella temperatura possono farla passare dal verde all’arancione e poi di nuovo al verde senza influire sulla qualità o sul gusto.
I frutti che vedete esposti al supermercato appaiono completamente arancioni, ma forse state cominciando a chiedervi preoccupati se non siano stati trattati con il gas. Non dovete.
L’etilene è inodoro, insapore e innocuo, e molti frutti e verdure lo esalano naturalmente una volta colti. Tra i produttori di etilene figurano le mele, i meloni, i pomodori, gli avocado e le banane. Il gas non è nocivo per voi, ma può danneggiare altri tipi di frutta o verdura; ecco perché fareste meglio a tenere mele e banane separate da limoni e carote, per esempio (e, ovviamente, dalle arance).
L’etilene ha vari usi, oltre alla produzione della plastica (e di detergenti e antigelo) e all’alterazione del colore delle arance. Se volete accelerare la maturazione di un mango acerbo tenetelo in un sacchetto con una banana.
Come si chiama il punto piú meridionale dell’Africa?
Non è il capo di Buona Speranza.
Gli abitanti della vicina Città del Capo lo devono spiegare spesso ai turisti. Il punto piú a sud del continente è il molto meno famoso capo Agulhas, centocinquanta chilometri a sudest del capo di Buona Speranza.
La ragione addotta di solito per la fama (e il nome) del capo di Buona Speranza è che era il punto psicologicamente importante superato il quale i marinai diretti nel lontano Oriente, dopo tanto navigare verso sud lungo la costa occidentale dell’Africa, finalmente viravano verso est.
D’altro canto, potrebbe essersi trattato di una trovata pubblicitaria ante litteram.
Bartolomeo Diaz (1451-1500), il navigatore portoghese che scoprí il capo di Buona Speranza e divenne il primo europeo a compiere il terrificante viaggio intorno all’estremità inferiore del continente africano, l’aveva denominato cabo das Tormentas (capo delle Tempeste). Il suo datore di lavoro, il re Giovanni II del Portogallo (1455-1495), ansioso di incoraggiare altri a seguire la nuova rotta commerciale, lo corresse, ribattezzandolo diplomaticamente cabo da Boa Esperança (capo di Buona Speranza).
Il re morí senza figli a soli quarant’anni. Cinque anni dopo morí anche Bartolomeo Diaz naufragando – insieme a quattro navi coi relativi equipaggi – in una terribile tempesta proprio al largo del capo che aveva denominato con tanta preveggenza.
Anche capo Agulhas è insidioso. Il suo nome portoghese significa infatti «capo degli aghi» per le rocce e le scogliere acuminate che ne infestano le acque tumultuose. La città che vi sorge ospita un museo dei naufragi, che commemora «un cimitero di navi».
Grazie all’isolamento e alle inaccessibili spiagge scogliose, l’area è ricca di flora e fauna allo stato naturale. Sulla terra ferma si trovano la microrana (Microbatrachella capensis), in grave pericolo di estinzione, e l’allodola battiali di Agulhas (Mirafra o apiata majoriae) cosí chiamata perché durante il corteggiamento batte rumorosamente le ali.
Al largo, tra maggio e agosto il mare ribolle di miliardi di sardine sudafricane (Sardinops sagax) che migrano. Questi banchi di pesci sono i piú vasti del pianeta, equivalenti alle grandi migrazioni di animali selvatici sulla terraferma, e possono estendersi per sei chilometri di lunghezza e due di larghezza. Centinaia di migliaia di squali, delfini, foche e uccelli marini seguono la scia delle sardine, servendosi a volontà senza produrre gravi danni, dato il grande numero.
Capo Agulhas si trova a 34° 49’ 58” sud e 20° 00’ 12” est ed è il punto di separazione ufficiale tra oceano Atlantico e oceano Indiano. Seguendo la dolce curvatura della costa, non particolarmente imponente, forse non ci si accorgerebbe nemmeno di averlo doppiato se non fosse per il cumulo di pietre che segna la posizione esatta della punta.
Qual è la sostanza piú dura che si conosca?
Il diamante? No, non piú.
Nel 2005 alcuni scienziati dell’Università di Bayreuth, in Germania, hanno creato un nuovo materiale comprimendo il carbonio puro a una temperatura estremamente elevata. L’hanno chiamato iperdiamante o diamante aggregato nanorod (Adnr) e benché sia incredibilmente duro assomiglia all’asfalto o a un lucente budino di cioccolata.
È risaputo da tempo che una forma di carbonio puro (grafite) si può trasformare in un’altra (diamante) mediante il calore e la pressione, ma l’équipe di Bayreuth non ha usato nessuna delle due, bensí una terza forma, la fullerite, nota anche come fullerene sferico o buckyball. I suoi sessanta atomi di carbonio formano una molecola simile a un pallone da calcio o a quelle cupole geodetiche inventate dall’architetto americano Richard Buckminster Fuller (1895-1983).
Nel diamante, gli atomi di carbonio sono disposti in cubi impilati a piramide; la nuova sostanza, invece, è fatta di minuscole barre intrecciate, chiamate nanorod proprio perché piccolissime. Ciascuna di esse è lunga un micron (un milionesimo di metro) e larga venti nanometri (venti miliardesimi di metro), circa un cinquantamillesimo della larghezza di un capello umano.
Sottoponendo la fullerite a calore estremo (2220 gradi Celsius) e a compressione (duecentomila volte la normale pressione atmosferica) si è ottenuto non soltanto il materiale piú duro, ma la sostanza piú rigida e densa che la scienza conosca.
La densità indica quanto sono fitte le molecole di un materiale e si misura con i raggi X. L’Adnr è piú denso del diamante dello 0,3 per cento.
La rigidità è una misura della comprimibilità: la uguale quantità di forza che si deve applicare su tutti i lati per ridurre il volume di un materiale. La sua unità base è il pascal, che prende il nome da Blaise Pascal (1623-1662), il matematico francese che contribuí allo sviluppo del barometro, lo strumento per misurare la pressione atmosferica. La rigidità dell’Adnr è di 491 gigapascal (GPa) contro i 442 GPa del diamante e i 180 GPa del ferro. Ciò significa che l’Adnr resiste alla compressione circa tre volte piú del ferro.
La durezza è piú facile da determinare: se un materiale può scalfirne un altro significa che è piú duro. Nel 1812 il mineralogista tedesco Friedrich Mohs (1773-1839) elaborò la scala di Mohs, che inizia con il materiale piú tenero, il talco (MH1). Il piombo è abbastanza tenero: MH1½; le unghie hanno una durezza di MH2½ (come l’oro); a metà ci sono il vetro e le lame dei coltelli, con MH5½. La comune carta vetrata (che è fatta di corindone) misura MH9 e in cima c’è il diamante, con MH10. Poiché l’Adnr può scalfire il diamante è addirittura fuori scala.
E c’è un’altra notizia deludente per i fan dei diamanti: non sono «per sempre». La grafite (che, caso strano, è uno dei materiali piú teneri che si conoscano, tenero quanto il talco) chimicamente è molto piú stabile del diamante. Infatti, tutti i diamanti si trasformano molto lentamente in grafite. Il processo però è impercettibile. Nessuno corre il rischio di ritrovarsi all’improvviso con due matite alle orecchie.
Qual è la sostanza piú strana che la scienza conosca?
L’H2O.
L’acqua, o ossido di idrogeno, è la sostanza piú strana che la scienza conosca. Con la possibile eccezione dell’aria, è anche la piú familiare. Copre il settanta per cento della terra e compone il settanta per cento del nostro cervello.
L’acqua è ossigeno legato all’idrogeno (l’elemento piú semplice e comune dell’universo) nel modo piú facile possibile. Qualunque altro gas combinato all’idrogeno produce un gas: soltanto l’ossigeno e l’idrogeno formano un liquido.
Ed è un liquido ch...