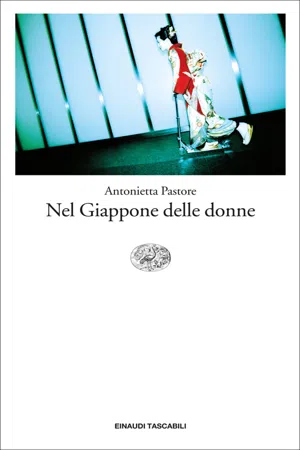![]()
Atsuko.
Incontro Atsuko nell’estate del ’77, a un corso di piano rock e jazz. Lei ha ventisei anni, io trentuno, e sono in Giappone da circa quattro mesi. Abito a casa dei miei suoceri perché né io né mio marito abbiamo ancora trovato un lavoro stabile che ci permetta di affittare un appartamento, la nostra unica fonte di reddito sono gli incarichi saltuari di interprete che lui svolge per alcune ditte di Osaka, le lezioni private di francese e italiano che io riesco a procurarmi tramite un’agenzia.
Dopo un primo periodo di entusiasmo incondizionato per tutto quello che vedevo, assaggiavo, provavo – quella che chiamo la fase del turista – sono appena entrata in una crisi di rigetto nei confronti del paese che mi ospita. Quasi tutti gli occidentali che ho conosciuto in Giappone sono passati attraverso queste due fasi, un primo innamoramento seguito da un totale rifiuto. Alcuni si sono fermati alla seconda, con ricadute occasionali nella prima, altri hanno continuato ad alternare i due stati d’animo in un rapporto di amoreodio mai risolto. Frequenti le depressioni, non rari i casi di gente che ha rivalutato il Giappone soltanto dopo averlo lasciato definitivamente ed essere tornata a vivere, dopo anni di lontananza, in un’Europa a lungo idealizzata dalla nostalgia. Ma sono anche tante le persone che hanno capito, sia attraverso i rapporti personali che le esperienze di lavoro, che in Giappone, come ovunque, esistono aspetti positivi e aspetti negativi, e che per discernere gli uni dagli altri è necessario prima di tutto liberarsi dei propri preconcetti, fare tabula rasa dei condizionamenti assimilati insieme a una cultura che pone l’Occidente a modello di civilizzazione. Quanto a me, molti sono i fattori che mi hanno aiutata a cogliere, e ad accogliere, nuovi valori – a cominciare da quelli più facilmente percepibili: il cibo, un’estetica svincolata dalla simmetria – e a trovare quindi in un tempo relativamente breve, più o meno tre anni, un rapporto sereno con il paese in cui vivevo. Innanzi tutto, determinante, il calore con cui sono stata accolta dai miei suoceri. In secondo luogo la mia formazione universitaria nel campo delle scienze umane, che mi ha sempre spinto a cercare, al di là delle apparenze, le cause profonde dei fenomeni. Altra circostanza favorevole, essendo nata e cresciuta a Torino in una famiglia siciliana, fin da bambina ho vissuto a cavallo tra due culture, sperimentando gli aspetti positivi e negativi di entrambe. Per finire, mi sono allontanata dal mio ambiente d’origine in maniera graduale: dopo aver studiato per tre anni a Ginevra, dove ho incontrato il ragazzo giapponese che sarebbe diventato mio marito, nel ’71 sono andata a vivere con lui a Parigi. Nel ’74 un primo soggiorno di un paio di mesi in Giappone – a casa dei miei suoceri – dal quale torno entusiasta, poi il trasferimento definitivo a Osaka nel ’77.
Nel periodo in cui incontro Atsuko, dunque, sono estremamente critica nei confronti della società giapponese, della quale colgo solo gli aspetti superficiali e formali: trovo rigide quasi tutte le persone che incontro, di facciata la loro cortesia, inutili le cerimonie che accompagnano ogni evento. Giudico anomala – sbagliando – la famiglia di mio marito, della quale amo l’atmosfera rilassata e serena, senza rendermi conto che se la vedo così è perché la guardo dall’interno, perché ne faccio parte. Inoltre la mia conoscenza della lingua, che per due anni ho studiato da sola su alcuni manuali comprati durante il viaggio del ’74, è ancora del tutto inadeguata, riesco appena a sostenere una conversazione rudimentale, il che non favorisce la reciproca comprensione con i giapponesi – a esclusione di mia suocera, che ha la pazienza di inventare ogni possibile giro di parole per comunicare con me.
Con Atsuko, che si è laureata in lingue in un’università privata, quando non riusciamo a capirci ci aiutiamo con qualche parola di francese (l’ha studiato come seconda lingua), e questo di sicuro allenta la tensione – la mia, capisco col senno di poi – facilitando il nostro rapporto. Infatti diventiamo subito amiche perché abbiamo tanti interessi in comune, il cinema, il teatro e la letteratura francese, che lei conosce piuttosto bene anche se legge solo in traduzione. Nonostante il titolo di studio, Atsuko lavora in una compagnia di assicurazioni in qualità di OL – office lady, in pratica una segretaria, come la stragrande maggioranza delle donne impiegate nel settore pubblico e privato – ma non se ne lamenta. Poiché vive con la famiglia, che deve essere molto agiata a giudicare dall’indirizzo di casa, può spendere tutto il suo stipendio in attività ricreative, e questo sembra bastare alla sua felicità. Colta, spiritosa, squisitamente educata, Atsuko ha un fascino garbato che evoca di continuo, nella mia fantasia, l’immagine delle nobili dame letterate della corte Heian. Fascino al quale contribuisce una socievolezza fluida e attenta, che rende la sua compagnia molto gradevole.
Per i primi tre mesi. Poi a poco a poco Atsuko si rabbuia, cerca di non darlo a vedere ma diventa sempre più triste e si chiude in se stessa. Quando andiamo a prendere un caffè insieme, come abbiamo l’abitudine di fare dopo la lezione di piano, parla del più e del meno, lei che si confidava volentieri, e svia sempre il discorso su genericità. Finché un giorno lo sfogo arriva, espresso con un’angoscia dignitosamente contenuta: i suoi genitori vogliono che lei si sposi, e si sono rivolti a una signora che si occupa di combinare matrimoni perché le organizzi degli incontri con uomini che abbiano i requisiti necessari. All’inizio lei era contraria, poi si è detta che in fin dei conti poteva anche essere un’occasione per conoscere qualcuno che le piacesse. Ha avuto tre storie d’amore finora, due quand’era studentessa, e una con un suo collega, ma tutt’e tre sono finite prima che passasse un anno. Di conseguenza un omiai, così si chiamano questi incontri combinati a scopo matrimoniale, non sarebbe una cattiva soluzione. Ma dopo aver conosciuto diversi possibili partner è molto delusa, non ce n’è uno che le vada a genio, neanche un po’. I primi non ha avuto difficoltà a respingerli, ma al quinto rifiuto sia i genitori sia la signora che fa da intermediaria han cominciato a dar segni di impazienza: Atsuko ha già ventisei anni e non può permettersi di continuare a rifiutare degli ottimi partiti. Se lascia trascorrere ancora un paio d’anni, dovrà accontentarsi di qualcuno che ora non prenderebbe neanche in considerazione. Stento a credere che una ragazza del fascino di Atsuko, ancora tanto giovane, debba farsi di queste preoccupazioni. Le chiedo se non abbia occasione di conoscere degli uomini senza ricorrere a un’intermediaria, ma lei mi risponde di no, frequenta solo i colleghi d’ufficio, o pochi ex compagni di scuola; e vede arrivare il momento in cui dovrà rassegnarsi a scegliere, seppur di malavoglia, uno dei candidati che le vengono proposti. L’ultimo in particolare sembra tenere molto a lei, insiste per rivederla, telefona ogni giorno, e lei non sa più come dire di no. Non al giovanotto che manderebbe a quel paese in quattro e quattr’otto, ma ai propri genitori che ogni giorno le chiedono se si è finalmente decisa.
La situazione in cui si trova Atsuko non è certo insolita. Esiste in effetti una grande difficoltà per i giovani a incontrare persone dell’altro sesso al di fuori dell’ambiente di cui si fa parte, l’università per gli studenti, la ditta per le persone che lavorano. La struttura della società giapponese, basata sul gruppo e non sull’individuo, tanto favorisce le relazioni all’interno del gruppo stesso, quanto ostacola quelle rivolte verso l’esterno. Feste e ricevimenti si fanno sempre fra colleghi, compagni di corso, di club, ex allievi dello stesso liceo e via di seguito, di conseguenza offrono pochi elementi di novità. L’abitudine di portare a queste riunioni un amico, un’amica, non esiste poiché la persona non appartenente al gruppo si sentirebbe molto a disagio. Ogni sera della settimana in ogni mese dell’anno, pub, birrerie e locali in genere sono pieni di una folla eterogenea, ma non avvengono scambi fra i diversi gruppi, spesso composti di soli uomini o di sole donne. I banchetti di nozze sono rigidi pranzi di gala, a metà strada fra tradizione locale e presunto bon ton occidentale (stucchevoli a forza di imitare – maldestramente – un romanticismo di stampo americano), durante i quali si parla esclusivamente con i vicini di tavola; ma poiché i posti sono studiati in modo da non mischiare i gruppi, gli invitati dello sposo da una parte della sala, quelli della sposa dall’altra, ci si ritrova insieme a vecchie conoscenze. E se in uno scambio di sguardi tra due estranei, da un tavolo all’altro, scocca una scintilla, l’uomo dovrà approfittare della confusione per presentarsi alla ragazza, o sperare di rivederla al secondo ricevimento, quello per gli intimi, che si terrà altrove. Per poi scoprire magari che è già sposata, perché ai matrimoni non si viene con i rispettivi consorti se non sono essi stessi amici personali dello sposo o della sposa. Succede naturalmente in altre circostanze che qualcuno faccia conoscere alla sorella o all’amica della fidanzata un vecchio compagno di scuola, o viceversa, ma queste presentazioni, che raramente avvengono per caso, assumono quasi sempre un carattere impegnativo che le avvicina all’omiai. Quanto allo sport, lo si pratica fra colleghi, o nel club universitario di cui si fa parte, dove si vedono solo facce note.
In conseguenza di questa situazione, ci sono solo due modi per i giovani di arrivare al matrimonio a conclusione di una storia d’amore nata spontaneamente: trovare il futuro marito o la futura moglie sui banchi dell’università o tra i colleghi d’ufficio. Una volta escluse queste due possibilità, non resta che l’omiai, il matrimonio combinato, che attualmente costituisce il 50 per cento delle unioni. All’inizio del mio soggiorno in Giappone trovavo la cosa sconcertante, ma in seguito sono venuta a pensare che nella società giapponese l’omiai svolga una funzione non solo utile, ma indispensabile. Oltre alla difficoltà di trovare possibili partner al di fuori degli ambienti che si frequentano quotidianamente, dove non si incontra necessariamente l’anima gemella, anche la timidezza naturale dei giapponesi, maschi e femmine, ostacola gli scambi tra i due sessi, e in più le regole della buona educazione impongono agli uomini un riserbo, nei confronti delle donne, che in Europa li farebbe passare per «imbranati». L’omiai d’altronde non è più quello che era fino a mezzo secolo fa, quando i genitori decidevano per i figli e i matrimoni venivano combinati senza domandare il parere di questi ultimi. Oggi il ragazzo o la ragazza ricevono vari dossier completi di fotografie (a parità di ambiente d’origine, per l’uomo il profilo insiste sulla carriera scolastica e professionale, per la donna sulla compitezza, l’educazione extrascolastica – pianoforte, arti tradizionali – l’avvenenza), li sottopongono all’approvazione delle rispettive famiglie, fanno le loro scelte, e incontrano un certo numero di possibili partner. In fin dei conti si tratta soltanto di andare a cena insieme in un buon ristorante, parlare del più e del meno, fare conoscenza, e se non nasce nessun tipo di feeling, amici come prima. Se invece i due si sono piaciuti, si rivedono, si frequentano per un certo tempo, e abbastanza velocemente arrivano alla decisione di sposarsi, visto che era questo l’obiettivo originario. La famiglie sono d’accordo fin dall’inizio, nessun problema. Tutto sommato è un modo pratico per conoscere dei candidati con tutte le carte in regola. È vero che i giovanissimi sognano un matrimonio d’amore, ideale che in questo paese conserva ancora, proprio perché è una scoperta relativamente recente, il fascino romantico che poteva avere in Europa nel secolo scorso. Ma non tutti riescono a incontrare la persona giusta in tempo utile, così spesso oggi sono i giovani stessi che decidono di ricorrere a un certo punto all’omiai, e più di una volta. Può succedere di innamorarsi, in seguito a un omiai, però capita anche che tra le numerose persone conosciute in questo modo non ce ne sia nessuna con cui si abbia voglia di passare il resto della propria vita. Allora si rimanda la scelta, e si rimanda ancora, finché la pressione della famiglia, della ditta, di tutta la società, inducono la ragazza o il ragazzo in questione ad accettare qualcuno che non avrebbero degnato di uno sguardo due o tre anni prima. Più passano gli anni, più si abbassano le pretese, più si è disposti al compromesso (al giorno d’oggi l’età media a cui ci si sposa è di 26,7 anni per le donne, 28,5 per gli uomini). Una giovane che rimandi troppo a lungo la scelta di un marito, che preferisca la vita comoda a casa dei genitori alle responsabilità del matrimonio – fenomeno in crescita – verrà considerata egoista (i sociologi Miura Shūmon e Sarada Tamako, in un saggio uscito nel settembre del 2001, chiamano questo tipo di donna parasaito shinguru, single parassita, espressione diventata subito di moda). L’obbligo di sposarsi è ancora più forte per l’uomo, poiché la società non accorda alcun credito a chi non è stato capace di formare una famiglia, lo giudica inaffidabile, e difficilmente gli permetterà di ricoprire cariche di responsabilità. Non ricordo di aver mai incontrato in Giappone un uomo che avesse superato i trentacinque anni e non fosse sposato. A eccezione di quelli che lavorano in ambienti particolari (moda, arte, spettacolo), quasi tutti finiscono per convolare a inevitabili nozze. Anche molti omosessuali (ricordo un professore di un’università privata – sposato e padre di numerosa prole – che appena alzava un po’ il gomito, alle cene di fine anno, approfittava della facilità di spostamento che permettono i tatami per avvicinarsi sornionamente agli allievi maschi e permettersi familiarità più rivelatrici che sospette). Una donna che per scelta o necessità non si sposi invece verrà accettata meglio, anche perché incarichi di grande responsabilità non gliene verrebbero affidati comunque. Fino ai trent’anni, trentacinque anni al massimo, di lei si dirà che è una parasaito single, poi che è stata sfortunata, o che nessuno l’ha voluta. Le classi serali per adulti che ho tenuto per molti anni in un centro culturale di Osaka erano frequentate in gran parte da donne nubili che avevano superato la quarantina, ed erano altrettante personificazioni di una figura ormai in via di estinzione in Occidente: la zitella. Insegnanti o impiegate di livello medio-basso, tutte avevano in comune un atteggiamento un po’ teso, quasi l’aria di scusarsi di qualcosa, come se non si sentissero del tutto a posto per non aver potuto – o voluto – svolgere il ruolo di mogli e di madri che la società si attendeva da loro. Un’ombra di disagio sempre all’erta nel loro sguardo lasciava intuire fin dalla prima lezione che non erano mai state sposate.
Cinquanta matrimoni su cento dunque ancor oggi sono combinati, e a giudicare dalle statistiche vanno meglio di quelli d’amore. Il che non potrebbe stupire: chi fin dal principio non nutre grandi aspettative sentimentali, non avrà grandi delusioni. I due giovani che si sposano in seguito a un omiai non si conoscono ancora bene, ma appartengono alla stessa classe sociale, hanno vissuto in ambienti simili, condividono presumibilmente idee e abitudini, e nella misura in cui non domandano alla vita coniugale forti emozioni, non c’è motivo per cui non vadano d’accordo. Anche perché nei trent’anni seguenti non passeranno molto tempo insieme: nei giorni lavorativi si separeranno al mattino per ritrovarsi a tarda sera, solo nei fine-settimana e nei brevissimi periodi di ferie avranno qualche ora da dedicare alla vita di coppia e di famiglia. Questo fino a quando il marito andrà in pensione, ma nel frattempo avranno avuto modo di abituarsi l’uno all’altra. Tanto più che la donna giapponese tollera meglio di quanto farebbe un’occidentale i difetti di un uomo che ogni mese porti puntualmente a casa uno stipendio congruo.
È una prospettiva un po’ squallida per una ragazza come Atsuko, romantica come una quindicenne, che forse non riesce a trovare una persona accettabile fra i tanti giovani che le vengono presentati perché non ha mai rinunciato al sogno di un matrimonio d’amore. Passano così, fra tergiversazioni e altri rifiuti, sei mesi. Atsuko ha resistito più di quanto si aspettasse lei stessa, ma la soglia dei ventisette anni, e con essa lo spettro dello zitellaggio, si avvicina. La pressione della famiglia diventa sempre più forte. Perché non si rende indipendente, le chiedo, perché non va a vivere da sola? Teme forse il brusco passaggio da una vita agiata a una condizione modesta? No, non è questo che fa paura ad Atsuko, bensì l’idea di scontentare i genitori e di mettersi in contrasto con loro. La ribellione alla famiglia non è nella sua mentalità, come non lo è in quella della maggior parte dei giovani in questa società ancor oggi fortemente confuciana: regolata cioè dal principio dell’obbedienza al padre e alla madre, agli anziani e alle persone gerarchicamente superiori. Inoltre Atsuko non tiene molto al suo lavoro, noioso e ripetitivo, e la prospettiva – l’unica realistica – di continuare a svolgerlo per decenni non le sorride affatto; d’altronde l’ha sempre considerato soltanto una tappa. E così decide di accettare la proposta di quel pretendente che non ha mai rinunciato del tutto a lei e continua a telefonarle a intervalli regolari. Il poveraccio dev’essersi innamorato sul serio, e non molla. Considerato che non le piace nessuno, tanto vale scegliere quest’uomo capace di passione, che per lo meno la amerà.
Una volta presa la decisione, Atsuko è più serena. Probabilmente in famiglia l’atmosfera si è distesa, tutti sono contenti di lei, e il suo futuro marito la colma di attenzioni: le manda fiori e dolci, le fa bei regali, viene a prenderla spesso alle lezioni di danza per portarla fuori a cena, insomma è un fidanzato premurosissimo, sembra uscito da un romanzo dell’Ottocento. Ho l’occasione di conoscerlo anch’io: certo non è un Adone, piuttosto basso, a trent’anni ha già un po’ di pancia e un inizio di calvizie, ma ha una faccia simpatica e bonaria, e guarda la sua futura sposa con occhi adoranti. Sto quasi per convincermi che è riuscito a farsi voler bene, quando un pomeriggio una frase di Atsuko mi riempie di costernazione. Siamo sedute in un vagone semivuoto della metropolitana, di ritorno dalla lezione di piano, e io le ho chiesto di descrivermi l’appartamento che i suoi genitori hanno comprato per lei, in una bella zona residenziale. Atsuko comincia a spiegare, quando tutt’a un tratto, dopo un’esitazione, aggiunge con amarezza: «tanto, per quel che mi interessa... lui non mi piace neanche un po’…», poi tace. Sto per obiettare qualcosa, ma lei mi blocca con un gesto della mano che ha un significato chiaro e perentorio: è troppo tardi per tornare indietro. La sua educazione le impedisce di aggiungere che io non posso capire, ma probabilmente lo pensa. E ha ragione, tutto il mio essere si ribella contro la sua rassegnazione.
All’epoca la vicenda mi sembrava assurda, inconcepibile in una democrazia industriale del ventesimo secolo, sarebbe bastato che lei tornasse sulla sua decisione, poteva farlo anche all’ultimo momento. Mi veniva in mente il film New York-Miami, quando alla fine la sposa nel suo velo bianco fugge dalla chiesa attraverso il prato verde per buttarsi nelle braccia di Clark Gable. Ma il Giappone non è l’America dell’happy end, qui l’obiettivo perseguito non è il lieto fine ma l’interesse del gruppo; e il matrimonio non è l’affare di due individui ma di due gruppi, di due famiglie, e al di là di esse della società intera. In ogni circostanza d’altronde, se l’interesse del gruppo richiede il sacrificio del singolo, quest’ultimo deve sottomettersi e accettarlo, la rivolta è giudicata una manifestazione di irresponsabilità e di infantile egoismo. Shikata nai, «non c’è nulla da fare», è l’espressione che ricorre più spesso sulla bocca della gente, quando la rinuncia è troppo dolorosa, la realtà troppo dura da sopportare. Una remissività che può sconcertare noi occidentali, ma ha un lato positivo: rende i giapponesi estremamente forti di fronte alle avversità ineluttabili della vita.
Dopo tre mesi di fidanzamento i due fissano la data delle nozze, che avranno luogo di lì a poco in un lussuoso albergo di Osaka. Vengo invitata anch’io, senza mio marito, come vuole l’usanza. Sono tentata di rifiutare, sia per la tristezza che queste nozze mi infondono, sia perché comprare un regalo e un vestito adeguati all’occasione costituisce per me una spesa esorbitante. Poco dopo aver conosciuto Atsuko infatti ho trovato un impiego relativamente stabile in una scuola di lingue, e mio marito degli incarichi periodici di interpretariato, così ci siamo trasferiti in una vecchia casa in stile tradizionale in un villaggio a nord di Osaka. È vero che l’affitto è molto basso, ma la vita in Giappone è cara, e pur riducendo al minimo le spese, i soldi bastano appena. Mia suocera mi offre allora il suo aiuto, costernata che io voglia rinunciare a un’occasione di fare un’esperienza nuova e interessante: vuole comperare lei il regalo da portare agli sposi e confezionarmi – con le sue mani d’oro – un vestito adatto. La curiosità e il desiderio di un po’ di frivolezza prevalgono e accetto riconoscente tutto quanto, non sapendo ancora che ciò che mi attende non è una festa, ma un rigido rituale: per tutta la durata del banchetto molti degli invitati, dagli ex professori di università fino ai migliori amici di Atsuko e del marito, pronunceranno lunghi discorsi a elogio degli sposi, i quali resteranno seduti ad ascoltare in religioso silenzio. Una noia mortale. Unica nota positiva il cibo, che è ottimo (ma ritroverò lo stesso menù – aragosta Termidoro, filetto di manzo con salsa béarnaise – a tutti i matrimoni a cui verrò invitata in seguito; qualche variante la offrirà soltanto la torta nuziale, che non è però quella che viene tagliata dagli sposi. Quella è finta, tre o quattro piani di cartapesta, di vera c’è solo una piccola fetta dove poter affondare il coltello). Allo sposo il cerimoniale concede di mangiare qualcosa, mentre la sposa è preferibile che non tocchi cibo, d’altronde non ci riuscirebbe neanche, col pesante trucco che le incrosta la faccia. Inoltre deve allontanarsi spesso per cambiarsi d’abito, dopo il magnifico kimono nuziale bianco, che ha indossato durante il breve rito shintoista celebrato solo davanti ai familiari, ne mette uno rosso, altrettanto fastoso, poi un abito da sposa bianco all’occidentale, un vestito tutto pizzi e fronzoli degno di Rossella O’Hara. In quest’ultima fase anche lo sposo si cambia, per indossare un tight bianco, secondo l’usanza americana. A questo punto i due, che rispettando la tradizione avevano fatto il loro primo ingresso in sala a tre passi di distanza, lui davanti e lei dietro, devono entrare sottobraccio. Ma la maggior parte delle coppi...