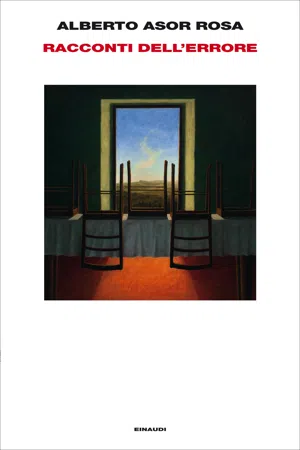![]()
![]()
Dopo trentotto anni di lavoro in banca, Umbertino decise di andare in pensione. Un po’ di conti son presto fatti: ne aveva ventidue quando c’era entrato; ne uscí a sessanta. Veramente, – come si dice in linguaggio burocratese-sindacale, – lui in questo modo non aveva raggiunto il «massimo della pensione». E però se n’andò lo stesso. Come mai? Perché «s’era stufato». La cosa è assolutamente notabile: e perciò va notata. Umbertino, – piú esattamente: Umberto D’Avanzo, – in tutta la sua vita non aveva fatto una cosa, una cosa sola, che non rientrasse pari pari nell’ordine costituito. Ossia: mai una volta che avesse infranto una regola; di passaggio in passaggio, di stagione in stagione, di età in età, aveva sempre fatto, con docilità sorprendente, quel che tutti si aspettavano che facesse, quello che disposizioni, scadenze, ordinamenti e ordini gli imponevano di fare. Un po’ di storia servirà a rimettere a posto le cose e a far capire meglio carattere e scelte di Umbertino.
Umbertino era nato, – sessant’anni prima, appunto, – nel cuore di un vecchio e lurido quartiere popolare, un borgo, per dirla alla teutonica, stretto fra altissime e magnificenti quinte celestiali e file ininterrotte di palazzoni ottocenteschi, dove comodamente allignava l’ala piú bottegaia e rapace della borghesia cittadina. In quel quartiere, anzi in quel borgo, tutti allora si conoscevano, e Umbertino bambino passava ilare e felice da una carezza all’altra, senza accorgersi invece d’essere troppo solo. Suo padre, il sor Fausto, un piccolo geometra di origine meridionale, e sua madre, la sora Lella, invece autenticamente borghigiana, erano stati due trucidoni, preoccupati piú che altro «de magnà bene» e «de fasse ogni tanto ’na scopata come se deve». Poi il sor Fausto, invadente e irritabile, per fortuna era morto, e Umbertino, dai dodici anni in su, era rimasto affidato alle cure della sora Lella, affettuosa, sempre preoccupata per lui e un po’ autoritaria. Umbertino aveva frequentato le elementari in una scuoletta di preti (che lí, nel vecchio borgo, ci stavano come fosse casa loro); poi le medie, e l’istituto tecnico commerciale, in un complesso statale incistato nel vecchio quartiere, in uno slarghetto che stava piú esattamente fra il vecchio quartiere e i palazzoni borghesi circonvicini. Aveva fatto tutte le scuole bene, ossia, dal punto di vista degli insegnanti, mediocremente («senza infamia e senza lode», soleva ripetere perplessa la sora Lella alle sue numerose amiche). Com’è, come non è, a diciott’anni si trovò diplomato (ossia ragioniere: specializzato, per modo di dire, in contabilità).
Per qualche anno Umbertino aveva poi bighellonato per il quartiere, superandone di rado i confini, spostandosi insieme con qualche coetaneo disutile come lui da un baretto all’altro, approdando talvolta a un cinemetto sporco e semicadente, che stava proprio in fondo a quel vecchio agglomerato di case, dove, senza trarne gran gusto, vedeva film italiani vecchi di almeno un decennio e western americani di terz’ordine. È impressionante constatare, e osservare, come tutte queste esperienzelle scivolassero su di lui senza lasciare traccia. Quando rientrava in casa, era appena in grado di raccontare alla sora Lella qualche brandello di trama, oppure una o due battute, che lo avevano piú colpito. Siccome quello di cui lui visionava gli esemplari era stato prevalentemente il cinema italiano della commedia facile e delle battute prorompenti, Umbertino avrebbe dovuto almeno ridere molto. Invece non accadeva quasi mai, e, quando accadeva, poco. A Umbertino tutto appariva finto, ma cosí finto, che non c’era modo di appassionarsene fino al punto di ridere a crepapelle (o, se si trattava di opere drammatiche e tristi, di farsi scivolare giú dagli occhi qualche lagrima, come invece assai spesso accadeva ai suoi coetanei e compagni di spettacolo, tanto sentimentali quanto stupidi). Al massimo, qualche risatina, un piccolo partecipe commento. E siccome Umbertino non aveva letto, né avrebbe mai letto, in vita sua un solo libro, o anche un solo numero di giornale, si potrebbe arrivare a dire con una battuta che le sue attività intellettuali erano prossime allo zero, che il suo cerebro produceva soltanto gli elementi essenziali per uscire di casa in orario la mattina e rientrarvi in tempo la sera con lo scopo di consumare il pasto frugale che la sora Lella gli faceva trovare infallibilmente sul freddo piano di marmo della tavola di cucina.
Alla fine, quando le sorti di Umbertino sembravano andare ormai alla deriva, uno zio di sua madre, anche lui borghigiano autentico, l’unico parente che apparisse ancora interessato alle sue sorti, – pensando che di lí a qualche anno il nipote, se lasciato a se stesso, sarebbe finito sotto un ponte –, gli trovò un posto in una banca, di cui era stato in passato faccendiere.
Per qualche anno Umbertino fece di tutto, dal calcolo solitario degli stipendi, suo e dei colleghi, chiuso in una stanzetta nel retro, all’addobbo del comunitario albero di Natale. Poi un direttore, dallo sguardo piú acuto, credette di scoprire in quel totale anonimato le virtú tipiche (che pure ci sono) di una totale assenza intellettuale; e lo spedí alla cassa. Lí Umbertino diede il meglio di sé, cavandolo senza sforzo esattamente da quanto con ogni evidenza gli mancava, e non avrebbe mai avuto. Siccome era privo d’ogni possibile forma di immaginario, – ossia non gli capitava mai di pensare a qualcosa che fosse piú lontana della punta del suo naso, – fu preciso, attento, gentile e infaticabile lavoratore. Era capace di stare sei-sette ore incollato allo sportello della cassa senza neanche avvertire il bisogno di andare a orinare. Quanto ai conti, siccome gli erano come il resto del tutto indifferenti, si rivelò di una precisione e di una correttezza assolute: non solo li faceva con un automatismo perfetto, che ricordava quello di un computer; ma anche non sentiva sorgere in sé, né di prima botta né di riscontro, quella seduzione del piccolo personale prelievo (tecnicamente: ammanco), di cui notoriamente molti dei suoi colleghi soffrivano. Dietro quello sportello restò trentaquattro anni. Cosí ci siamo: in banca a ventidue; quattro perché l’astuto direttore scoprisse, dietro quella facciata piatta come una superficie senza forma, le sue virtú segrete; a ventisei andò alla cassa; ne uscí a sessanta, dopo trentaquattro passati appollaiato su di uno sgabello per giunta un po’ traballante, ma che gli sosteneva comodamente il deretano e la schiena.
Gliene avanzavano altri due per andarsene, appunto, con il «massimo della pensione». Come mai se ne andò in anticipo, rinunciando al tempo stesso a un posto di lavoro assai considerato, e da lui, come s’è detto, praticato con una sorta di straordinaria agevolezza, e a una fettina non trascurabile della retribuzione post-lavorativa, che gli sarebbe spettata? Neanche Umbertino se lo spiegava con chiarezza. Tuttavia, se qualcuno glielo avesse chiesto, e perciò gli avesse imposto di pensarci, crediamo che avrebbe risposto: «Non ne potevo piú». Se quest’ipotesi fosse vera, ne ricaveremmo un altro tratto importante, finora sconosciuto, del modo d’essere di Umbertino. «Non ne potevo piú» voleva dire: tutto è possibile, tutto, ma proprio tutto, finché la misura non è colma.
Ma la misura, dopo migliaia e migliaia di ore passate dietro quello sportello, dopo milioni di calcoli eseguiti per far quadrare i conti, dopo le innumerevoli giornate trascorse nel lucore indistinto e nel chiacchiericcio assordante di una agenzia di banca, simile a una inospite caverna frequentata da trogloditi, era evidentemente colma. Umbertino non ne aveva piú voglia. O per meglio dire: non ne aveva mai avuto voglia (non gl’importava nulla di fare questo o quello); ma perché l’assenza congenita di voglia non sbocciasse in una sorta di rifiuto categorico, era necessario che tra lui e la voglia di fare ci fosse almeno un pallido simulacro, l’assenza, appunto, del rifiuto, per quanto, per cosí dire, neanch’esso condiviso fino in fondo. E, – tratto caratteriale anche questo assai rilevante, – Umbertino era capace di fare di tutto, restando completamente indifferente a quel che faceva: ma per farlo, aveva bisogno d’essere disponibile a farsi trattare lui come uno strumento anonimo e totalmente disponibile. Se la disponibilità a essere usato gli veniva meno, non c’era modo di fermarlo: nell’andarsene era capace d’essere piú cocciuto di quanto lo sarebbe stato s’avesse deciso di restare (come, certo, piú frequentemente gli accadeva).
Cosí fu quella volta: i dirigenti della banca cercarono in tutti i modi di fermarlo, perché Umbertino era utile, anzi utilissimo, ai loro traffici. Ma quando s’accorsero che non c’era niente da fare, lasciarono perdere con una certa facilità. Umbertino, a parte le sue caratteristiche pratiche e utilitarie, non aveva nessun tratto che contribuisse a farne desiderare piú a lungo la permanenza: simpatia, affabilità, intelligenza, niente di tutto questo, ovviamente, ma neanche qualcosa di immediatamente secondario e minore, che so, la semplice percezione che dietro quella faccia assolutamente anonima ci fosse un individuo disposto a comunicare e magari a farsi voler bene. No: nessuno dei suoi dirigenti, e neanche dei suoi colleghi, aveva mai avvertito qualcosa del genere. Espletati i dovuti, professionali tentativi, Umbertino fu liquidato su due piedi, e in men che non si dica nessuno si ricordò piú minimamente di lui.
Cosí fu restituito totalmente alla vita di quartiere. A sessant’anni, però, non era la stessa cosa che a diciotto. Umbertino era un uomo di media statura, né grasso né magro, con una capigliatura liscia, di capelli marroncini esili esili, che con l’età s’erano un poco diradati, due occhi chiari chiari (non molto espressivi, a dir la verità), e una carnagione bianca, ma cosí bianca, da attirare l’attenzione: sembrava una signora d’altri tempi, che avesse passato la sua vita a coprirsi di trine e pizzi per difendersi dai raggi mordenti del sole. Siccome per antica abitudine bancaria Umbertino indossava sempre un vestito intiero, in genere di colore scuro (sempre con la cravatta, finché andò in banca; poi piú senza, ma con il solino della camicia bianca chiuso da un bottoncino, sempre), contro tutti i suoi desideri e aspettative si distingueva a prima vista in quel quartiere di scamiciati e di trucidoni: questo serví a impedirne il completo riassorbimento e a far pensare ai suoi correligionari che Umbertino, sí, forse era tornato, ma forse continuava a non esserci.
Da giovane, cosí tirato a lucido, avrebbe potuto sembrare, se non piacente, almeno di tollerabile aspetto. Ma di avventure sentimentali non c’è traccia nella storia della sua vita (tornerò su questo punto). La sua educazione sessuale fu, come per tutti gli altri giovani del quartiere (come per tutti gli altri giovani di quella città e di quella fase storica) di tipo postribolare. Al di là del ponte, che scavalcando il vecchio fiume metteva in comunicazione le due parti piú consistenti della grande e lurida città, di bâtiments addetti alla bisogna ce n’era quanti se ne voleva, di tutte le qualità e di tutti i prezzi. I giovani del quartiere sceglievano in primis quelli di piú basso prezzo, cioè gli infimi: piú che averne voglia, anche qui, bisognava sforzarsi di reprimere il disgusto. Qualche volta, però, Umbertino, tenendo conto una volta tanto delle proprie voglie e fronteggiando le insistenze contrarie dei suoi piú accomodanti compagni, rinunciava a qualcuno di quei conviti non proprio esaltanti, metteva da parte un po’ di soldini e si concedeva il lusso di un incontro di gran classe. E però, anche lí, Umbertino non riusciva facilmente a liberarsi da un’impressione devastante di falsità, anzi di menzogna, che gli vanificava il desiderio di piacere accumulato lentamente nei lunghi giorni dell’attesa: alla fine, uscendo di corsa da uno di quei luoghi di lusso, gli accadeva di pensare con una certa nostalgia a quelle povere, disperate mignottine di quart’ordine, che elemosinavano senza tentare di celarsi dietro la finzione i pochi soldi che gli servivano per mantenere un figlio illegittimo o un pappa insaziabile.
Ma a questo, ovviamente, Umbertino non poteva certo tornare, sia per motivi di età sia per motivi di dignità, sia soprattutto perché nel frattempo una mano benefica, anzi provvidenziale, aveva pensato di sopprimere le case ospitali di cui sopra (con grande beneficio, si dice abitualmente, per il costume pubblico, in particolare quello giovanile). Cosí la vita di quartiere fu da quel momento in poi per lui qualche passeggiata in su e in giú per vie e vicoli maleodoranti, di cui quel luogo era incredibilmente ricco, qualche sosta in uno dei bar e baretti della zona, dove Umbertino incontrava i suoi amici o amiche d’infanzia o di adolescenza (quanto mai, anche loro, diradati di numero, e i superstiti vistosamente depilificati e traballanti sulle gambe) e ci faceva quattro chiacchiere (il tempo, la salute, con i piú depravati lo sport, con qualcuno ancora piú depravato le porcherie e le infamie dell’ultimo governo in carica: ma su questi ultimi due punti Umbertino, che ne era totalmente disinteressato e disinformato, esibiva soltanto apprezzamenti vaghi e generici o, piú spesso, solo un sorrisetto di condivisione). Quanto alle magnificenti quinte celestiali, e alle loro reiterate, e talvolta prepotenti e invasive manifestazioni di ultrapotenza, di cui il quartiere subiva sovente la scomoda contiguità, Umbertino c’era cresciuto insieme, sapeva che come invadevano, cosí si sarebbero presto ritirate, rifugiandosi dietro i sacri portoni: non c’era che da aspettare pazientemente, magari restandosene rintanato in casa, poi tutto come sempre sarebbe tornato come prima. Del resto, – per affrontare anche questo argomento, – nei confronti delle magnificenze celestiali Umbertino ostentava il suo solito atteggiamento che non era né di rifiuto né di accettazione. Prudentemente, Umbertino non avrebbe mai detto se ci credeva oppure no: ma neanche se gli facevano schifo oppure lo facevano delirare. Chi sa: qualche segno di devozione gli scappava (era quello che tutti gli abitanti di quel quartiere erano abituati a fare da tempo immemorabile, il loro codice genetico plurisecolare, per cosí dire, glielo imponeva); ma metterci la mano sul fuoco, beh, quello no, le magnificenze celestiali erano troppo contigue alla sua misera vita, gli erano troppo famigliari, anzi domestiche, perché lui potesse provarne la soggezione che qualsiasi fede inevitabilmente richiede.
Da quando Umbertino era rientrato in pianta stabile nel quartiere, era uscito di casa sua. Come, uscito? Sí, uscito dalla casa dov’era nato, e aveva trascorso i primi sessant’anni della sua vita. La sora Lella ora ne aveva raggiunti ottantadue: con l’età s’era arrotondata come una vecchia botte panciuta, e la sua querimoniosità aveva superato ogni limite. Da bambino Umbertino non aveva potuto opporre resistenza ai suoi abbracciamenti festosi, che lo spiaccicavano contro il seno gonfio e molle di lei, né ai baci e bacetti, rigogliosi di tracce umide, che gli venivano ad ogni occasione spalmati sul volto. Insomma, per lui la sora Lella aveva sempre rappresentato una sorta di schermo a un rapporto simpatetico e consensuale con il mondo (chi s’intende di psicanalisi e di altre diavolerie del genere, saprà dare i nomi adatti ai vari aspetti di questa fenomenologia, che qui stiamo esponendo in forma superficiale e approssimativa): quando gli accadeva di pensare alle ragazze (cioè alle donne), era l’immagine della sora Lella che si levava a far da paravento a qualsiasi, per quanto modestissima e normale, immaginazione di tipo sessuale. Crescendo, Umbertino, naturalmente, aveva cominciato a prendere le distanze. Ma proprio allora la sora Lella aveva iniziato ad affrontarlo sempre piú sistematicamente. Quel figlio che cresceva da solo in casa sua le era sembrato un’anomalia da sanare. Alle amiche del quartiere non faceva che ripetere: «Ma sto fijo mio come mai nun se sistema? Come mai nun se sistema?» Perciò, fin da quando lui aveva avuto venti-ventidue anni, lei non s’era mai stancata di additargli e proporgli questa o quella ragazza del quartiere, che, ovviamente, insieme con Umbertino era cresciuta, riempiendosi a poco a poco delle giuste curve rotondeggianti e di tutte le moine e ammiccamenti, voluti o no, che testimoniassero della loro disponibilità a prendere in esame un candidato qualsiasi. Da quando poi Umbertino era stato assunto in banca, lí era diventato (come si dice) un buon partito: sicché, se da una parte la sora Lella aveva infittito le sue gratificazioni e raccomandazioni, dall’altra qualche occhiata d’interessato gradimento gli arrivava dalle medesime fanciulle che costituivano l’oggetto di quello scambio diseguale fra madre e figlio: «Umberti’, e perché nun esci con Sabrina? E perché nun vai al cinema con Vanessa? Umberti’, nun hai visto che bei occhi che c’ha Serena? Nun hai visto che belle gambe che je so’ spuntate a Felicina?» Umbertino, quando la madre l’assediava con le sue chiacchiere, guardava svagato qua e là, sprofondava in qualche suo insondabile pensiero, faceva uno strano sorrisetto, poi quando non ne poteva piú invariabilmente s’alzava in piedi, si preparava a uscire e le diceva: «Ciao, ma’, ce vedemo». Ma a ogni ritorno in casa, il fiotto ricominciava. Giunto ormai alle soglie dei quarant’anni, una volta che l’infinita querimonia era ricominciata, Umbertino, invece di alzarsi e andarsene, guardò diritto la madre negli occhi, e, con un’inflessione che lei non aveva mai conosciuto, e perciò la impressionò molto, le disse: «E mò, basta, ma’. Mò basta». E cosí fu finita (e per sempre).
Ma a sessanta l’idea di trascorrere piú o meno l’intera giornata da pensionato con la sora Lella ottantaduenne fra i piedi gli sembrò esagerata. Si trovò un quartierino di due stanze e cucina a tre portoni di distanza da quello di sua madre, e cominciò finalmente a quell’età la sua vita da scapolo. Magari andava a trovarla un giorno sí e un giorno no a casa sua, e magari una volta alla settimana la portava a fare una passeggiata nell’abbraccio, enormemente vasto e accogliente, dell’immensa piazza celestiale. Ma quando s’alzava la mattina, e quando s’addormentava la sera, stirando in un caso come nell’altro le braccia cortine verso l’alto come per afferrare un refolo d’aria, almeno era e almeno si ritrovava tranquillamente solo, senza quella vivente rottura di coglioni in agguato nella stanza accanto.
Certo, c’era poco da divertirsi. Umbertino, – l’abbiamo già detto, – non leggeva, non amava quei diabolici strumenti di (presunta) ricreazione mentale, che a comando trasmettono immagini e parole senza sosta, non aveva grandi amicizie con cui colloquiare. Quando stava in casa, pensava. Ma a che pensava, se non aveva niente a cui pensare? Se fosse stato còlto, molto còlto, si sarebbe detto che stava come dentro un flusso esistenziale che non aveva né peso né consistenza, e che lui s’accontentava di esserci: perché tanto, se avesse deciso di non accontentarsi, che cosa avrebbe potuto fare per non farlo? Qualche ricordo d’infanzia, qualche lacerto di indefiniti entusiasmi adolescenziali, il lungo inesauribile tessuto, sempre uguale, sempre uniforme e indistinto, della professione bancaria… o, piú semplicemente, chiedersi se aveva in casa gli ingredienti giusti per prepararsi una buona minestra quella sera, oppure per la pastasciutta del giorno dopo, una pallida previsione (sempre la stessa, del resto) per i giorni successivi (la passeggiata, il bar, qualche chiacchiera con gli amici all’angolo della farmacia di quartiere). Insomma, nei suoi limiti se la cavava. Non fu toccato mai, mai, dall’idea che la sua vita avrebbe potuto essere diversa (diversa come? mah). Qualche volta, a dir la verità, gli accadeva di afferrare, in quel contenitore elementare che era il suo cervello, come le tracce di pensieri che partivano da lui e se ne andavano misteriosamente da qualche altra parte, senza che lui potesse farci niente. Ma era affare di pochi attimi. A Umbertino le cose invece piacevano povere e limitate ma precise, riconoscibili e banalmente comprensibili. Di quell’eco che invece le deformava, trasformandole in fanfaluche, arzigogoli, illusorie deformazioni del reale, non sapeva che farsene, preferiva il suono diretto ed elementare delle cose, che era in grado di raccogliere fisicamente con l’orecchio, senza bisogno di prestare attenzione all’eco ingannevole che qualche volta gliene rimbalzava dal cervello.
Quando era stanco di pensare (a modo suo, s’intende, come abbiamo cercato di spiegare) usciva. Faceva una piccola passeggiata, prendeva un cappuccino al bar, attaccava quattro chiacchiere con gli amici all’angolo della farmacia di quartiere. Una sola, e rara, variante si consentiva. Bisogna tener conto del fatto che in quella grande e lurida città, all’interno della quale il borgo dall’eternità si collocava, ci sono giornate in cui il sole illumina una realtà che potenzialmente potrebbe essere del tutto diversa (e forse è) da quella che comunemente si vede. La luce scende dall’alto confortante e gradevole, né troppo calda né troppo smorzata; agli angoli degli edifici le ombre prendono la morbida corposità di un elegante addobbo di chiesa; le bellezze architettoniche, artistiche e, sí, anche femminili, che popolano fittamente da tempo immemorabile quel pezzo di mondo, confliggendo con i suoi altrettanto innumerevoli luridumi e sporcizie (in gergo locale: zozzerie), assumono un nuovo vigore, riprendono con forza la loro incrollabile vita secolare. Se ci fosse consentita una variante letteraria (o addirittura poetica), diremmo che, in quei momenti, la natura riprende il sopravvento sull’umano artefatto, o, meglio, miracolosamente s’incorpora in esso. Accade anche altrove? Chi lo sa; ma qui di sicuro accade, ed è per questo che talvolta le zozzerie vengono obliate, e lo splendore di quella luce miracolosamente (e anche un po’ ironicamente, – nei confronti, s’intende, delle molteplici miserie degli umani) trionfa.
Quando questo accadeva, Umbertino, – il quale dai tempi della banca era abituato ad alzarsi presto, – scendeva dal letto, apriva una finestrella che dava su una fuga di tetti di cotto tutt’intorno e spingeva lo sguardo fuori. Quel che vedeva gli metteva una strana agitazione in cuore: era come se, da lontano, gli arrivasse una frustatina a non starsene anche quel giorno accoccolato da mane a sera nel suo dimesso pensatoio o ad andarsene bighellonando senza scopo, dal baretto al lattaio, dal lattaio al negozio di ferramenta, a raccontarsi sempre le medesime cose, a sbattersi senza scopo da un cantone all’altro del suo borgo. In casi del genere, Umbertino, dopo essersi vestito come al solito, usciva di casa, attraversava come al solito la sua vecchia tana (per forza, come avrebbe potuto fare altrimenti?), imboccava una delle porte semi-preistoriche che si aprivano, bene o male, nella sua cinta muraria, e sboccava con insolita soddisfazione su di un immenso spiazzo, che, da una parte poneva fine al vecchio quartiere, dall’altra abbracciava un’altrettanto vecchia, e gigantesca, mole edilizia, che prima era stata un tumulo principesco, poi una celestiale fortific...