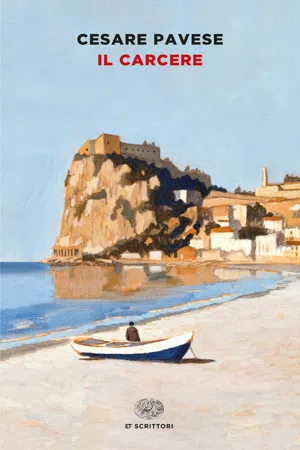![]()
Cesare Pavese
Il carcere
![]()
Nel 1935 Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, Cuneo, 1908 - Torino, 1950) venne condannato a tre anni di confino perché aveva tentato di proteggere la donna amata, militante del Pci. Due di quei tre anni gli furono successivamente condonati, ma l’esperienza della vita al confino, in un luogo cosí lontano dal suo mondo piemontese come Brancaleone Calabro, non fu senza conseguenze nell’opera dello scrittore. Quando, però, provò a scrivere di quel suo anno coatto al sud, dapprima nel 1936 nel racconto Terra d’esilio, e poi in un componimento piú lungo steso tra il 27 novembre 1938 e il 16 aprile 1939 sotto il titolo Memorie da due stagioni (che è il testo che qui presentiamo con il titolo Il carcere attribuitogli alla fine), Pavese aveva già subíto altre esperienze fondamentali. A partire dalla constatazione, al suo ritorno a Torino, di non potere assolutamente contare sull’affetto della donna per cui si era attirato le punizioni fasciste.
Il carcere, pubblicato da Pavese solo nel 1948 (insieme con un altro romanzo breve o racconto lungo, La casa in collina, sotto il titolo comune Prima che il gallo canti di trasparente allusione) è una storia di privata solitudine. Recita una nota del diario pavesiano Il mestiere di vivere, in data 24 ottobre 1938, ovvero circa un mese prima dell’inizio della stesura di Memorie da due stagioni: «Ma ora succede che proprio il raccontare un fatto e un personaggio, è fare l’oziosa creazione fantastica perché a questo raccontare si riduce il concetto tradizionale di poesia. Per scrivere mirando a qualche altro scopo, ora bisogna proprio lavorare di stile, cercare cioè di creare un modo d’intendere la vita... che sia una nuova conoscenza. In questo senso va accettata la mia antica mania di fare argomento della composizione l’immagine, di raccontare il pensiero, di uscire dal naturalismo. Questo non è fantasticare ma conoscere: conoscere che cosa siamo noi nella realtà. Ecco soddisfatta l’esigenza di credere avvenuto quello che stiamo per raccontare...»
Il carcere riprende in terza persona quanto Pavese aveva già cercato di narrare prima in Terra d’esilio. Il confino dell’ingegnere Stefano diventa metafora di una condizione esistenziale di solitudine, metà condanna metà alibi del suo chiamarsi fuori dal mondo, a guardare la vita «come dalla finestra del carcere». L’ingegnere è un intellettuale che imputa a se stesso piú che al mondo la responsabilità della propria situazione, rifiutando di riconoscere una qualche giustificazione politica al suo soggiorno a Brancaleone Calabro proprio nel periodo di maggior consenso degli italiani al regime fascista, tra la guerra d’Abissinia e quella di Spagna. Ringraziando Emilio Cecchi per una favorevole recensione a Prima che il gallo canti, Pavese ammise il 17 gennaio 1949 di essersi vergognato a lungo de Il carcere come di una ricaduta nel solipsismo, ma di essersi reso conto, scrivendo dieci anni dopo La casa in collina, di sentirsi legato ancora al problema. Di qui la pubblicazione dei due testi a confronto. Il carcere è il primo grande risultato della maturità di Cesare Pavese, anche se il pubblico l’ha conosciuto solo sette anni dopo l’apparizione in libreria, nel 1941, di Paesi tuoi, romanzo breve o racconto lungo scritto successivamente a Il carcere dal 3 giugno al 6 agosto 1939.
![]()
![]()
Stefano sapeva che quel paese non aveva niente di strano, e che la gente ci viveva, a giorno a giorno, e la terra buttava e il mare era il mare, come su qualunque spiaggia. Stefano era felice del mare: venendoci, lo immaginava come la quarta parete della sua prigione, una vasta parete di colori e di frescura, dentro la quale avrebbe potuto inoltrarsi e scordare la cella. I primi giorni persino si riempí il fazzoletto di ciottoli e di conchiglie. Gli era parsa una grande umanità del maresciallo che sfogliava le sue carte, rispondergli: – Certamente. Purché sappiate nuotare.
Per qualche giorno Stefano studiò le siepi di fichidindia e lo scolorito orizzonte marino come strane realtà di cui, che fossero invisibili pareti d’una cella, era il lato piú naturale. Stefano accettò fin dall’inizio senza sforzo questa chiusura d’orizzonte che è il confino: per lui che usciva dal carcere era la libertà. Inoltre sapeva che dappertutto è paese, e le occhiate incuriosite e caute delle persone lo rassicuravano sulla loro simpatia. Estranei invece, i primi giorni, gli parvero le terre aride e le piante, e il mare mutevole. Li vedeva e ci pensava di continuo. Pure, via via che la memoria della cella vera si dissolveva nell’aria, anche queste presenze ricaddero a sfondo.
Stefano si sentí una nuova tristezza proprio sulla spiaggia un giorno che, scambiata qualche parola con un giovanotto che s’asciugava al sole, aveva raggiunto nuotando il quotidiano scoglio che faceva da boa.
– Sono paesacci, – aveva detto quel tale, – di quaggiú tutti scappano per luoghi piú civili. Che volete! A noi tocca restarci.
Era un giovane bruno e muscoloso, una guardia di finanza dell’Italia centrale. Parlava con un accento scolpito che piaceva a Stefano, e si vedevano qualche volta all’osteria.
Seduto sullo scoglio col mento sulle ginocchia, Stefano socchiudeva gli occhi verso la spiaggia desolata. Il grande sole versava smarrimento. La guardia aveva accomunata la propria sorte alla sua, e l’improvvisa pena di Stefano era fatta di umiliazione. Quello scoglio, quelle poche braccia di mare, non bastavano a evadere da riva. L’isolamento bisognava spezzarlo proprio fra quelle case basse, fra quella gente cauta raccolta fra il mare e la montagna. Tanto piú se la guardia – come Stefano sospettava – solo per cortesia aveva parlato di civiltà.
La mattina Stefano attraversava il paese – la lunga strada parallela alla spiaggia – e guardava i tetti bassi e il cielo limpido, mentre la gente dalle soglie guardava lui. Qualcuna delle case aveva due piani e la facciata scolorita dalla salsedine; a volte una fronda d’albero dietro un muro suggeriva un ricordo. Tra una casa e l’altra appariva il mare, e ognuno di quegli squarci coglieva Stefano di sorpresa, come un amico inaspettato. Gli antri bui delle porte basse, le poche finestre spalancate, e i visi scuri, il riserbo delle donne anche quando uscivano in istrada a vuotare terraglie, facevano con lo splendore dell’aria un contrasto che aumentava l’isolamento di Stefano. La camminata finiva sulla porta dell’osteria, dove Stefano entrava a sedersi e sentire la sua libertà, finché non giungesse l’ora torrida del bagno.
Stefano, in quei primi tempi, passava insonni le notti nella sua catapecchia, perch’era di notte che la stranezza del giorno lo assaliva agitandolo, come un formicolio del sangue. Nel buio, ai suoi sensi il brusio del mare diventava muggito, la freschezza dell’aria un gran vento, e il ricordo dei visi un’angoscia. Tutto il paese di notte s’avventava entro di lui sul suo corpo disteso. Ridestandosi, il sole gli portava pace.
Stefano seduto davanti al sole della soglia ascoltava la sua libertà, parendogli di uscire ogni mattina dal carcere. Entravano avventori all’osteria, che talvolta lo disturbavano. A ore diverse passava in bicicletta il maresciallo dei carabinieri.
L’immobile strada, che si faceva a poco a poco meridiana, passava da sé davanti a Stefano: non c’era bisogno di seguirla. Stefano aveva sempre con sé un libro e lo teneva aperto innanzi e ogni tanto leggeva.
Gli faceva piacere salutare e venir salutato da visi noti. La guardia di finanza, che prendeva il caffè al banco, gli dava il buon giorno, cortese.
– Siete un uomo sedentario, – diceva con qualche ironia. – Vi si vede sempre seduto, al tavolino o sullo scoglio. Il mondo per voi non è grande.
– Ho anch’io la mia consegna, – rispondeva Stefano. – E vengo da lontano.
La guardia rideva. – Mi hanno detto del caso vostro. Il maresciallo è un uomo puntiglioso, ma capisce con chi ha da fare. Vi lascia persino sedere all’osteria, dove non dovreste.
Stefano non era sempre certo che la guardia scherzasse, e in quella voce chiara sentiva l’uniforme.
Un giovanotto grasso, dagli occhi vivaci, si fermava sulla porta e li ascoltava. Diceva a un tratto: – Mostrine gialle, non ti accorgi che l’ingegnere ti compatisce e che lo secchi? – La guardia, sempre sorridendo, scambiava un’occhiata con Stefano. – In questo caso, tu saresti il terzo incomodo.
Tutti e tre si studiavano, chi pacato e chi beffardo, con un vario sorriso. Stefano si sentiva estraneo a quel gioco e cercava di equilibrare gli sguardi e di coglierne il peso. Sapeva che per rompere la barriera bastava conoscere la legge capricciosa di quelle impertinenze e prendervi parte. Tutto il paese conversava cosí, a occhiate e canzonature. Altri sfaccendati entravano nell’osteria e allargavano la gara.
Il giovane grasso, che si chiamava Gaetano Fenoaltea, era il piú forte, anche perché stava di fronte all’osteria, nel negozio di suo padre, padrone di tutte quelle case, e per lui attraversare la strada non era abbandonare il lavoro.
Questi sfaccendati si stupivano che tutti i giorni Stefano se ne andasse alla spiaggia. Qualcuno di loro veniva con lui ogni tanto; gli avevano anzi indicata loro la comodità dello scoglio; ma era soltanto per compagnia o per un estro intermittente. Non capivano la sua abitudine, la giudicavano infantile: nuotavano e conoscevano l’onda meglio di lui, perché ci avevano giocato da ragazzi, ma per loro il mare non voleva dir nulla o soltanto un refrigerio. L’unico che ne parlò seriamente fu il giovane bottegaio che gli chiese se prima, via, prima del pasticcio, andava a fare la stagione sulla Riviera. E anche Stefano, benché certe mattine uscisse all’alba e andasse da solo sulla sabbia umida a vedere il mare, cominciò, quando sentiva all’osteria che nessuno sarebbe venuto quel giorno con lui, a temere la solitudine e ci andava soltanto per bagnarsi e passare mezz’ora.
Incontrandosi davanti all’osteria, Stefano e il giovane grasso scambiavano un semplice cenno. Ma Gaetano preferiva mostrarsi quando già c’era crocchio, e senza parlare direttamente con Stefano, soltanto canzonando gli astanti, lo isolava in una sfera di riserbo.
Dopo i primi giorni divenne loquace anche con lui. Di punto in bianco lo prendeva calorosamente sotto braccio, e gli diceva: – Ingegnere, buttate ’sto libro. Qui non abbiamo scuole. Voi siete in ferie, in villeggiatura. Fate vedere a questi ragazzi che cos’è l’Altitalia.
Quel braccetto era sempre cosí inaspettato, che a Stefano pareva come quando, adolescente, aveva, col cuore che batteva, avvicinato donne per strada. A quell’esuberanza non era difficile resistere, tanto piú che lo metteva in imbarazzo davanti agli astanti. Stefano s’era sentito troppo studiato da quegli occhietti nei primi giorni, per poterne adesso accettare senz’altro la cordialità. Ma il buon viso di Gaetano voleva dire il buon viso di tutta l’osteria, e Gaetano, per quanto, quando voleva, squadrasse freddamente l’interlocutore, aveva l’ingenuità della sua stessa autorevolezza.
Fu a lui che Stefano domandò se non c’erano delle ragazze in paese, e, se c’erano, come mai non si vedevano sulla spiaggia. Gaetano gli spiegò con qualche impaccio che facevano il bagno in un luogo appartato, di là dalla fiumara, e al sorriso canzonatorio di Stefano ammise che di rado uscivano di casa.
– Ma ce ne sono? – insisté Stefano.
– E come! – disse Gaetano sorridendo compiaciuto. – La nostra donna invecchia presto, ma è tanto piú bella in gioventú. Ha una bellezza fina, che teme il sole e le occhiate. Sono vere donne, le nostre. Per questo le teniamo rinchiuse.
– Da noi le occhiate non bruciano, – disse Stefano tranquillo.
– Voialtri avete il lavoro, noi abbiamo l’amore.
Stefano non provò la curiosità di andare alla fiumara per spiare le bagnanti. Accettò quella tacita legge di separazione come accettava il resto. Viveva in mezzo a pareti d’aria. Ma che quei giovani facessero all’amore, non era convinto. Forse nelle case, dietro le imposte sempre chiuse, qualcuno di quei letti conosceva un po’ d’amore, qualche sposa viveva il suo tempo. Ma i giovani, no. Stefano sorprendeva anzi discorsi di scappate in città – non sempre di scapoli – e allusioni a qualche serva di campagna, bestia da lavoro tanto disprezzata che si poteva parlarne.
Specialmente all’imbrunire si sentiva quella povertà. Stefano usciva sull’angolo della sua casetta e si sedeva s’un mucchio di sassi, a guardare i passanti. La penombra s’animava di lumi, e qualche imposta si schiudeva alla frescura. La gente passava con un lieve fruscio e qualche susurro, talvolta in gruppi parlottanti. Qualche gruppo piú chiaro, piú isolato, era formato di ragazze. Non si spingevano molto lontano e subito riapparivano, rientrando in paese.
Di coppie non se ne vedevano. Se qualche gruppo s’incrociava, si sentivano asciutti saluti. Quel riserbo, del resto, piaceva a Stefano che dopo il tramonto non poteva allontanarsi dal domicilio e, piú che la gente, cercava la notte e la dimenticata solitudine dell’ombra. Tanto ne aveva dimenticato la dolcezza, che bastava un fiato di vento, il frinio di un grillo e un passo, l’ombra enorme del poggio contro il cielo pallido, per fargli piegare la gota sulla spalla, come se una mano lo carezzasse compiacente. La tenebra chiudendo l’orizzonte ampliava la sua libertà e ridava campo ai suoi pensieri.
A quell’ora era sempre sol...