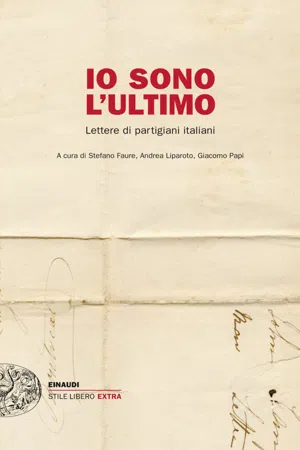![]()
![]()
Cosa vi devo dire. Le storie sono quelle. C’era la miseria. Si andava a scavare le patate che crescevano selvatiche nei prati, la notte. Si riusciva a trovare un pezzo di pane bianco. Era un sogno per noi. Si portava in famiglia e si divideva fra tutti, nove persone per una pagnotta. Si facevano i chilometri in bicicletta per trovare qualcosa da mangiare, lo si metteva nei barattoli di vetro, si cascava dalla bicicletta e si doveva dividere con le mani il cibo dal vetro.
Il momento era quello. L’ho raccontato a mia figlia. Ai miei nipotini di sei e sette anni, appena hanno avuto le orecchie per sentire una voce che non fosse quella della loro mamma. Lo racconto a voi, pur sapendo che certe cose non si possono capire.
Erano tempi di scelte. Io ho scelto la parte giusta. Ho fatto bene?
Ho avuto tanti amici morti da una parte e dall’altra. Amici morti con la camicia nera. Non dimentico neppure loro.
Io ho scelto la parte giusta. Ne sono convinto. È andata come doveva andare.
Ricordo il tram 19 a Torino il giorno della deposizione di Mussolini. Si credeva che la guerra fosse finita! È salito un tale, con la spilla del partito fascista puntata sul petto. Lo hanno afferrato per il bavero della giacca, quattro schiaffoni. Che cosa ne sapeva, quello, di che cosa era successo? Com’era possibile che non ne sapesse niente? Ha avuto la possibilità di scelta, il tizio? Forse si stava solo comportando come aveva fatto ogni giorno. Come avrebbero fatto in molti, moltissimi, se non avessero sentito la radio. Forse la sua radio era rotta. Oppure non aveva neanche piú le orecchie per sentire e gli occhi per vedere – non li aveva mai avuti, forse. Magari aveva altre preoccupazioni per potersi ricordare di levare una spilla.
Non dimentico i ragazzi del Borgo che avevano scelto di indossare la camicia nera, morti anche loro. Che cosa ne sapevano loro? Che cosa ne potrebbero dire, della loro scelta?
Io posso dire di mia madre con un figlio sulle montagne, uno in Africa, due nelle fabbriche. Dei miei fratelli, in Fiat a Torino e Firenze, sotto i bombardamenti e i tedeschi – il coraggio che ci voleva senza le armi e un posto dove andare a nascondersi. Delle mie quattro sorelle e dei fascisti che le puntavano il mitra addosso passando sulle camionette, per divertimento.
Posso dire della gente che non c’entrava niente ammazzata dai fascisti, del macellaio e del Grande invalido della Prima guerra mondiale messi al muro per rappresaglia a causa di una sparatoria avvenuta a decine di chilometri di distanza, della gruccia dell’invalido appoggiata al muro fissata per sempre nella memoria di mia sorella Germana.
Posso dire di tutte le volte che la mia famiglia sentiva partire i camion dal Dazio a poche decine di metri da casa, camion carichi di fascisti diretti verso le Valli di Lanzo per fare i rastrellamenti, per andare a stanare quelli come me che avevano fatto la scelta di non fare la guerra indossando una camicia nera. E posso dire del ragazzo in camicia nera che vedevo ogni volta che riuscivo a tornare a casa per una breve sortita, di tutte le volte che l’ho visto fare il posto di blocco con i repubblichini del Dazio.
Qualche giorno dopo la Liberazione, quando eravamo noi a fare i posti di blocco, quel ragazzo me lo sono visto che cercava di passarci davanti. Indossava una camicia di un altro colore, ma qualcuno lo ha riconosciuto lo stesso.
Un compagno lo teneva per il bavero della giacca, in un modo che faceva capire che non se la sarebbe cavata con quattro schiaffoni. Erano successe troppe cose, nel mezzo. Il momento era quello.
Io mi sono avvicinato al compagno. Questo ragazzo lo conosco bene, gli ho detto. È uno del mio quartiere. Una brava persona. Ci siamo sbagliati. Non è certo il tipo da aver indossato una camicia nera. Lasciamolo andare.
Ho fatto bene? La guerra è finita. Le scelte sono state fatte. Le storie sono quelle. Sono storie che dobbiamo ancora raccontarci, anche se sappiamo che voi non potete capirle del tutto. Finché abbiamo orecchie per ascoltarle.
![]()
Sono stato accusato di essermi bagnato del sangue degli italiani.
Ringrazio Dio ogni giorno per essere sopravvissuto a tutto questo e per esserne uscito indenne.
Tanti compagni hanno riportato ferite permanenti e tanti altri li ho visti perdere la vita sul campo di battaglia.
Io mi ritengo un miracolato.
Quando passavano i tedeschi ci si faceva il segno della croce. Era meglio spararsi da soli piuttosto che capitare in mani loro. Ogni volta che un militare tedesco perdeva la vita, senza alcun processo e senza alcuna giustizia, dieci italiani venivano sacrificati a sangue freddo.
C’era un soldato tedesco impegnato a sistemare la luce su un palo. Io sferrai un colpo d’arma.
La guerra è brutta, basterebbe un’ora soltanto là in mezzo per accorgersi di quanto sia atroce.
Il rumore degli spari risuona cosí forte nelle orecchie da farti cadere in terra.
Vedo morire accanto a me undici compagni. I corpi senza vita sono cosparsi di benzina e gli viene dato fuoco. Il grasso dei cadaveri bruciati incollava i piedi al suolo.
Dopo la Liberazione d’Italia feci ritorno nel paese nativo, atteso da genitori e fratelli. Trovai una realtà poverissima, in cui incontrai serie difficoltà nel trovare un impiego. Gli equilibri sociali erano ancora delicati e precari, non soltanto a causa della situazione economica. La presenza delle brigate nere e dei parenti dei fascisti caduti in guerra costituiva, infatti, un reale rischio per la sopravvivenza di tutti coloro che avevano combattuto il fascismo. Venivano ancora messe in atto vendette atroci.
È per questo motivo che decisi di emigrare all’estero per cercare lavoro. Trascorsi diciotto anni tra l’Inghilterra e il Belgio dove lavorai come minatore. Nel 1968 tornai definitivamente a Seclí dove, con i risparmi messi da parte, acquistai una casa e un terreno di quattro ettari. Da allora lavorai come agricoltore coltivando il mio terreno per mantenere la famiglia e permettere ai figli di studiare.
Il passato da partigiano è vivo in me, nella mia memoria, nelle mie notti insonni e in ogni gesto della quotidianità.
A cos’altro potrei pensare? L’Italia doveva essere liberata dal fascismo e io l’ho fatto, il dovere mio, l’ho fatto davvero.
![]()
Quanti, entrando in Milano da nord, sanno che il Monte Stella, quella verde collina che lasciamo a destra dopo piazzale Kennedy, è l’enorme cumulo di insanguinate macerie degli edifici distrutti dai bombardamenti del ’43 e ’44?
Non posso fare a meno di pensarlo, ogni volta che ci passo.
Quando entrai in Milano, da nord, quella collina non c’era.
Le macerie erano ancora ammucchiate ai bordi delle vie, nell’interno dei palazzi sventrati, nei loro cortili senza bimbi e senza vita. Anche da lí ci sparavano.
Quando entrai in Milano, era la prima volta che ci andavo.
Neppure un anno prima, a Gravellona Toce, un milite e due partigiani uccisi mi avevano mostrato l’orrore e la pietà che mi accompagnarono per tutta la lotta di Liberazione.
Mentre osservavo quella visione pietosa vidi l’asfalto sollevarsi a pezzi. Fu un attimo: mi stavano inquadrando.
Con un salto mi trovai al lato della strada, riparato dietro un muretto, disteso fra le ortiche. Altri compagni mi avevano preceduto, c’era anche quel tipo magro e lungo, di Ornavasso, che per la sua calma chiamavamo «Tranquil». Poi seppi che Tranquillo era proprio il suo nome.
Tranquil stava trascinando una mitragliatrice Saint-Etienne, vecchio residuo della Prima guerra mondiale, come lo erano anche i novantuno che alcuni di noi impugnavano.
– Aiutami, – mi disse, indicando una cassetta con lunghi caricatori, – e seguimi.
Sembrò cosí naturale che quasi mi passò la paura appena provata.
Ci portammo strisciando in un boschetto di robinie, vicino alla ferrovia, e da lí il Tranquil cominciò a sparare, a battere la zona da dove partivano i tiri che cercavano di fermare i nostri che entravano.
Lui era seduto dietro l’arma, io gli passavo i caricatori prima della raffica.
– Guarda la terza finestra della stazione, – disse il Tranquil.
Un attimo e la finestra era una nube di calcinacci, poi da lí non sparavano piú.
Dopo poche raffiche ci avevano localizzati e arrivavano i loro tiri.
Ero sdraiato al suolo e guardando il Tranquil, quando gli passavo il caricatore, vedevo che i rami di robinia sopra la sua riccia testa venivano tritati. E quello imperterrito a sparare.
– Adesso guarda la finestra di quella casa, là dietro.
Poi anche da là non sparavano piú.
Il rintronare della Saint-Etienne, l’odore della balestite bruciata, il sibilo delle pallottole, il cuore in gola per la paura e al tempo stesso l’ebbrezza di certe situazioni, le urla e l’incoscienza erano entrate di prepotenza nei nostri giorni.
Mi affidai totalmente al Tranquil, quasi ricevendo la sua calma.
Finita la guerra ci rivedemmo una decina di volte.
Il Tranquil lavorava, tranquillamente, al suo paese, e invecchiava bene. Pochi anni fa ero tornato ancora, come altre volte, in Val d’Ossola, dove per me il ricordo della guerra partigiana e dei tanti personaggi conosciuti allora è sempre vivo, quando, a Ornavasso, mi dissero che il Tranquil era morto. Avevo diciotto anni quando ci siamo conosciuti, e lui ventitre.
Quando lo penso lo rivedo sempre come allora, seduto dietro alla vecchia Saint-Etienne dalle lucide impugnature di ottone, con i rametti di robinia che cadono tritati sopra la sua riccia testa di montanaro buono.
Nell’aprile 1945, in tre giorni e due notti quasi insonni, ci aprimmo la strada per Milano.
Solo due giorni prima avevamo urlato la nostra gioia quando giunse l’ordine di calare al piano, di liberare le nostre città, di tornare a casa. Il 24 aprile Arona era tornata libera, mostrava ancora i segni dove avevamo combattuto solo dieci giorni prima, ma ora eravamo tornati per restarci.
Entrammo fra i primi, con la mia Brigata, i cecchini sparavano ancora ma i loro capi erano fuggiti lasciandoli soli.
Guardavamo il calvario delle nostre città distrutte, vedevamo le ultime vittime di quella tragica repubblica imposta alla gente di mezza Italia.
Morire in quei giorni era ancora piú disumano che non nei lunghi anni e mesi di guerra.
Poi, il 6 maggio, ci fu la grande sfilata delle brigate partigiane arrivate a Milano e due giorni dopo, l’8 maggio, la Germania crollava firmando un armistizio senza condizioni.
Vedere finire il mostro ci vaccinò per sempre contro la bestialità di tutto ciò che nega l’amore e il diritto di vivere liberi.
Ora tutto era finito, ma cominciava il difficile.
![]()
Non sapevamo neanche i nostri veri nomi, ma solo i nomi di battaglia. E io, per tutti, ero Stella.
Era una vita dura, ma resistevamo. Perché piú che amici eravamo fratelli. Ci volevamo bene.
Sono figlia di antifascisti. Anche se di politica in casa, con noi bambini, non se ne parlava. Noi studiavamo Mussolini come se fosse un dio in terra e solo dopo abbiamo saputo tante cose che ci erano state tenute nascoste.
Il primo ad avere rapporti con la Resistenza è stato mio fratello Giovanni. Poi ho conosciuto Dario, il comandante della Sap (Squadra di azione patriottica), che aveva il suo distaccamento alla Baracca di Roncarolo sull’argine del torrente Chiavenna. È stato lui a insegnarmi a fare la staffetta. Io avevo solo diciotto anni e non sapevo neanche cosa volesse dire: però questo è stato il ruolo che ho scelto e che ho portato avanti fino alla fine della Resistenza. Dalla Baracca andavo in bicicletta alla diga di Mignano, attraversando la via Emilia, un viaggio di quaranta chilometri per incontrare mio fratello o altri partigiani di Giovanni lo Slavo e tenere i contatti tra le Sap della pianura e le formazioni della montagna. Poi dovevo tornare indietro da Dario a Caorso, per riferire le novità. Oppure da Bore andavamo a piedi a Morfasso, attraverso sentieri nei boschi.
C’era da stare attenti. I mie...