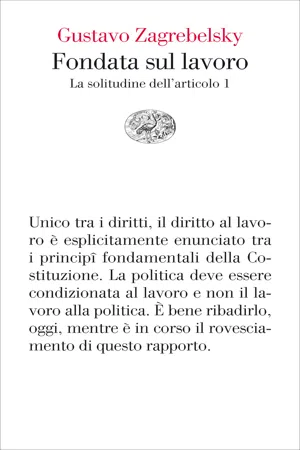![]()
In effetti, questo rovesciamento è sotto gli occhi di tutti, come prevalenza dell’effettività sulla legittimità.
Innanzitutto, il mondo del lavoro è in fase di decostruzione. I due principî-guida delle relazioni industriali, l’unitarietà e la generalità, sono insidiate dalla frammentarietà e dalla specialità. L’art. 39 della Costituzione proclama bensí la libertà di associazione sindacale e quindi il pluralismo e la reciproca autonomia delle organizzazioni dei lavoratori. Ma esso vuole altresí ch’esse operino solidariamente nei rapporti contrattuali con le controparti aziendali. Questo vuol dire la «rappresentanza unitaria» degli interessi dei lavoratori. Questa parte dell’art. 39 non ha trovato attuazione e le ragioni di ciò sono altrettanto note. Ma, pur in assenza di attuazione legislativa, l’esigenza costituzionale unitaria era pur stata soddisfatta dalla convergenza d’intenti, se non perfino dall’unità d’azione, dei sindacati. Oggi non è piú cosí. La rottura dell’unità pone le organizzazioni dei lavoratori, l’una indipendentemente dall’altra, di fronte alle aziende, alcune delle quali a loro volta hanno rotto il fronte comune, uscendo dalla loro associazione di categoria. Ne deriva, come conseguenza, che le aziende possono contrattare con questa o quell’organizzazione sindacale, possono cioè scegliere il contraente piú disposto ad aderire all’accordo, e lasciare da parte chi lo è meno o non lo è affatto, lasciando senza tutela diretta i lavoratori non iscritti ai sindacati contraenti (salva la tutela che, in taluni casi, può essere offerta contro i «comportamenti antisindacali»). In piú, viene introducendosi un fattore di privilegio a favore dei sindacati contraenti e a sfavore di quelli non contraenti, i quali, secondo l’art. 19 dello Statuto dei lavoratori, non potrebbero costituire rappresentanze aziendali. Può trattarsi di alterazione anche grave, non solo nel rapporto tra lavoratori e datori di lavoro, ma anche nei rapporti fra i sindacati stessi tra loro e con la propria base associativa, a seconda della disponibilità piú o meno marcata ad accordarsi con la controparte aziendale. Ciò non comporta la violazione di alcuna norma di legge, poiché vale il principio di libertà sindacale, ma certo determina un tipo di relazioni tra capitale e lavoro non conforme allo spirito, cioè al principio di unitarietà al quale s’ispira l’art. 39 medesimo.
Ma anche il principio di generalità, che si esprime nel contratto collettivo nazionale, è oggi soggetto a logoramento. Anzi, è espressamente contraddetto da una norma contenuta nella «legge di stabilità» del 2011, che rappresenta un vero e proprio rivoluzionamento del sistema ricevuto delle fonti giuridiche in materia di relazioni industriali: una norma che si presenta col titolo dimesso e apparentemente amico di «contratti di prossimità». Si tratta di contratti collettivi di scala minore, aziendale o territoriale, sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori «piú rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero da rappresentanze sindacali aziendali». Le intese cosí realizzate sono obbligatorie nei confronti di tutti i lavoratori, se sottoscritte da rappresentanze sindacali aziendali maggioritarie, e possono riguardare pressoché tutti gli aspetti del rapporto di lavoro. La finalità è quella di superare rigidità e uniformità, e favorire l’aderenza alle condizioni di realtà aziendali particolari. L’aspetto di maggior rilievo è che questi «accordi di prossimità» possono derogare, cioè contraddire, i contratti collettivi nazionali e perfino le disposizioni della legge. Queste norme diventano cedevoli, come dicono i giuristi, e nei contratti particolari possono stabilirsi, per i lavoratori, condizioni peggiorative. La Corte costituzionale (sent. n. 221 del 2012) con una motivazione sorprendentemente apodittica – si tratterebbe d’una limitata eccezione – ha salvato questa norma. Ma è facile comprendere ch’essa rappresenta, invece, l’allontanamento, se non il rovesciamento, dello spirito della Costituzione.
In sintesi, l’abbandono dell’unitarietà e della generalità ha come effetto di spezzare il fronte sindacale e di spostare il baricentro della contrattazione nella dimensione prossima alle esigenze vitali immediate dei lavoratori: dove si tratti di ciò, le resistenze evidentemente diminuiscono, e cosí la capacità contrattuale nei confronti dell’azienda. Quando poi è in gioco la garanzia del posto di lavoro, quando l’azienda subordina investimenti e occupazione alla sottoscrizione di determinati patti, di fronte a un simile Diktat, nel quale la disparità di posizione si rivela allo stato puro, l’accordo formale copre cedimenti sostanziali, rinunce a posizioni acquisite nel passato, disponibilità a condizioni di lavoro piú pesanti. Se poi a ciò si aggiunge la consultazione referendaria che conferma il cedimento, è la democrazia sindacale a risultare svuotata.
Si dirà che tutto ciò non deriva che da condizioni oggettive imposte dal mercato mondializzato, non da volontà sopraffattrice delle aziende, che operano anch’esse in stato di necessità imposto dalla concorrenza globale. Si dirà che oggi imprenditori e loro dipendenti devono considerarsi non contrapposti negli interessi, ma accomunati nella medesima impresa, di cui tutti sono, a seconda dei ruoli, funzionari o «servitori» (come Federico II di Prussia, che diceva di sé d’essere il primo servitore e magistrato dello Stato). Ma questa è altra questione, diversa dal rilevare il discostamento dalla Costituzione, che rinvia alle possibilità e alle responsabilità della politica, nel promuovere e imporre standard comuni di tutela del lavoro e nel combattere l’omologazione del lavoro verso il basso.