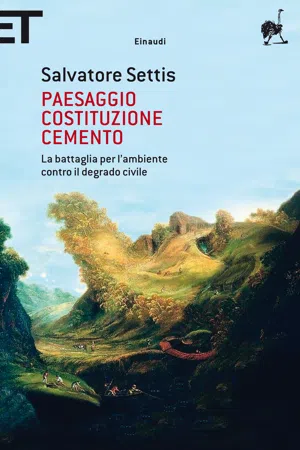![]()
1. Entra in scena l’‘ambiente’.
Sul paesaggio è in corso da decenni fra Stato e Regioni un duro conflitto che indebolisce i poteri pubblici, defunzionalizzando le amministrazioni e deresponsabilizzandole (vedi sopra, cap. V.4-5). Ma questa sorda lotta non è il solo nemico del nostro paesaggio. Con essa s’intrecciano almeno altri due fattori che vale la pena di discutere brevemente: il progressivo emergere della nozione di ‘ambiente’ e, in anni più recenti, il rapporto fra la normativa italiana e la Convenzione europea sul paesaggio.
La nozione di ambiente non c’era nella Costituzione del 1948, ma venne imponendosi più tardi, con la diffusione della cultura ambientalista e dei relativi linguaggi. Il tema entrò nella discussione pubblica in Italia grazie alla «Commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio» (la cosiddetta Commissione Franceschini), istituita in base alla L. 310 del 1964. Fu nei lavori di questa Commissione che venne a consolidarsi l’espressione oggi corrente ‘beni culturali’, peraltro già usata dal francese Georges Berlia in una riunione Unesco tenutasi a Firenze nel 1950, e poi nella L. 279 del 1958, con cui l’Italia ratificò la Convenzione Unesco per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (1954)126. Negli atti della Commissione, pubblicati nel 1967127, i «beni culturali ambientali» erano una categoria a sé, come i beni archeologici e storico-artistici o quelli archivistici e librari. Essi venivano definiti come «le zone corografiche costituenti paesaggi, naturali o trasformati ad opera dell’uomo», ma includevano anche «le strutture insediative, urbane e non urbane, che, presentando particolare pregio per i loro valori di civiltà, devono essere conservate al godimento della collettività» (Dichiarazione XXXIX, Atti, I, p. 69). Si tentava qui, suggerendola al legislatore, una piena ricomposizione fra ‘paesaggio’ e ‘urbanistica’, e infatti i «beni culturali ambientali» venivano raggruppati in «due grandi classi di beni, quelli di tipo paesaggistico e quelli di tipo urbanistico». Si ricordavano con rilievo anche le situazioni ‘intermedie’ («strutture insediative non urbane come castelli, torri, abbazie, borghi, casolari, ville, case coloniche, villaggi di pescatori ecc.»); ad esse si dava anzi implicitamente la funzione di raccordo fra le città e le campagne.
Consapevole del dissidio fra materia paesaggistica e materia urbanistica (vedi sopra, cap. V.3-4), la Commissione Franceschini dichiarò che la trasformazione degli insediamenti urbani «non può farsi unicamente in funzione delle condizioni economiche e sociali emergenti, ma deve essere considerata come bene culturale in fieri, che esige particolari tutele ed interventi» mediante «l’inscindibile ed irrinunciabile presenza delle istanze culturali» che possono condurre «alla creazione di significativi paesaggi urbani» (Atti, I, p. 73). L’efficacia di questo principio doveva esser garantita dal forte nesso fra i piani regolatori comunali e la «dichiarazione di bene culturale ambientale», promossa dalle Soprintendenze ma anche dai privati cittadini: un ritorno, in sede amministrativa anziché giudiziaria, all’‘azione popolare’ prevista nella prima versione della legge Rava (vedi sopra, cap. III.4). Queste proposte erano contenute entro un quadro assai ricco e immaginativo; ma esso, nonostante le speranze di allora, cadde nel vuoto. Il punto centrale doveva essere l’istituzione di una Amministrazione autonoma dei beni culturali, con un Consiglio Nazionale composto da esperti con competenze specifiche di settore e presieduto dal ministro della Pubblica Istruzione. Essa doveva essere strutturata con «ampia autonomia normativa e organizzativa, sistema contabile di tipo aziendale, bilancio di cassa con aggiustamenti periodici» (Atti, I, p. 91), e ne dovevano dipendere le Soprintendenze, intese come «apparato scientifico e tecnico». La nuova categoria concettuale e giuridica di «beni culturali ambientali», in quel contesto, era intesa non solo a ricomporre la dicotomia fra urbanistica e paesaggio, ma anche a raccordare fortemente il paesaggio (anche urbano) con il patrimonio archeologico e storico-artistico.
Ma nella Relazione Franceschini la nozione di ‘ambiente’ era di fatto solo un’estensione di quella di ‘paesaggio’ dell’art. 9 Cost., e non conteneva ancora connotazioni essenziali che intanto andavano prendendo piede in Italia come in tutta Europa. La nuova nozione di ‘ambiente’ come bene giuridico soggetto a tutela si riferirà assai presto, invece, al regime dei suoli e delle acque, alla salvaguardia (o all’inquinamento) dell’aria, delle risorse naturali e del territorio, alla protezione (o al degrado) della biosfera, alle variazioni del clima, e così via, in senso prevalentemente ‘quantitativo’ (con riferimento ai massimi livelli ‘accettabili’ di alterazione ambientale). Tuttavia, la nozione di ‘ambiente’ spesso verrà allargata fino a includervi anche quella, di per sé essenzialmente ‘qualitativa’, di ‘paesaggio’.
Si diffondeva intanto in tutto il mondo la cultura ambientalista. Già nel 1948 era stato fondato assai precocemente in Italia un Movimento per la Protezione della Natura; dal 1951 esisteva in America The Nature Conservancy, dal 1961 in Europa il Wwf. Il 1970 fu dichiarato dal Consiglio d’Europa ‘anno della conservazione della natura’, e del 1972 fu la Dichiarazione di Stoccolma sull’ambiente, promossa dall’Onu. Il livello di allarme su questi temi crebbe ancora quando, in un congresso a San Diego (1977), dati scientifici inoppugnabili mostrarono la veloce estinzione di molte specie animali e le conseguenze sull’ambiente; quasi che in quel destino si vedesse in qualche modo riflessa la possibile sorte della specie umana. Anche in Italia vi furono in quegli anni iniziative molto promettenti mirate all’esplorazione delle tematiche ecologiste e a una nuova definizione di ‘ambiente’. Fra esse emerge per ambizioni e sistematicità la Prima relazione sulla situazione ambientale del Paese, prodotta dalla Tecneco, una società fondata dall’Eni nel 1971 nell’ambito di Snam Progetti. Voluta da Raffaele Girotti (che aveva appena sostituito Eugenio Cefis alla presidenza dell’Eni) e condotta sotto gli auspici del Presidente del Consiglio e il coordinamento del ministro per la Ricerca Scientifica, la Relazione fu redatta nel 1972-73, presentata il 29 giugno 1973 a Urbino, e poi pubblicata in quattro volumi, per circa 1200 pagine, nel 1974. L’Eni intendeva allora impegnarsi fortemente sul fronte dell’ecologia: già nel 1971 erano usciti cinque volumi, a cura di Italo Insolera ed Enrico Ascione, Le coste d’Italia (sarebbe istruttivo, e deprimente, ripercorrere le nostre coste invase oggi dal cemento con in mano le foto di allora), seguiti da quelli sui Monti d’Italia. Girotti volle fare di più, e controbilanciare le accuse di inquinamento di cui l’Eni era il bersaglio con una ricerca sistematica sull’ambiente italiano; ma dopo le gravissime difficoltà politiche di quella prima prova, il percorso ‘ecologico’ dell’Eni si interruppe128. Nella Relazione sulla situazione ambientale le singole parti non sono firmate, ma si sa che vi contriburono fra gli altri Feliciano Adami e Giovanni Urbani, direttore dell’Istituto centrale per il restauro, che in quegli stessi anni promosse con Franco Briatico (presidente della Tecneco) il suo Piano pilota per la conservazione dei beni culturali in Umbria, tanto più importante in quanto totalmente disatteso129.
La Relazione Tecneco lamentava, in contrasto con «l’evoluzione della coscienza civile» (I, p. 36), «l’immobilità del quadro legislativo e istituzionale», indicando i settori ‘caldi’ di quella che veniva chiamata «difesa ambientale», e cioè «aria, acqua, pesticidi, rumore, rifiuti solidi, radiazioni, fauna, flora, urbanistica, difesa del suolo, parchi e riserve naturali, boschi e foreste, bellezze naturali e del paesaggio, beni culturali e via dicendo» (I, p. 32; III, p. 19). La Relazione fu respinta, anzi affossata, dalla sinistra, che la lesse come una mistificazione tecnocratica al servizio dell’industria130: eppure essa aveva in comune con il regionalismo ‘di sinistra’ un punto essenziale, la determinazione a far leva sulla nozione di ‘ambiente’ per estendere l’ambito di competenza delle Regioni. I ‘tecnocrati’ dell’Eni e i loro acerrimi nemici che militavano nel Pci ritennero, in una concordia che nessuno era disposto ad ammettere, che la nuova nozione di ‘ambiente’, proprio perché ancora indeterminata e senza un contenuto giuridico definito, potesse funzionare come una sorta di magnete, annettendosi di fatto, anche per influenza della Relazione Franceschini, le materie dell’art. 9 Cost. (paesaggio e beni culturali), che infatti furono anch’esse partitamente censite nella Relazione Tecneco (Patrimonio dei beni culturali, II, pp. 401-46, con sezioni su Paesaggio e dimore rurali tradizionali e sullo Stato attuale dei vincoli sulle «bellezze naturali» secondo la L. 1497 del 1939).
La sotterranea, inconfessata convergenza Eni-Pci si spiega facilmente: sull’uno come sull’altro fronte, per ragioni diverse, si voleva trarre il massimo vantaggio da una situazione contingente che sembrava promettere un vasto, inatteso terreno d’azione. Gli anni in cui si diffondeva in tutto il mondo la cultura ambientalista furono infatti gli stessi in cui in Italia (e solo in Italia) alcuni poteri essenziali dello Stato venivano trasferiti alle Regioni a statuto ordinario, previste dalla Costituzione ma ‘decollate’ in realtà solo il 1º aprile 1972 (‘primo decentramento’: vedi sopra, cap. V.4). Le leggi nazionali di trasferimento delle competenze e i singoli Statuti regionali parvero dunque il luogo e l’occasione per ridurre a unità paesaggio e urbanistica, «fattori disaggregati» (così la Relazione Tecneco) che si sperò potessero esser raccolti sotto la nuova etichetta di ‘ambiente’. Mancò allora ogni consapevolezza che, se davvero si voleva ricomporre, chiamandola ‘ambiente’, una superiore unità che includesse urbanistica, paesaggio e beni culturali, era indispensabile partire dall’art. 9 Cost., armonizzandolo con le (modeste) competenze regionali allora previste all’art. 117 Cost. La tendenza politica del momento fu anzi l’opposto: forzare le maglie dell’art. 117, che alle Regioni attribuisce la materia urbanistica, e appropriarsi dell’‘ambiente’ – proprio perché non nominato nella Costituzione – inserendolo tacitamente fra le materie di competenza regionale. È quello che fa la Relazione Tecneco, che non a caso cita le leggi Bottai del 1939, ma sorvola sull’art. 9 Cost. che, come abbiamo visto (cap. V.1), ne era stata la proiezione costituzionale, ed evita di parlare di ‘paesaggio’ tornando alla dizione ‘bellezze naturali’ della legge Bottai. Anzi, insiste la Relazione, «la materia urbanistica di cui all’art. 117 della Costituzione» va intesa «non tanto e non solo come coinvolgente le competenze attinenti al regolare svolgersi degli insediamenti urbani, quanto tutte quelle ordinate in modo diretto o indiretto ad una equilibrata utilizzazione del territorio nel suo complesso», e ciò «in vista della tutela dell’ambiente» (III, p. 127). Perciò, secondo la Relazione, i decreti delegati del ‘primo decentramento’ hanno dato alle Regioni troppo poco; non hanno ricomposto «la scissione operata tra la materia urbanistica e quella delle bellezze naturali», lasciando alle Soprintendenze statali un «potere puntuale d’intervento». Meglio sarebbe riconoscere alle Regioni l’«unificato potere di pianificazione», incentrandolo sulla materia urbanistica dell’art. 117 (III, pp. 127-28). I decreti delegati si erano limitati a riproporre l’impostazione adottata nelle Regioni a statuto speciale, alle quali peraltro «in taluni casi si sono consentite possibilità di intervento sufficientemente omogenee e ragionevolmente corrispondenti alle esigenze di impostazione e gestione unitaria del settore» (III, p. 128); meglio sarebbe, secondo la Relazione, unificare le competenze in tutta Italia e attribuirle in blocco alle Regioni.
La nozione giuridica di ‘ambiente’, ancora in formazione, venne dunque intesa allora come il grimaldello col quale si potesse forzare la magica porta oltre la quale ‘territorio’ e ‘urbanistica’, diventati tutt’uno, potessero di fatto ingoiare il ‘paesaggio’ senza nemmeno dirlo esplicitamente. Bell’esempio di un modus operandi che, polverizzando realtà materiali unitarie, le trasforma in nozioni astratte e malleabili, un divide et impera nostrano che tendenzialmente consente ogni arbitrio e cancella ogni responsabilità. Ha ragione la Relazione Tecneco: nessuna delle Regioni a statuto speciale aveva colto questa opportunità, dato che i loro statuti (anche quello del Friuli - Venezia Giulia, 1963) erano anteriori alla voga ambientalista; le Regioni a statuto ordinario si trovarono così nella curiosa situazione di potersi autoattribuire poteri più ampi di quelle a statuto speciale; e, in mancanza di direttive del governo centrale e di coordinamento fra loro, lo fecero confusamente e in ordine sparso. È utile ripercorrere (traendola dalla stessa Relazione Tecneco, III, pp. 124-41) la mappa delle diverse soluzioni adottate negli Statuti delle Regioni, tutti elaborati nei relativi Consigli regionali e poi approvati dal Parlamento e promulgati con leggi dello Stato fra 1970 e 1971:
Piemonte: «conservare e definire l’ambiente naturale» è fra le attribuzioni della Regione, che includono anche «parchi e riserve naturali»; non si menzionano né paesaggio né beni culturali.
Liguria: la Regione «tutela l’ambiente naturale», ma anche «tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale», contribuendo inoltre «alla valorizzazione dei centri storici ed alla loro rivitalizzazione».
Lombardia: la «difesa dell’ambiente» è fra le finalità della pianificazione territoriale.
Veneto: «l’assetto zonale ed economico del territorio» va garantito e valorizzato nel rispetto delle «caratteristiche naturali», «per risanare e salvaguardare gli ambienti naturali e umani nel loro insieme»; la Regione garantisce inoltre «la conservazione e il ripristino del patrimonio ambientale, storico e artistico del Veneto e di Venezia».
Emilia-Romagna: la competenza regionale include «la difesa attiva del suolo e dell’ambiente quale insieme di valori culturali e naturali».
Toscana: «in concorso con lo Stato e con gli enti locali», la Regione «garantisce che l’assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita delle generazioni attuali e future», promuove «un giusto rapporto fra città e campagna», subordina «a queste necessità gli interventi relativi alle opere di interesse pubblico, agli insediamenti umani e alle attività produttive»; infine, «concorre alla difesa del paesaggio e del patrimonio storico-artistico», anche per sviluppare il turismo.
Marche: la Regione «tutela, come beni culturali, il patrimonio storico, artistico e archeologico, i centri storici, la natura e il paesaggio».
Umbria: per creare «un equilibrato assetto del territorio» e «un ambiente idoneo a soddisfare compiutamente le esigenze della persona umana», la Regione «provvede alla difesa del suolo e del paesaggio, alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali, dell’ambiente ecologico e del patrimonio storico, artistico ed archivistico».
Lazio: la Regione «difende l’ambiente naturale» e ispira la propria legislazione anche a «iniziative volte a preservare ed a valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale».
Abruzzo: nell’ambito della propria «politica di piano», la Regione «determina l’assetto del territorio nel rispetto delle caratteristiche naturali … anche mediante la difesa del suolo».
Molise: la Regione cura «la valorizzazione e la difesa del paesaggio e del patrimonio storico e artistico» in funzione dello «sviluppo del turismo».
Campania: l’«assetto territoriale e di pianificazione urbanistica» si lega strettamente alla «piena valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico», che la Regione «concorre a tutelare», anche costituendo «parchi e riserve».
Puglia: la Regione «concorre alla difesa del suolo … dell’ambiente ecologico, del paesaggio».
Basilicata: la «difesa dell’ambiente naturale» e la «legislazione e pianificazione territoriale» si legano strettamente alla «conoscenza, valorizzazione, tutela e gestione del patrimonio storico, artistico e culturale», oltre che ai «parchi e riserve naturali».
Calabria: la Regione «persegue un razionale assetto del territorio» con «lo sviluppo ordinato degli insediamenti umani», e insieme «la tutela dei valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico ed archeologico».
Tot capita, tot sententiae: sarebbe utile (ma anche un po’ frustrante) ripercorrere affinità e differenze fra i linguaggi di volta in volta adoperati dalle varie Regioni. Nei loro Statuti, ora si ricorda la «concorrenza» con lo Stato nell’esercizio dei propri poteri, ora lo Stato non è nemmeno men...