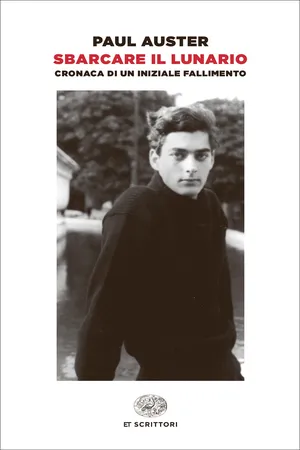![]()
Paul Auster
Sunset Park
Traduzione di Massimo Bocchiola
![]()
Il traduttore ringrazia Enzo Di Gesú, segretario dell’Associazione giornalisti baseball, per la cortese consulenza.
![]()
A cavallo dei trent’anni, vissi un periodo in cui tutto quello che toccavo si trasformava in fallimento. Il mio matrimonio si concluse con un divorzio, il mio lavoro di scrittore andò a picco, e mi ritrovai assillato dai problemi finanziari. Non sto parlando di penurie occasionali, o di periodiche tirate di cinghia, ma di una mancanza di denaro continua, oppressiva, soffocante, che mi avvelenava lo spirito generando una condizione di panico senza fine.
Non potevo rimproverare altri che me stesso. Il mio rapporto con i soldi era sempre stato deficitario, elusivo, ricco di impulsi contraddittori, e ora pagavo il prezzo del mio rifiuto di assumere sul problema una posizione decisa. Fino allora, la mia unica ambizione era stata quella di fare lo scrittore. Lo avevo stabilito da quando avevo sedici o diciassette anni, e non mi ero mai illuso che avrebbe potuto darmi da vivere. Fare lo scrittore non è una «scelta di carriera», come fare il medico o il poliziotto. Piú che sceglierlo, ne vieni scelto, e una volta constatato che non sei adatto a fare nient’altro, ti devi preparare a percorrere per il resto della vita una strada lunga e difficile. A meno di scoprirti un favorito degli dèi (e peste colga chi vi fa affidamento), il tuo lavoro non ti procurerà mai abbastanza per mantenerti, e se ci tieni ad avere un tetto sopra la testa e a non morir di fame, è meglio che ti rassegni, per pagare conti e bollette, a fare un altro lavoro. Lo capivo, ero preparato, non avevo rimostranze. In questo senso, ero enormemente fortunato. Non nutrivo particolari voglie di beni materiali, e la prospettiva della povertà non mi spaventava. Tutto quello che volevo era un’occasione di fare il lavoro verso cui intimamente mi sentivo portato.
La maggioranza degli scrittori ha una doppia vita. Traggono ragionevoli guadagni da professioni riconosciute, e il tempo da dedicare alla scrittura lo raggranellano come possono: la mattina presto, la sera tardi, nei fine settimana, in vacanza. William Carlos Williams e Louis-Ferdinand Céline erano medici. Wallace Stevens lavorava per una compagnia di assicurazioni. T. S. Eliot fece prima il bancario e poi l’editore. Fra quelli che conosco di persona, il poeta francese Jacques Dupin è condirettore di una galleria d’arte a Parigi. William Bronk, il poeta americano, ha gestito per piú di quarant’anni l’impresa di famiglia occupandosi di legname e carbone nello Stato di New York. Don De Lillo, Peter Carey, Salman Rushdie ed Elmore Leonard hanno lavorato a lungo nella pubblicità. Altri scrittori insegnano. Attualmente, quest’ultima è probabilmente la soluzione piú comune: tutte le università, dai piú prestigiosi atenei ai college piú sperduti, annoverano i cosiddetti corsi di «scrittura creativa», perciò narratori e poeti si affannano a scribacchiare e sgomitare per aggiudicarsi un posto. E chi può biasimarli? Gli stipendi non saranno sontuosi, ma è un lavoro sicuro e con orari piú che accettabili.
Il mio problema era che la doppia vita non mi interessava. Non che non volessi lavorare, ma l’idea di timbrare il cartellino in un posto dalle-nove-alle-cinque mi lasciava freddo, completamente privo di interesse. Avevo vent’anni o poco piú, e mi sentivo troppo giovane per mettere la testa a partito, troppo pieno di progetti diversi per sprecare il mio tempo a guadagnare piú soldi di quanti ne volessi o me ne servissero. Insomma, in quanto a finanze mi bastava tirare avanti. Ai tempi la vita costava poco e calcolai che, dovendo mantenere soltanto me stesso, me la sarei cavata con un reddito annuale di circa tremila dollari.
Per un anno tentai il dottorato, ma solo perché la Columbia mi offrí una borsa che univa all’esenzione dalle tasse universitarie un sussidio di duemila dollari: in sostanza, venivo pagato per studiare. Anche se le condizioni erano ideali, scoprii in breve che non faceva per me. Ne avevo abbastanza della scuola, e la condanna a fare lo studente per altri cinque o sei anni mi sembrava peggiore della morte. Non volevo piú parlare di libri, volevo scriverli. In linea di principio trovavo sbagliato che uno scrittore si rintanasse in università circondandosi di troppi personaggi a lui affini, mettendosi troppo a proprio agio. C’era il pericolo dell’autocompiacimento, e cedendo a esso uno scrittore è praticamente perduto.
Non intendo difendere le scelte che feci. Se non furono pragmatiche, la verità è che io non volevo essere pragmatico. Volevo nuove esperienze. Volevo uscire nel mondo e mettermi alla prova, divagare da un’esperienza all’altra, esplorare il piú possibile. Pensavo che se avessi tenuto gli occhi aperti, tutto quello che poteva succedermi sarebbe stato utile, mi avrebbe insegnato cose che non avevo mai saputo. Può sembrare vecchia letteratura, e forse lo era. Il giovane scrittore dà l’addio alla famiglia e agli amici salpando per mete incognite alla scoperta di se stesso. Nel bene e nel male, dubito che mi si sarebbe adattata un’impostazione diversa. Avevo l’energia, una testa che scoppiava di idee e il solletico ai piedi. In un mondo cosí grande, l’ultima cosa che desideravo era starmene al calduccio.
Non ho difficoltà a descrivere i fatti o a ricordarmi come li vivevo. Il problema nasce solo quando mi domando perché mi comportassi a quel modo e sentissi quello che sentivo. Tutti gli altri giovani poeti e narratori miei compagni all’università, stavano preparandosi il futuro con giudizio. Non essendo ragazzi ricchi, da poter contare sulle provvigioni dei genitori, una volta lasciato il college avremmo dovuto pensare a guadagnarci da vivere una volta per sempre. Tutti avevamo di fronte la stessa prospettiva, tutti sapevamo come stavano le cose: ma loro agirono in un modo, e io in un altro. Ecco perché non so ancora spiegarmelo. Perché i miei amici si comportarono con tanta avvedutezza, e io in modo tanto avventato?
Provenivo da una famiglia medioborghese. Ho trascorso l’infanzia nel benessere, senza mai conoscere la scarsità e le privazioni che assillano gran parte degli esseri umani viventi sulla terra. Non ho mai sofferto né la fame né la sete, non ho mai rischiato di perdere niente di ciò che avevo. La sicurezza era scontata, eppure, malgrado l’agiatezza e la fortuna della mia famiglia, il denaro era oggetto costante di discussione e ansietà. Entrambi i miei genitori avevano vissuto la Depressione, e nessuno dei due si era completamente rimesso da quel periodo di miseria. Erano rimasti segnati dall’esperienza di non avere il necessario, e in maniere diverse continuavano a portarne le ferite.
Mio padre era parsimonioso; mia madre era prodiga. Lei spendeva; lui no. Il ricordo della povertà non aveva allentato la morsa sul suo spirito, e benché la sua condizione fosse cambiata, non riuscí mai a convincersene del tutto. Viceversa, lei dal suo nuovo stato traeva un immenso piacere. Abbracciava i rituali del consumismo, e come tanti altri americani prima e dopo di lei, praticava lo shopping come un mezzo di espressione personale, talvolta elevandolo a forma d’arte. Entrare in un negozio significava introdursi in un processo alchemico che saturava il registro di cassa di proprietà metamorfiche. I desideri indicibili, i bisogni intangibili, le smanie inarticolate: tutto passava attraverso la cassa per fuoriuscirne in forma di realtà, di oggetti palpabili. Mia madre non era mai stanca di replicare questo miracolo, e i conti che ne risultavano divennero il pomo della discordia fra lei e mio padre. Lei era convinta che ce li potessimo permettere; lui no. Due stili, due visioni del mondo, due filosofie morali erano in perenne attrito, finché non sgretolarono il matrimonio. I soldi erano la linea di spaccatura, e si imposero come l’unica, incontrollabile fonte dei loro dissensi. Il dramma è che erano due brave persone – premurose, oneste, lavoratrici – e al di fuori di quel cruento campo di battaglia sembrava proprio andassero d’accordo. Giuro che non riuscii mai a capire come una questione cosí relativamente futile poté portare fra loro tanta acredine. Ma naturalmente, il denaro non è mai solo il denaro. È sempre qualcos’altro, è sempre qualcosa di piú, e ha sempre l’ultima parola.
Da bambino, fui preso in mezzo a questa guerra di idee. Mia madre mi portava a comprare vestiti, risucchiandomi nel vortice del suo entusiasmo e della sua generosità; quante volte mi sono lasciato convincere di volere le cose che mi offriva: sempre di piú di quanto mi aspettassi, sempre di piú di quello che credevo mi servisse. Era impossibile resistere, impossibile non godere alla vista dei commessi che baciavano la terra dove metteva i piedi, impossibile non essere ammaliati dalla grandiosità della sua esibizione. Tuttavia la mia gioia era sempre mista a una buona dose di angoscia, perché sapevo esattamente cosa avrebbe detto mio padre alla vista del conto. E in effetti lo diceva sempre. Avremmo avuto l’inevitabile esplosione, e quasi inevitabilmente la faccenda si sarebbe risolta con la dichiarazione di mio padre che, la prossima volta che mi serviva qualcosa, mi avrebbe portato a fare acquisti lui. Cosí sarebbe venuto il momento di comprarmi, per dire, una nuova giacca invernale o un paio di scarpe nuove, e una sera dopo cena mio padre e io saremmo partiti in auto verso un discount store, chissà dove lungo una strada nel buio del New Jersey. Ricordo, di quei luoghi, il bagliore delle lampade al neon, i muri di calcestruzzo grigio, le interminabili scansie di indumenti maschili a buon mercato. Come diceva la canzoncina della pubblicità alla radio: «Questa stagione Robert Hall | Vi aggiusta per le feste | Da capo a piè… | Bum, bum, bum | Da capo a piè!» A conti fatti, la mia infanzia è altrettanto legata a quei versi che alle preghiere della sera.
La verità è che questa caccia al risparmio con mio padre non mi piaceva meno delle scorrerie spenderecce orchestrate dalla mamma. La mia lealtà era suddivisa equamente fra i miei due genitori e non ebbi mai la tentazione di piantare le tende nell’accampamento dell’una o dell’altro. Forse l’atteggiamento di mia madre era piú accattivante, almeno per capacità di divertire e suscitare emozione, ma anche nella cocciutaggine di mio padre c’era qualcosa che mi avvinceva, l’impressione che le sue idee fossero fondate su un’esperienza e una consapevolezza ottenute a caro prezzo, su un’integrità di propositi che non lo faceva recedere mai, neanche di fronte al rischio di apparire cattivo. Questo lo trovavo ammirevole, e sebbene adorassi la mia mamma bellissima, dal fascino inesauribile, per quel suo modo di abbagliare il mondo, adoravo ugualmente mio padre per come sapeva resistere al mondo stesso. Vederlo in azione poteva essere esasperante – era un uomo che sembrava non preoccuparsi mai di quello che gli altri pensavano di lui – ma anche istruttivo, e a conti fatti penso di aver prestato a quelle lezioni piú attenzione di quanto non credessi.
Da bambino ero un classico tuttofare. Alle prime tracce di neve, correvo fuori con la pala e iniziavo a suonare i campanelli e chiedere ai vicini se mi pagavano per ripulirgli sentieri e vialetti. In ottobre, quando cadevano le foglie, eccomi con il rastrello a suonare gli stessi campanelli e offrirmi per il prato. Altre volte, quando sul terreno non c’era niente da togliere, mi offrivo di fare i «lavoretti». Riordinare il garage, rassettare la cantina, potare la siepe… qualunque cosa servisse, faceva per me. In estate vendevo la limonata per dieci cent al bicchiere sul marciapiede davanti a casa mia. Raccoglievo i vuoti dalla dispensa, li caricavo sul mio carrettino rosso e li trainavo fino al negozio per renderli in cambio di qualche spicciolo. Due cent per le bottiglie piccole; cinque cent per quelle grandi. Gran parte dei miei guadagni li spendevo per comprare figurine del baseball, giornali sportivi e a fumetti, e riponevo diligentemente quello che restava nel mio salvadanaio a forma di registratore di cassa. Ero davvero il figlio dei miei genitori, e non posi mai in discussione i principî che animavano il loro mondo. I soldi parlavano, e cosí bene che se li ascoltavi e seguivi le loro opinioni, avresti imparato a parlare la lingua della vita.
Ricordo che una volta avevo un pezzo da cinquanta cent. Non mi ricordo come entrai in possesso di quella moneta – che a quei tempi era rara come adesso – ma, che mi fosse stata regalata o l’avessi guadagnata, ho tuttora la chiara sensazione del suo valore per me, e della somma considerevole che rappresentava. Ai tempi con cinquanta cent ti potevi comprare dieci pacchetti di figurine, cinque album a fumetti, dieci bastoncini canditi, cinquanta caramelle… oppure, a scelta, svariate combinazioni di tutto questo. Mi infilai il mezzo dollaro nella tasca di dietro e mossi verso il negozio, almanaccando febbrilmente su come avrei speso la mia piccola fortuna. Però lungo la strada, per ragioni che ancora non so ricostruire, la moneta sparí. Rovistai nella tasca solo per controllare – sapevo che c’era, volevo solo assicurarmene – e il denaro era scomparso. Avevo un buco nella tasca? Avevo fatto scivolare accidentalmente la moneta fuori dai pantaloni l’ultima volta che l’avevo toccata? Chissà. Avevo sei o sette anni, ma ricordo ancora come mi sentii disgraziato. Ci avevo messo tutta l’attenzione possibile, ma malgrado le mie precauzioni alla fine avevo perso i soldi. Come avevo potuto permettere che succedesse una cosa del genere? Non trovando nessuna spiegazione logica, stabilii che era stato un castigo divino. Non sapevo il perché, ma ero sicuro che l’Onnipotente in persona mi avesse ficcato una mano in tasca e sfilato i quattrini.
A poco a poco cominciai a voltare le spalle ai miei genitori. Non che da un certo punto in poi abbia voluto loro meno bene; ma il mondo da cui provenivano non mi sembrava piú un posto allettante dove vivere. Avevo dieci, undici, dodici anni, e stavo già trasformandomi in un émigré interiore, un esule in casa mia. Molti di questi cambiamenti si possono attribuire all’adolescenza, al semplice fatto che stavo crescendo e cominciavo a pensare con la mia testa… ma non tutti. Contemporaneamente in me altre forze erano al lavoro, e ciascuna ebbe un ruolo nello spingermi sulla strada che seguii successivamente. Non fu solo il dolore di dover assistere alla fine del matrimonio dei miei genitori, e non fu solo la frustrazione di sentirmi imprigionato in un sobborgo provinciale, e non fu solo il clima dell’America alla fine degli anni Cinquanta: ma il risultato di tutto questo fu una rivolta subitanea e violenta contro il materialismo, la denuncia della visione conformista per cui i soldi erano un bene da anteporre a tutti gli altri. I miei genitori tenevano in considerazione il denaro, e che fine avevano fatto? Avevano lottato cosí duramente per averlo, ci avevano creduto fino in fondo, ma a ogni problema da esso risolto ne era subentrato uno nuovo. Il capitalismo americano aveva creato uno dei momenti di massima prosperità nella storia dell’uomo. Aveva prodotto quantità esorbitanti di automobili, ortaggi surgelati e shampoo miracolosi, ma adesso che era presidente Eisenhower tutta la nazione si era trasformata in un gigantesco spot televisivo, un peana incessante a chi compra di piú, produce di piú e spende di piú; un invito a danzare intorno all’albero del dollaro finché non si cadeva morti per la semplice frenesia di non essere da meno di tutti gli altri.
Non passò molto tempo e scoprii di non essere l’unico a provare quel disagio. A dieci anni, in una pasticceria di Irvington, New Jersey, trovai una copia di «Mad Magazine», e ricordo l’intenso, quasi attonito piacere che provai leggendo quelle pagine. Mi insegnarono che in questo mondo avevo degli spiriti affini, e le porte che tentavo di socchiudere erano già state aperte da altri. Nel sud degli Stati Uniti usavano gli idranti contro i neri, i russi avevano lanciato il primo Sputnik, e io incominciavo a seguire queste vicende. No, non ero obbligato a trangugiare il dogma che volevano somministrarmi. Potevo opporre resistenza, deriderli, scoprire il loro bluff. L’integrità e la deprimente rettitudine della vita americana non erano piú che una fandonia, una tiepida montatura pubblicitaria. Nel momento in cui cominciavo a esaminare i fatti, venivano a galla delle contraddizioni, smascheravo flagranti ipocrisie, di colpo diventava praticabile un modo del tutto nuovo di guardare le cose. Ci avevano insegnato a credere nel binomio «libertà e giustizia per tutti», ma in realtà la libertà e la giustizia spesso erano in contrasto fra loro. L’ossessione del denaro non aveva niente a che fare con la lealtà: suo propulsore era il principio sociale «ognuno per sé». Quasi a dimostrazione della sostanziale disumanità del mondo del mercato, quasi tutte le sue metafore erano tratte dal regno animale: cane mangia cane, i tori e gli orsi1, gli squali della finanza, la selezione naturale. I soldi dividevano il mondo tra vincenti e perdenti, ma che cosa ne era dei perdenti? In base agli elementi di cui disponevo, dedussi che erano destinati all’emarginazione e all’oblio. Peccato, naturalmente… ma il mondo è fatto a scale. Se si costruisce un universo cosí primitivo che il suo filosofo è Darwin e il suo massimo poeta Esopo, che altro ci si può aspettare? È una giungla, sí o no? Basta guardare il leone di Dreyfus che passeggia nel mezzo di Wall Street2. Si è mai visto un messaggio piú chiaro? Mangiare o essere mangiati. È la legge della giungla, amico mio, e se non hai stomaco a sufficienza, tiratene fuori finché sei in tempo.
Io me ne tirai fuori ancor prima di entrare. All’inizio dell’adolescenza avevo già deciso che il mondo degli affari avrebbe dovuto fare a meno di me. Credo che quello sia stato il mio peggior periodo: non fui mai altrettanto confuso e insopportabile. Ardevo del fuoco sacro del mio nuovo idealismo, e i rigori della perfezione mi trasformarono in un aspirante puritano in miniatura. Gli sfoggi di ricchezza mi ripugnavano, e trattavo con disprezzo ogni elemento di ostentazione che i miei genitori introducevano in casa nostra. La vita era ingiusta: alla fine lo avevo stabilito, ed essendo stata una mia scoperta personale, mi colpí con forza apocalittica. Col passare dei mesi, trovavo sempre piú disagevole conciliare la mia buona sorte con la sfortuna di tanti altri. Che cosa avevo fatto per meritarmi gli agi e i vantaggi che si erano riversati su di me? Mio padre se li poteva permettere, ecco tutto; e che lui e mia madre litigassero o meno sui quattrini contava poco se rapportato al fatto che avevano dei quattrini su cui litigare. Io friggevo ogni volta che dovevo salire sulla macchina dei miei: cosí appariscente e nuova e dispendiosa, un invito cosí smaccato al mondo ad ammirare la nostra prosperità. Tutte le mie simpatie andavano agli oppressi, agli espropriati, agli ultimi dell’ordinamento sociale, e un’auto come quella mi faceva morire di vergogna: non solo per me stesso, ma per il fatto di vivere in una società dove simili cose avevano diritto di cittadinanza.
I miei primi mestieri non contano. Ero ancora mantenuto dai miei genitori, e non avevo nessun obbligo di provvedere a me stesso o di contribuire al bilancio familiare. Non ero sotto pressione, e quando non si è sotto pressione non si rischia niente di importante. Ero contento di avere il denaro che guadagnavo, ma non dovevo mai usarlo per necessità pratiche, non dovevo mai preoccuparmi di mettere in tavola il pranzo o di non restare indietro con l’affitto. Questi problemi sarebbero venuti in seguito. Per ora ero soltanto un liceale in cerca di un paio di ali con cui volare via da dove mi trovavo.
A sedici anni, feci per due mesi il cameriere in un campeggio estivo nello Stato di New York. L’estate dopo lavorai nel negozio di elettrodomestici di mio zio Moe a Westfield, New Jersey. Erano dei lavori molto simili, nel senso che erano sostanzialmente manuali e non richiedevano molto cervello. Anche se portare vassoi e stoviglie era un po’ meno interessante che installare condizionatori o scaricare frigoriferi da camion lunghi quindici metri, non ne farei una questione troppo grossa. Non si trattava di mele e di arance, ma di due qualità di mele, ed entrambe della stessa tonalità di verde. Tuttavia, per monotoni che fossero, mi diedero un’immensa soddisfazione. Entravo in contatto con troppi tipi pittoreschi, dovevo assimilare troppi pensieri nuovi per risentire dello sforzo fisico, e non ebbi mai l’impressione di buttare il mio tempo al solo scopo di riscuotere un salario. Certo, i soldi importavano, ma non lavoravo solo per guadagnare: mi serviva a capire chi ero e come mi sarei inserito nel mondo.
Anche al campeggio, dove i miei colleghi erano tutti studenti di sedici o diciassette anni, gli sguatteri di cucina provenivano da un mondo crudamente diverso. Nullatenenti, barboni della Bowery, personaggi dalle dubbie esperienze: il proprietario del campeggio li aveva reclutati dalle strade di New York convincendoli ad accettare un lavoro sottopagato che però garantiva due mesi di aria fresca e vitto e alloggio gratis. Generalmente non resistevano per molto. Un bel giorno sparivano, tornavano in città senza dire né ciao né arrivederci. In un paio di giorni il fuggiasco veniva rimpiazzato da un’altra anima persa, che a sua volta sarebbe durata poco. Ricordo uno dei lavapiatti, si chiamava Frank: un tipo arcigno e burbero con gravi problemi di alcolismo. Non so come, ma facemmo amicizia, e alla sera, finito il lavoro, qualche volta ci sedevamo a parlare sui gradini nel retro della cucina. Scoprii che Frank era colto e molto intelligente. Aveva fatto l’assicuratore a Springfield, Massachusetts, e prima di essere sopraffatto dal bere, aveva vissuto da bravo cittadino che produce e paga la tasse. Ricordo perfettamente che non ebbi mai il coraggio di chiedergli cosa fosse successo, ma una sera fu lui a dirmelo...