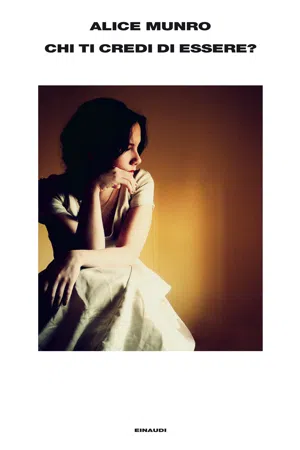Rose si innamorò di Clifford a una festa organizzata da Clifford e Jocelyn a cui lei e Patrick parteciparono. Al tempo erano sposati da tre anni, Clifford e Jocelyn da circa un anno in piú.
Clifford e Jocelyn abitavano oltre West Vancouver, in uno di quei villini estivi mal coibentati che si allineavano sulle viuzze tortuose tra la statale costiera e il mare. La festa ebbe luogo in marzo, in una sera di pioggia. Rose era nervosa all’idea di andarci. Attraversando West Vancouver le venne quasi la nausea, mentre osservava le luci al neon colare nelle pozzanghere sul selciato, e ascoltava lo stridore implacabile dei tergicristalli. In seguito, le sarebbe spesso capitato di ripensarci e di vedere se stessa seduta accanto a Patrick, in camicetta nera scollata e gonna di velluto nero, con la speranza che quello si rivelasse un abbigliamento adatto all’occasione, e con una gran voglia di andare invece semplicemente al cinema. Non poteva sapere che la sua vita stava per cambiare.
Era nervoso anche Patrick, ma non lo avrebbe mai ammesso. La vita sociale era un compito frastornante e spesso spiacevole per tutti e due. Erano arrivati a Vancouver senza conoscere nessuno. Cercavano di adeguarsi. Rose non sapeva se davvero volevano farsi degli amici o se si sentivano solo in dovere di averne. Si vestivano bene e andavano a trovare qualcuno, oppure mettevano in ordine il soggiorno e aspettavano ospiti a casa loro. In certi casi stabilirono dei cicli di visita regolari. Bevevano qualcosa, nel corso di quelle serate, e intorno alle undici, undici e mezza – un’ora che pareva non arrivare mai con sufficiente tempestività –, Rose andava in cucina a preparare il caffè e qualcosa da mangiare. Di solito si limitava a tartine di pane tostato con sopra una fetta di pomodoro, un cubetto di formaggio e una fettina di pancetta, il tutto passato al grill e fermato con uno stuzzicadenti. Non le veniva in mente nient’altro.
Era piú facile per entrambi fare amicizia con gente che piaceva a Patrick, perché Rose sapeva adattarsi fino a sfiorare l’ipocrisia, mentre Patrick non si adattava per niente. In questo caso però, nel caso di Jocelyn e Clifford, gli amici erano di Rose. O quantomeno, Jocelyn. Jocelyn e Rose erano abbastanza sagge da non aver mai cercato di frequentarsi in coppia. Patrick trovava Clifford antipatico anche senza conoscerlo, perché faceva il violinista; e indubbiamente Clifford trovava antipatico Patrick perché lavorava in una filiale dei grandi magazzini di famiglia. Al tempo, le barriere sociali erano ancora solide e forti; tra artisti e uomini d’affari; tra uomini e donne.
Rose non conosceva nessuno degli amici di Jocelyn, ma sapeva che tra loro c’erano musicisti, giornalisti, docenti universitari e perfino una sceneggiatrice di cui avevano trasmesso una commedia alla radio. Se li immaginava intelligenti, spiritosi e facilmente sprezzanti. Aveva la sensazione che, mentre lei e Patrick passavano le serate in qualche salotto, in casa d’altri o propria, la gente davvero brillante e simpatica, quella che a buon diritto li guardava dall’alto in basso, conducesse esistenze trasgressive e partecipasse ad altre feste. E adesso che avevano l’occasione di mescolarsi a quelle persone, il suo stomaco non ne voleva sapere, e le sudavano le mani.
Jocelyn e Rose si erano conosciute al reparto maternità del General Hospital di North Vancouver. La prima cosa che Rose vide, tornando in camera dopo aver avuto Anna, fu Jocelyn che, seduta sul letto, leggeva il Diario di André Gide. Riconobbe il libro dai colori della copertina, perché l’aveva notato nell’espositore del drugstore. Gide era sulla lista di autori che intendeva affrontare. In quel periodo leggeva soltanto classici.
La cosa che per prima la sorprese e rassicurò di Jocelyn, fu quanto sembrasse una studentessa, quanto poco si fosse lasciata contagiare dall’atmosfera del reparto maternità. Con le sue lunghe trecce nere, il faccione pallido e gli occhiali spessi, Jocelyn non mostrava traccia di banale avvenenza, ma aveva in compenso un’aria serena e riflessiva.
La donna sul letto accanto a quello di Jocelyn stava illustrando la disposizione dei mobili di cucina. Ogni tanto si scordava di precisare dove teneva, che so, il riso, o lo zucchero di canna, e a quel punto ricominciava tutto da capo, assicurandosi che le astanti continuassero a seguirla con domande tipo: «Vi ricordate, no, che sul ripiano in alto a destra, vicino al gas, tengo le minestre, quelle liofilizzate però, non quelle in lattina, che vanno sotto il piano di lavoro con l’altro scatolame, beh, proprio lí di fianco…»
Qualcuna cercava di intervenire e specificare a sua volta come ordinava le cose, ma non c’era verso, se non per pochi secondi. Jocelyn stava seduta a leggere, attorcigliandosi il fondo della treccia sulle dita, come se si trovasse in biblioteca, all’università, come se stesse facendo ricerca per un saggio e quel mondo di donne non le si fosse mai chiuso intorno. Cosa avrebbe dato Rose, per riuscire a fare altrettanto.
Era ancora stordita dal parto. Se chiudeva gli occhi, continuava a vedere un’eclissi, una grossa palla nera dentro un anello di fuoco. Era la testa della bambina, circondata dal dolore fisico, l’attimo prima che la spingesse fuori. L’immagine era attraversata, a ondate irritanti, dai mobili di cucina della donna, schiacciati dal peso immane di scatole e lattine. Ma poteva sempre decidere di aprire gli occhi e vedere Jocelyn, bianca e nera, con le lunghe trecce appoggiate sulla camicia dell’ospedale. Jocelyn era, secondo lei, l’unica lí dentro dotata della solennità placida adatta alla circostanza.
Poco dopo, Jocelyn scese dal letto, rivelando lunghe gambe pallide non depilate e la pancia ancora tesa dalla gravidanza. Si infilò un accappatoio a righe. Al posto della cintura, si legò in vita una cravatta da uomo. Si avviò sul linoleum dell’ospedale scalpicciando a piedi nudi. Accorse subito un’infermiera per dirle di mettersi le pantofole.
– Non ce le ho, le pantofole.
– E le scarpe, le ha? – chiese piuttosto brusca l’infermiera.
– Beh, sí. Le scarpe le ho.
Jocelyn tornò a un armadietto metallico accanto al letto e ne estrasse un paio di mocassini sporchi e sfondati. Poi ripartí, sciabattando con la stessa rumorosa insolenza di prima.
Rose aveva una voglia matta di conoscerla.
L’indomani, anche Rose tirò fuori il suo libro. Era L’ultimo puritano di George Santayana, purtroppo preso in biblioteca; il titolo in copertina, ormai sbiadito, era illeggibile, perciò Jocelyn non avrebbe potuto ammirare le letture di Rose come lei aveva ammirato le sue. Rose non sapeva come attaccare discorso.
La donna che aveva spiegato tutto dei suoi armadietti di cucina adesso parlava di come usava l’aspirapolvere. Disse che era fondamentale sfruttare tutti gli accessori, perché ciascuno aveva una sua funzione specifica e poi con quello che costavano… Molte non li utilizzavano. La donna spiegò come puliva i tendoni in soggiorno. Un’altra disse che ci aveva provato anche lei, ma la stoffa finiva risucchiata a grumo nell’aspirapolvere. L’autorità in materia sentenziò che evidentemente sbagliava metodo.
Rose intercettò lo sguardo di Jocelyn oltre l’angolo del libro.
– Mi auguro che tu lucidi le manopole del gas, – disse a bassa voce.
– Ci mancherebbe, – rispose Jocelyn.
– Tutti i giorni?
– Due volte al giorno, prima, ma adesso, con il bambino, non so se potrò piú permettermelo.
– Usi quel prodotto apposta?
– È ovvio. E lo passo con lo straccio da manopole del gas che vendono insieme, nella confezione speciale.
– Brava. C’è gente che se ne frega.
– C’è gente capace di usare qualunque cosa.
– Anche la cartavetro.
– Anche la carta igienica.
– E se non è igienica, fa lo stesso.
Dopodiché, la loro amicizia fiorí in un baleno. Una di quelle intimità profonde favorite da istituzioni come scuole, colonie, galere. Si aggiravano nei corridoi, trasgredendo agli ordini delle infermiere. Tormentavano e disorientavano le altre pazienti. Ridevano come scolarette per certi passi che si leggevano reciprocamente ad alta voce. Non da Gide o da Santayana, ma dalle copie di «True Love» e «Personal Romances» trovate in sala d’attesa.
– Qui dice che si possono comprare polpacci finti, – leggeva Rose. – Però! Ci sarà la fila! Dice che si attaccano direttamente alle gambe, o si infilano dentro le calze.
– Colpacci? – domandò Jocelyn. – Attaccati alle gambe? Ma cosa dici? Di cosa parli?
Bastava una cosa del genere a dar loro il la.
– Colpacci finti?
– Ma no, polpacci. Tette finte, culi finti, polpacci finti, no?
– Che cosa si devono ancora inventare…
La donna dell’aspirapolvere disse che si intromettevano sempre disturbando i discorsi delle altre e che non capiva che cosa ci fosse di tanto divertente nelle parolacce. Aggiunse che se non la smettevano, rischiavano che gli si inacidisse il latte.
– Me lo stavo proprio chiedendo, se il mio non fosse già acido, – commentò Jocelyn. – Ha un colore schifoso.
– Che colore? – domandò Rose.
– Beh, dà sull’azzurro.
– Dio buono, non sarà inchiostro!
La donna dell’aspirapolvere disse che avrebbe riferito all’infermiera che bestemmiavano. Non per fare la bigotta, ma tutto aveva un limite. Dubitava che fossero adatte a diventare madri. Come se la sarebbe cavata Jocelyn a lavare i pannolini, quando era chiaro a tutti che non si lavava neanche la vestaglia?
Jocelyn rispose che avrebbe usato il muschio come gli indiani.
– Non stento a crederlo, – disse l’altra.
Dopo quello scambio di battute, Jocelyn e Rose presero l’abitudine di introdurre molte dichiarazioni con la frase: «Non per fare la bigotta, ma…»
«Non per fare la bigotta, ma da’ un’occhiata a questo budino!»
«Non per fare la bigotta, ma secondo me questa bambina ha già messo tutti quanti i denti».
L’infermiera le rimproverò, suggerendo loro di crescere, che era ora.
Passeggiando nei corridoi, Jocelyn raccontò a Rose di avere venticinque anni, che suo figlio si sarebbe chiamato Adam, che a casa ne aveva già un altro, Jerome, di due anni, che suo marito si chiamava Clifford e di mestiere faceva il violinista. Suonava nella Vancouver Symphony Orchestra. Erano poveri. Jocelyn era originaria del Massachusetts e aveva frequentato il Wellesley College. Suo padre era psichiatra e la madre pediatra. Rose le disse che lei, invece, veniva da un paesino dell’Ontario, che Patrick era di Vancouver Island e che i genitori di lui erano stati contrari al loro matrimonio.
– Dove sono nata io, – esagerò Rose, – la gente dice voialtri. Voialtri cosa bevete? Voialtri come state?
– Ma dài.
– Sí. Voialtri, l’opposto di noialtri.
– Ah. Come a Brooklyn. O in James Joyce. E Patrick, per chi lavora?
– Nel negozio di famiglia. I suoi hanno un grande magazzino.
– Allora sarai ricca, no? Non sei un po’ troppo ricca per stare in questo reparto?
– Abbiamo appena speso tutto quello che avevamo per comprare la casa che voleva Patrick.
– Perché, tu non la volevi?
– Non quanto lui.
Rose non l’aveva mai detto prima.
Procedettero verso nuove e svariate rivelazioni.
Jocelyn detestava sua madre. L’aveva costretta a dormire in una camera con le tendine di organza bianca, e incoraggiata a collezionare papere. A tredici anni, Jocelyn doveva avere la collezione di papere piú completa al mondo: di gomma, ceramica, legno, dipinte, ricamate. Aveva anche scritto quello che definí un odioso racconto infantile dal titolo Le mirabolanti avventure di Oliver, il Nonno Papero, che sua madre aveva fatalmente stampato e distribuito un Natale ad amici e parenti.
– È una di quelle persone viscide che mascherano tutto con l’ipocrisia. Sembra che coli unto su ogni cosa. Mai che parli con voce normale, mai. Tutta moine. Un mucchio di moine schifose. Naturalmente, come pediatra ha grande successo. Ha un vezzeggiativo schifoso pronto per ogni parte del corpo.
Rose, che delle tendine di organza sarebbe stata felici...