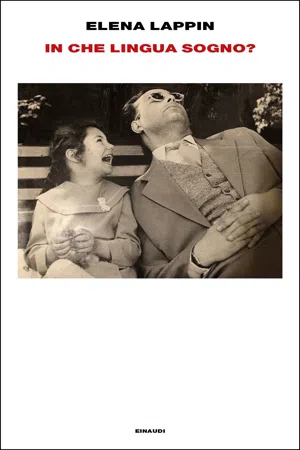Poco dopo la sua prima telefonata, V mi mandò una mail in cui tracciava, in un inglese piuttosto involuto, la storia della mia famiglia. I fatti essenziali non erano sbagliati: i nomi e le date di nascita del mio padre biologico, dei suoi genitori e di sua sorella; il lavoro di mio nonno come agente sotto copertura; le date dei loro trasferimenti. Cercava di comporre per me una piccola sintesi genealogica, affinché mi orientassi meglio nella nuova famiglia che stavo per incontrare. Lui aveva perso tutti i suoi e ci teneva che la figlia, V, conoscesse i propri parenti. – Siete cugine prime. È un legame importante –. Spiegava inoltre che di fatto era stato uno dei parenti moscoviti di mia madre, un professore universitario che conosceva per ragioni di lavoro, a metterlo sulla strada giusta. Alla fine aveva chiamato mia madre ad Amburgo e le aveva chiesto il mio numero di Londra. Mia madre gliel’aveva dato senza fare domande. Forse, dopo aver nascosto il suo grande segreto per tanti anni, aveva bisogno di sgravarsene.
Dapprima presi per buone le informazioni di V, una sintesi puntuale. Col tempo però, soprattutto quando Joseph mi fece notare alcune discrepanze, nonché il fatto che V non poteva essere un narratore affidabile di avvenimenti di cui non era stato testimone, decisi di condurre una mia ricerca personale. Per un certo periodo il giornalismo d’inchiesta – specie se relativo a vicende imperniate su qualche frode interessante – era stato il mio genere di scrittura preferito: applicare la mia curiosità alla storia della mia famiglia sarebbe stato doppiamente eccitante.
Un controllo su internet del nome del mio nonno paterno, Leon Minster, mi portò rapidamente a documenti dell’Archivio nazionale di Londra relativi alla sua attività di agente segreto a Shanghai nel 1934; poi, passo a passo, dettaglio dopo dettaglio, la vita della famiglia Minster emerse come risultato dell’indagine sistematica che portai avanti attingendo a vari strumenti di ricerca genealogica online, e a tutta la letteratura e agli archivi disponibili, compresi quelli, utilissimi, dell’Fbi – consultabili grazie al Freedom of Information Act.
D’un tratto non solo arrivai a conoscere l’identità del mio padre biologico, ma potei anche schizzare e in seguito colorare ogni centimetro, ogni dettaglio, della sua – e di conseguenza mia – storia famigliare. Storia che mi condusse, molto velocemente, al presente. La storia è la mappa nascosta del chi, dove e come siamo oggi. Pochi giorni dopo avere scoperto il nome di mio nonno sulla prima pagina di un quotidiano del Connecticut dell’agosto 1951, scovai il nome da sposata di una delle sue numerose sorelle. Altri articoli menzionavano suo figlio, e le altre sorelle. Vi erano annunciati e descritti vari avvenimenti della comunità locale, e io cominciai a farmi un quadro di parecchi decenni della vita del mio prozio e delle mie prozie. Era citato anche il mio bisnonno, in relazione a un servizio religioso in sinagoga. A uno a uno i membri della famiglia nascosta cominciarono a emergere dalle ombre del lontano passato, assumendo la forma di persone i cui nomi erano negli elenchi del telefono. Individuai un parente, che mi condusse agli altri. Molti altri. Dopo un turbine di mail e di telefonate, mi ritrovai calorosamente accolta dentro una grande famiglia di cui avevo sempre ignorato l’esistenza. Garbatamente incuriositi dalle circostanze della mia nascita e parentela, i miei nuovi cugini – piú o meno alla lontana – mi aprirono un mondo completamente nuovo. Fu affascinante essere catapultata nel vecchio mondo da cui tutti venivamo: la Russia e l’Ucraina.
Mio padre Joseph non era nato in Russia bensí nel distretto newyorkese di Brooklyn. Riuscii a seguire la presenza dei suoi genitori nel registro dell’anagrafe cittadina fino alla metà degli anni Trenta. Ogni censimento effettuato negli Stati Uniti, fino a quello del 1930, mi forní informazioni importanti su entrambi i nonni paterni e le loro famiglie. Trovai i loro indirizzi esatti, le loro professioni, i nomi dei loro vicini di casa… Scoprii che erano proprietari di una stazione radiofonica. E che parlavano, leggevano e scrivevano in tre lingue: inglese, russo e yiddish. Ogni volta che un documento riportava un indirizzo, lo cercavo immediatamente su Google Maps e su Google Street View, per vedere se quel particolare edificio era ancora in piedi. Gran parte dei palazzi di Brooklyn sembravano vecchi abbastanza per essere lí dagli anni Trenta; altri erano stati sostituiti da parcheggi per le auto. La realtà virtuale di Street View non era un concetto astratto, ma lo strumento che mi consentiva di vedere, coi miei occhi, la continuità dell’effettiva sequenza temporale fisica dei miei antenati: che avevano vissuto qui, poi qui, poi qui…
Mentre riflettevo sui miei nuovi archivi, non seppi resistere all’impulso di viaggiare, se pure in modo virtuale, dalla mia scrivania londinese non solo verso quegli ignoti indirizzi newyorkesi, ma anche verso tutte le case reali in cui avevo vissuto. Prima a Mosca, poi a Praga. Poi ad Amburgo, quindi a Tel Aviv e Haifa. A Ottawa, e a Westchester. Ognuna delle case in cui avevo vissuto continuava a esistere anche dopo che me n’ero andata, e adesso ero in grado di vederla: questa finestra, quel balcone, quella porta e quel panorama… Street View innescava ricordi autentici che di colpo non avevano piú nulla di onirico, e potevano essere verificati e confrontati con le immagini che comparivano sullo schermo del mio computer. La ricostruzione narrativa della mia vita non era piú un mero esercizio che giocava con le nozioni di tempo e di spazio: era radicata in luoghi reali, legati a un tempo reale. Le nuvole fotografate da Google nel cielo sopra la mia scuola di via Ostrovní erano dolcemente familiari, come se fossero rimaste lí immobili, non toccate dai venti, dal clima e dal tempo, fin dai miei ultimi giorni a Praga.
Una simile libertà di vagabondare contemporaneamente nel passato e nel presente diventò per me una specie di droga. Localizzai Selidovo, il minuscolo villaggio ucraino dove la famiglia Minster aveva vissuto molti anni perlopiú felici, prima che, nel 1914, i miei bisnonni paterni partissero per l’America. Grazie alla mappa di internet trovai i link per un mare di foto: qualcuno aveva attraversato il villaggio da un capo all’altro, catturando e postando le varie vedute, tutte particolareggiate. Percepivo la quiete del villaggio, la silenziosa bellezza dei campi, degli alberi e del fiume, e vidi un paio di edifici fatiscenti che sembravano corrispondere alla descrizione che avevo letto nelle testimonianze famigliari circa il tipo di casa che i miei bisnonni possedevano («una grigia costruzione in muratura, a un piano, con tre camere»). Una delle mie prozie, Gertrude, aveva scritto dei brevi racconti pieni di dettagli, in una prosa letteraria e sognante, sulla sua infanzia a Selidovka. Erano ricordi nitidi, addolciti dal tempo e dalla distanza, rievocazioni di situazioni e di eventi che risalivano all’inizio del ventesimo secolo: i grandi matrimoni delle due sorelle maggiori, cui aveva partecipato l’intero villaggio, ebrei e gentili; suo padre che sbatteva fuori dalla scuola ebraica un maestro pedofilo; la cucina e la dispensa coloratissima di sua madre, traboccante di carni, cereali, frutta, verdura, aringhe, cetrioli sottaceto, uova – tutta roba fresca. Un’altra prozia, Vera, aveva raccontato i suoi ricordi a un nipote, Jonathan, che aveva utilizzato quelle conversazioni per un saggio, scritto negli anni Ottanta, in cui mescola narrazione orale e ricerca storica con risultati notevolissimi. Apparentemente ignara dei terremoti politici avvenuti nella nativa Russia all’inizio del ventesimo secolo, la mente di Vera aveva conservato fiabeschi cammei dell’infanzia vissuta in un tempo e in un luogo scomparsi. Tra la bianca fioritura degli alberi di acacia davanti alla casa di famiglia e il giardino dei ciliegi di un vicino, Vera si perdeva nelle fantasticherie, leggendo e imparando a memoria i versi di Puškin, restia a rientrare in casa quando la madre la chiamava. Vera racconta di una gita in slitta con tutta la famiglia, della casa sempre piena di bambini che mangiano, ridono, cantano e suonano la chitarra. Dipinge un ritratto dettagliato della famiglia, e soprattutto del padre, Samuel David, un uomo imponente, «metà padre, metà eroe popolare»:
Il suo aspetto ti colpiva: occhi blu, capelli neri e ricci, la barba rossa e le guance rosee. Il suo yiddish si mescolava con l’ebraico, ma con i contadini parlava solo l’ucraino. Aveva un sorriso stupendo e amichevole che catturava l’attenzione generale. E una faccia che ispirava fiducia. Lo incontravi una volta, e subito ti fidavi di lui e lui si fidava di te. Eppure gli capitò piú volte di essere imbrogliato, e di farsi spillare fino all’ultimo soldo dai truffatori. Mia madre era molto riservata. Ma per mio padre un mensch è un mensch, un uomo è un uomo, e con un uomo ci si può sempre parlare. Era il capo della comunità. C’erano altri piú istruiti di lui, non era mica un insegnante di ebraico. Tuttavia era un leader nato, e nato per pensare con la propria testa, e io l’adoravo, e anche i miei fratelli, tutti noi lo adoravamoa.
Vera descrive l’interno della loro abitazione in modo cosí minuzioso, stanza per stanza, da un angolo all’altro, che una persona capace di disegnare «a orecchio», come fanno i disegnatori della polizia scientifica quando devono realizzare un identikit, potrebbe ricavarne immagini di fotografica esattezza. Di fatto, sulla base delle descrizioni di Vera si potrebbero disegnare, oltre alla casa, anche quelli che ci vivevano: i miei bisnonni e i loro quattordici figli, uno dei quali sarebbe diventato il mio nonno paterno. In America si chiamava Leon; in Unione Sovietica, Grigori; ma nella Russia zarista della sua infanzia il suo nome era stato Israel. Lo scoprii solo grazie alle liste passeggeri del piroscafo su cui, nel luglio 1914, la famiglia emigrò in America, e che per ironia della sorte si chiamava Czar. Non so come lo chiamassero in famiglia, a Selidovka, perché nel racconto di Vera appare di rado, e solo quando si riferisce collettivamente ai fratelli come «i ragazzi». È quasi come se Leon fosse stato cancellato dalle cronache famigliari, o lui stesso si fosse cancellato. Eppure la vita di Leon è la chiave delle mie origini.
Grazie alla trascrizione di questi ricordi, e ai miei scambi personali con i parenti americani da poco scoperti, possiedo ora una visione d’insieme della famiglia che non ho mai conosciuto, e dalla cui storia sono stata escissa. C’è della saggezza nella legge ebraica secondo cui l’ebraicità si trasmette solo per via materna; il ragionamento è che non si può mai essere certi della paternità. Tuttavia nel mio caso l’ebraicità non è mai stata incerta: entrambi i miei padri erano ebrei al cento per cento e, a risalire un po’ indietro nel tempo, le loro radici non erano nemmeno troppo diverse né troppo lontane geograficamente.
Il kitsch sentimentale delle radici ebraiche esteuropee è una miscela commercializzata, in varie forme artistiche, che combina Il violinista sul tetto e i tableaux alla Chagall, una visione color seppia della vita nella Russia prerivoluzionaria, un set di scene idilliache in cui gli ebrei appaiono confinati e ridotti a un’esistenza di perenne malinconia, costellata di canti e danze yiddish. Sebbene vivessero segregati e disponessero di mezzi limitati in quanto minoranza mal sopportata e spesso perseguitata a morte, la vita degli ebrei dell’Europa orientale era tutt’altro che triste, insipida o monotona. Era un mondo ricco e sfaccettato, che copriva l’intera gamma dall’ebraismo, da quello ultraortodosso a quello secolarizzato, e degli orientamenti politici, un universo intellettualmente e artisticamente vibrante, semplice e al tempo stesso sofisticato. La sua letteratura (in ebraico e in yiddish), con gli interrogativi sovversivi e la rottura dei tabú e dello status quo culturale, anticipa la letteratura ebraico-americana.
I ricordi della prozia Vera sulla famiglia di mio padre, quelli che vivevano in Ucraina ed emigrarono in Connecticut, ha una chiusa bizzarra: «Bene, questo è tutto. Ogni cosa fugge via come un sogno. E questa è la nostra vita», dice Vera, prima in ebraico, poi in inglese. Ma non c’era niente di onirico nel ritratto realistico e minuzioso della loro vita famigliare. Partirono alla vigilia della Prima guerra mondiale, e pochi anni prima della Rivoluzione. Quei due eventi che trasformarono il mondo accaddero senza la loro presenza o partecipazione. Eppure spesso mi domando se mio nonno non avesse contratto il virus rivoluzionario da adolescente, quando viveva ancora in patria, e se non sia stato proprio questo a determinare la sua successiva adesione politica ai servizi segreti militari dell’Unione Sovietica. Se i Minster fossero rimasti, forse anche loro sarebbero cambiati alla forzata velocità della luce rivoluzionaria.
Nei racconti delle sue figlie, il mio bisnonno Samuel David emerge come una figura quasi mitica che non sarebbe stata fuori luogo in un western. Non c’è traccia in lui dell’ebraicità dello shtetl: è l’agiato proprietario, sicuro di sé, ottimista, indipendente, di un frantoio e di tre case, nonché un mercante di cavalli, a quanto pare di successo. La vita della famiglia fa pensare piuttosto a un ranch da qualche parte in Texas… Samuel David gode del rispetto della popolazione ucraina, invita tutto il dorf all’annuale festa di Capodanno, in casa si parlano ucraino e russo, non solo yiddish. Tutti amano cantare e non dimenticheranno mai i canti popolari del loro paese. In casa ci sono armi da fuoco, per autodifesa, ma vengono usate di rado. Salvo una volta, quando l’onda del pogrom si avvicina a Selidovka e il padre non c’è perché, come capita spesso, è in viaggio di lavoro. Allora l’intera famiglia si trasferisce da certi contadini amici mentre il maggiore dei figli monta la guardia alla casa imbracciando il fucile. Il pogrom passò oltre il villaggio; la paura e lo stato di allerta rimasero. Forse il primo germe dell’idea di fuggire dai pericoli della Russia e partire per l’America nacque allora, e giunse a maturazione qualche anno dopo, quando il figlio maggiore fu reclutato dall’esercito dello zar – e il padre e un fratello riuscirono a prelevarlo dal luogo dove prestava servizio militare e a farlo espatriare clandestinamente.
I registri di Ellis Island documentano l’arrivo a New York di Temma, la mia bisnonna, insieme a nove dei suoi figli, su una nave proveniente dalla Lettonia. Suo marito e due figli piú grandi erano arrivati già da alcuni mesi, seguendo un itinerario piú tortuoso. Per parecchio tempo non mi riuscí di trovare nessuna traccia del loro arrivo, poi misi finalmente le mani sull’elenco dei passeggeri di una nave partita da Brema, Germania, in cui scovai i nomi dei due fratelli, i miei giovani prozii. Il padre era già a New York. In famiglia ancora si racconta lo choc di Temma quando, mettendo piede sulla banchina del porto, rivide il marito dopo molti mesi di separazione: si era tagliato la maestosa barba rossa. Pensò che si fosse convertito al cristianesimo. Di fatto lui non abbandonò mai le sue convinzioni religiose e divenne un membro fedele della sua sinagoga nel Connecticut. Tuttavia, sotto altri aspetti, non posso fare a meno di pensare che negli Stati Uniti quell’animo forte abbia finito con lo spezzarsi. Grazie ai guadagni e ai risparmi accumulati con le sue fiorenti attività in Russia, Samuel David era arrivato a New York con una piccola fortuna. Depositò tutto in una banca, che poco dopo fallí. E lui perse tutto. L’arrivo nella terra promessa americana fu per il mio bisnonno un ironico e desolato contraltare della vita condotta in patria: un uomo che, in Russia, aveva mantenuto una famiglia di quindici persone con la sua intelligenza e le sue capacità, di colpo diventò un vecchio (non in senso anagrafico) che dipendeva dai figli. Lui, che un tempo batteva la campagna russa, quali che fossero le condizioni atmosferiche, per combinare affari e prendere contatti, e poi tornava a casa allegro ed eccitato, carico di soldi e cibarie, si ridusse dall’oggi al domani a essere un anziano pater familias che vivacchiava in placidi sobborghi metropolitani. Ma se non fossero emigrati, il futuro suo e della sua famiglia probabilmente sarebbe stato assai piú fosco: dopo la Rivoluzione le loro attività commerciali sarebbero state espropriate o distrutte, avrebbero dovuto affrontare la miseria e la fame durante la guerra e, come tanti altri ebrei ucraini, la prospettiva di essere ammazzati dai nazisti. Perciò un po’ di noia e forse persino depressione nei sobborghi americani non furono un prezzo troppo alto perché la famiglia potesse vivere in libertà e, col tempo, nella prosperità.
L’unico lavoro che Samuel David tentò nel nuovo paese fu quello di sensale di matrimoni, che nella comunità ebraica è un servizio onorato, una mitzvah che di solito svolgono le donne. Forse era solo un’estensione del suo considerevole fascino personale, delle sue capacità affabilmente comunicative e del suo genuino interesse per gli altri. La sua stessa vita coniugale, come tanti altri aspetti della sua vita, potrebbe essere la materia per una romantica storia nera. Samuel David aveva sposato due sorelle. La prima, Masha, morí poco dopo avere dato alla luce il loro terzo figlio, che sarebbe diventato il giovanotto la cui chiamata alle armi, nel 1914, avrebbe innescato l’esodo dell’intera famiglia. Dopo qualche tempo (non molto, bisogna dirlo) il vedovo si rese conto che gestire due bambini piccoli, un neonato e gli affari era troppo per lui, e chiese aiuto ai suoceri, i quali gli offrirono la sorella minore di Masha, come madre per i semiorfani, e come moglie. – Lei mi vuole? – chiese Samuel David. Lei disse che no, non lo voleva. Ma i genitori decisero altrimenti. – Ti sposerà, – dissero. – È la volontà di Dio.
In famiglia si racconta che Temma, la sorella minore, fosse innamorata di un ragazzo, ma per lei era impensabile disubbidire ai genitori. Cosí sposò il cognato, e il letto in cui sua sorella aveva partorito ed esalato l’ultimo respiro divenne il suo. Anno dopo anno arrivarono nuovi bambini, finché alla fine furono quattordici (tra quelli di primo e quelli di secondo letto). All’inizio avevo dei dubbi, mi chiedevo se la mia bisnonna non fosse la sorella maggiore dimenticata (dimenticata perché in famiglia era diventato un tabú ricordare che c’erano state due madri e che i fratellastri erano anche cugini) e temevo che non avrei mai saputo dove era sepolta. Non so perché, ma mi sembrava importante. Poi però i calcoli e i confronti fra le date di nascita confermarono in maniera definitiva che la mia bisnonna era Temma, la sorella piú giovane. Se non avesse rinunciato al primo, vero amore, e si fosse rifiutata di sposare il cognato, non si sarebbe creata la catena di eventi che portò alla mia nascita a Mosca. So esattamente in quale cimitero del Connecticut sono sepolti lei e il marito, i miei bisnonni paterni. Morirono entrambi negli anni Quaranta. Certo dovettero chiedersi che fine avesse fatto quel figlio – mio nonno – che nel 1934 aveva lasciato New York con la moglie e due bimbi piccoli. Sapevano che era tornato in Russia con la famiglia? Come avrebbero interpretato quel rovesciamento dell’ottimistica odissea di Samuel David dall’oppressione nel vecchio paese alla libertà in America? Se lo vennero a sapere, saranno stati quantomeno perplessi. O, piú probabilmente, in collera.
Ho due straordinari ritratti fotografici dei miei bisnonni paterni all’inizio della mezza età. Sono foto a colori, forse ritoccate. Temma ha un viso aperto, piacevole, ma serio, con i capelli e gli occhi scuri, la fronte alta e le sopracciglia dritte; ha un’aria fiera e capace: è una donna che comanda sul suo territorio. A Samuel David quegli occhi blu (un tratto genetico dominante in famiglia), i capelli neri e la barba rossa danno un’aria drammatica e risoluta. Nei racconti che fece al nipote, la mia prozia Vera riuscí a descrivere il loro ambiente e il loro carattere in modo da farmi sentire fam...