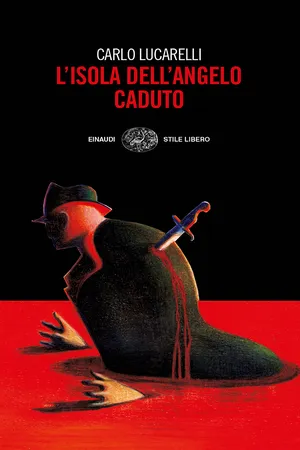Fu un rumore a svegliarlo, e ancora nel sonno, con gli occhi chiusi, il commissario immaginò che fossero piccioni, tanti piccioni appollaiati nella stanza. Stavano sui mobili, sulla testiera del letto, sul comodino, sulla bacinella del lavamano, gonfi e rotondi, con la testa affondata nel petto. Non muovevano le ali ma battevano le zampe sul legno e sulla porcellana, su e giú, ed era quello il rumore, un calpestio leggero ma intenso, frenetico.
Il commissario aprí gli occhi e vide che nella stanza non c’erano piccioni, ma sua moglie. Una sagoma scura, prima, davanti al cassettone, ancora indistinta e lucida di sonno rappreso tra le palpebre, poi Hana dai contorni definiti nella penombra, in camicia da notte. Si muoveva veloce e quasi silenziosa, grattava nei cassetti, picchiettava con le dita sul piano dei mobili e scivolava fino a un tavolino, in un sottile frusciare di stoffa.
– Cosa c’è? – chiese il commissario. – Che stai facendo?
– Preparo la valigia, – sussurrò Hana, come se non volesse svegliarlo.
– La valigia?
– Sí. Per il viaggio –. Smise di armeggiare col tavolino e si voltò in un fruscio piú rapido. – Perché? Non vuoi partire piú?
Non riusciva a vederla in volto. I suoi occhi si erano abituati alla penombra, ma Hana era ancora una macchia senza lineamenti ritagliata nell’oscurità. Si sollevò su un gomito, ma anche cosí non la vedeva. Fece scivolare la mano sul comodino, cercando i fiammiferi, e quando li trovò accese lo stoppino del lume a petrolio, girando tra le dita la rotellina che regolava la fiamma.
– Ma certo, – disse, – certo che voglio partire. Tutti vogliono andarsene da quest’isola. Però c’è tempo... devo aspettare l’ordine di trasferimento da Roma.
Alla luce della fiamma Hana aveva un’espressione assorta. Guardava di lato come se osservasse qualcosa, le labbra sporte in avanti, la ruga sottile all’angolo della bocca che non si vedeva ma c’era. Annuí all’improvviso, e lasciò cadere nella valigia aperta il corsetto che aveva in mano.
– Preparo la colazione, – disse. – Abbiamo bisogno di mangiare. Dobbiamo essere in forze per il viaggio.
Uscí dalla stanza cosí com’era, in camicia da notte, e il commissario sospirò, buttando da parte lenzuolo e coperta. Scese dal letto e si vestí in fretta, rabbrividendo quando la biancheria fredda prese il posto del camicione ancora caldo di notte e di sonno. Infilò le scarpe senza calzini e, sfregandosi le mani sulle maniche della camicia, lanciò un’occhiata all’orologio che teneva sul comodino, scoprendo che non era poi cosí presto come credeva. Prese la vestaglia di Hana, cercò le sue pantofole sullo stuoino dalla sua parte del letto e la raggiunse in cucina.
Hana stava imburrando una fetta di pane. Dopo aver spalmato uno strato di burro altissimo, lo coprí di marmellata. Poi appoggiò la fetta su un piatto, si leccò le dita e ne prese un’altra. Il commissario le mise la vestaglia sulle spalle, si chinò fino al pavimento, le sollevò una caviglia e le infilò una pantofola al piede. Fece lo stesso con l’altro e quando si rialzò Hana aveva finito di coprire di marmellata la seconda fetta e cosí poté infilarle le maniche della vestaglia, tirando la stoffa sul gomito perché teneva aperte le dita appiccicose. Quando le ebbe allacciato l’ultimo bottone sotto al collo, Hana sembrò riprendere coscienza di sé e corse rapida al fuoco, a controllare la caffettiera.
Il commissario si sedette al tavolo di cucina. La caviglia di Hana era ghiacciata e ne aveva ancora il ricordo freddo sulla punta delle dita. Per contrasto, pensò alla pelle rovente della moglie dell’inglese e allora scosse la testa per scacciare quel pensiero. Prese una fetta di pane pesante di burro e marmellata e ne staccò un morso, anche se la mattina, di solito, non riusciva a mangiare niente. Il gusto dolce delle ciliegie e la densità salata del burro gli sigillarono la bocca mentre cercava di concentrarsi sul fatto che, in tutto quel tempo, quella era forse la prima volta che Hana usciva dalla sua stanza. Poi, il sibilo della napoletana e l’odore amaro del caffè lo stordirono con un desiderio cosí forte che sentí male alle giunture della mascella, sotto le orecchie.
– Avremo una casa grande quando saremo là, – disse Hana, versandogli il caffè, e lui stava per risponderle ma lei continuò a parlare, facendogli capire che quella non era una domanda. – Con un terrazzo. Il terrazzo è importante... dà sulla strada e si può vedere chi passa.
– Non so neppure dove mi mandano. A Roma, a Bologna... a Trento. Può essere anche in un paesino.
Hana annuí ancora, come seguendo un discorso tutto suo. Prese una fetta di pane e la morse a fondo, lasciando i segni dei denti nel burro arrossato di ciliegie.
– Magari è un posto di frontiera con quattro case e una strada, – disse il commissario, cauto, soffiando sul caffè. Hana socchiuse gli occhi e sorrise come a una battuta. Aveva finito il pane e si leccò le labbra, raccogliendo una briciola all’angolo della bocca.
– O forse è oltremare, in colonia...
Hana prese la sua tazza. Schiuse le labbra sul caffè e ne bevve un sorso, poi alzò gli occhi sul commissario, guardandolo da sopra il bordo di porcellana. Lui l’aveva sempre trovata bellissima quando faceva cosí. Bellissima.
– Non importa, – disse lei, scostando la tazza dalla bocca. – Sarà quel che sarà, basta che non sia qui.
Bevve un altro sorso e lo guardò ancora. Bella. Bellissima.
– Qui no, – disse. – Qui c’è il Diavolo.
Il commissario non ebbe il tempo di rispondere. Le dita sudicie di Martina lo toccarono sul braccio, facendolo sobbalzare. Non l’aveva sentita avvicinarsi e il fatto che non avesse sentito neppure il rumore del chiavistello significava che aveva lasciato aperta la porta di casa quando era rientrato, la sera prima. Gli tornò in mente come fosse corso in camera a lavarsi perché Hana non gli sentisse addosso l’odore di quello che aveva fatto, e di come le fosse stato lontano finché non si era addormentata. Il pensiero di Hana e Miranda non lo aveva neanche piú sfiorato e si era sbiadito come il fantasma di un sospetto assurdo, da usarsi solo come stupida e meschina scusa per giustificare il suo tradimento. Di nuovo si sentí strangolare dal senso di colpa e con un sorso buttò giú il caffè ormai freddo, mentre Hana diceva: – Finito qui, vieni ad aiutarmi con la valigia, – e Martina rispondeva: – Appena fatto, signora.
Cercando di non pensare a nulla, guardò Martina che si muoveva svelta per la stanza, toglieva le tazze, spazzava dalla tavola le briciole di pane, raccolte nella mano a coppa, e le gettava nel camino spento. La guardò mentre gli girava attorno con la scopa in mano, impicciata, piú che imbarazzata, dalla sua presenza, e la vide prendere la legna e accendere il fuoco. Poi, sempre senza pensare, quasi ipnotizzato da gesti a cui non si interessava, la vide afferrare un ventaglio di piume, montare in piedi su un ciocco di legno e sporgersi sull’alzata del camino per sventolare il fuoco. In equilibrio sul ciocco, le dita dei piedi agganciate alla curva del legno e il busto piegato, con una mano appoggiata ai mattoni del camino e l’altra protesa in avanti, le vide il grembiule salire sulle gambe, veloce, a scoprire le cosce, la curva delle natiche e la pelle nuda e scura, e allora si alzò di scatto e pensando bestia che sono! scappò dalla cucina.
Era l’oscurità piú nera che avesse mai visto. La piú cieca. Il buio piú denso, chiuso e totale. Anche a sbattere le palpebre, a stringere gli occhi e fissarli in avanti, non si riusciva a intravedere una luce, una traccia piú pallida, neppure i contorni delle cose che dopo un po’ si disegnano sempre nel buio, come ombre in rilievo. Era un’oscurità piena, senza sfumature, liquida e compatta come un bagno di pece, cosí assoluta, avvolgente e infinita che anche i rumori, i suoni e i ronzii sembravano scomparsi, assorbiti e inghiottiti da un silenzio nero. Era l’oscurità piú completa che avesse mai visto, e mentre si diceva questo Valenza pensò che era surreale e ancora piú assurdo, perché l’oscurità non si vede.
Sapeva bene dove fosse. Era all’Inferno. Lo aveva capito appena gli avevano aperto la porta di ferro e aveva visto la cella graffiata di scritte lucide e nere, perché le pareti erano di lava e non si sbiancavano a scorticarle di nomi, date e bestemmie. Chi era stato in quella cella, come Friedrich, l’aveva descritta cosí, i muri, il soffitto e il pavimento opachi e grezzi, e l’aveva chiamata usando quel nome che doveva avergli dato il primo detenuto che ci era finito dentro. L’Inferno.
Appena gli avevano chiuso la porta alle spalle, la luce era sparita di colpo e si era sentito il buio addosso, schiacciato e stretto da una sensazione di smarrimento cosí forte che gli era sembrato di sentirsi sollevare da terra. Aveva anche allargato le braccia, annaspando nel vuoto con gli occhi che gli bruciavano, senza fiato, come se davvero quel buio liquido come la pece gli fosse entrato in gola e nel naso e gli avesse riempito le orecchie. Quando poi era caduto a terra, il colpo delle ginocchia sulla pietra del pavimento gli aveva dato una scossa. Ma già poco dopo, non appena si era abituato al freddo della lava, che era diventato il freddo dell’aria e anche il freddo delle sue ginocchia, aveva dovuto toccarsi con le mani per sapere di esistere ancora.
Poi si era addormentato, in quel silenzio senza luce e senza tempo, ed era caduto in un sonno cosí profondo che non si era neppure accorto che qualcuno fosse entrato per portargli da mangiare. Lo aveva capito dall’odore della minestra, che prima non c’era, e ne aveva avuto la certezza quando ci aveva infilato dentro le dita, tastando a caso sul pavimento.
La minestra sulla lingua, il metallo della scodella tra le labbra, il pavimento duro sotto il sedere e la parete nodosa dietro la schiena e sotto la nuca, quando piegava indietro la testa. Altro della cella non sapeva. Non aveva allungato le mani oltre quella minestra, non aveva esplorato la parete, si era limitato ad accucciarsi sul posto, stretto su se stesso come un feto.
Perché aveva paura, Valenza.
Ma non del buio, dei pesci.
Nonostante fosse uno scienziato e avesse studiato, toccato e dissezionato quasi ogni specie vivente conosciuta sulla terra, esseri umani compresi, anzi, soprattutto esseri umani, il professor Valenza aveva paura dei pesci.
Non di tutti. Le acquadelle che ondeggiavano vicino alla riva del mare come schegge d’argento e che scartavano tutte assieme da una parte quando immergeva le dita in mezzo al branco, quelle non gli facevano paura. E neanche i pesci rossi che da bambino aveva vinto alla fiera di San Gennaro gli facevano paura: non gliene facevano quando rimaneva a osservarli dentro la boccia piena d’acqua, le bocche e gli occhi ingigantiti dalla curvatura del vetro, e non gliene avevano fatta quando li aveva trovati a galleggiare a pancia all’aria, lividi e gonfi, perché aveva dimenticato di dargli da mangiare. E neppure i rombi, le spigole, le sarde e le passere che quasi tutti i venerdí, fino a quando non si era iscritto all’Università, sua madre lo aveva costretto a guardare, annusare e toccare, la mattina presto, al mercato del pesce, e a prendere dalle mani argentate di squame dei pescatori mentre ancora si dibattevano in un foglio di carta bagnata e sanguinante: neppure quelli gli facevano paura.
Erano i polipi, con i loro occhi liquidi e le bocche nascoste sotto ai tentacoli coperti di ventose. I polipi lo spaventavano. E anche i crostacei, le aragoste, i gamberoni e gli astici che si contorcevano sul ghiaccio con le chele aperte, le antenne che sforbiciavano nell’aria e quelle zampe sottili da ragno.
Ma soprattutto i pesci mostruosi degli abissi.
Quelli sí che lo terrorizzavano, quegli aborti albini dalle bocche spaventose, gli occhi fosforescenti appesi in cima alle antenne e le pinne corte e tozze. Aveva urlato la prima volta che li aveva visti disegnati sull’atlante animale, riprodotti dai cartografi che li avevano pescati per errore scandagliando le profondità degli oceani o ricostruiti sui dati delle esplorazioni sottomarine. Soltanto l’idea che da qualche parte, sospesi nelle profondità piú nere degli abissi, ci fossero quegli esseri mostruosi lo faceva correre fuori dall’acqua con una scusa qualunque, anche se stava facendo il bagno a pochi passi da riva.
Aveva cercato una spiegazione al suo terrore e ne aveva trovata una simbolica. Aveva pensato che lui, uomo di scienza e raziocinio, vedesse in quegli incubi assurdi, che sembravano vomitati dalla notte piú cieca dell’inferno, i mostri generati dal Sonno della Ragione. I demoni dell’inconscio primordiale, le forze incontrollate del caos, tumori maligni dallo sviluppo imprevedibile, in grado di paralizzare la ragione impedendole di esercitare il suo logico dominio.
Studiare le leggi naturali che hanno prodotto quei peduncoli e quelle branchie invece di chiudere l’atlante. Osservare la funzione illuminante della fosforescina. Imparare a riconoscere un Mictophide da un Ceratoide, riuscire a fissare senza paura un pesce Boccatonda e una Vipera di mare, invece di irrigidirsi e serrare gli occhi, voltando anche di lato la testa.
Quando aveva cominciato a scambiare lettere e messaggi con altri attivisti politici, si era dovuto inventare un codice per sfuggire alle spie della polizia che simpatizzava con i fascisti. Forse, chiamare i capi degli squadristi con i nomi dei pesci mostruosi dell’abisso, scelti sull’atlante con un foglio di carta sotto la mano a coprire i disegni, era stato il primo passo per affrontare quella paura e cercare di vincerla. Mussolini, nel suo linguaggio clandestino da cospiratore, era uno Sternoptychide, un pesce Accetta.
Ma starsene lí, in quella cella, immerso nel buio come nella notte piú cieca dell’inferno, gli aveva fatto fare un passo indietro. Quando si era trovato avvolto da quell’oscurità nera, aveva commesso l’errore di pensare che cosí doveva essere il fondo degli oceani. E allora si era rattrappito, ghiacciato dalla paura, e non aveva piú allungato una mano per il terrore assurdo di sentirsi all’improvviso sotto le dita la bocca, gli occhi o le pinne di uno di quei pesci mostruosi.
È ovvio, si era detto, con ser...