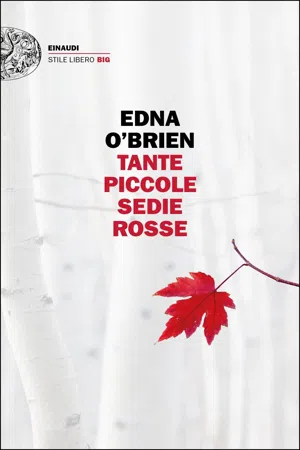La sporcizia dei viaggi Gilgamesh lavò dai capelli, le vesti lorde gettò via, indossò abiti nuovi e puliti, se li avvolse intorno, stretto al corpo un mantello con le frange, legato con la sua fascia lucente.
La cittadina prende il nome dal fiume. La corrente, rapida e pericolosa, prorompe con allegria convulsa, trascinandosi dietro pezzi di legno e ciocchi di ghiaccio. Nei piccoli anfratti dove l’acqua rimane intrappolata le pietre, blu, nere e viola, risplendono dal letto del fiume lisciate e arrotondate a perfezione, e sembra di vedere una covata di grosse uova in un cesto d’acqua. Il rumore è assordante.
Dai ramoscelli piú esili degli alberi di Folk Park sospesi sul fiume stilla con soffice sussurro il ghiaccio al disgelo, e la scultura di cerchi metallici, un pugno nell’occhio a detta di molti abitanti del luogo, è impreziosita da una collana di ghiaccioli scompigliati, bluastri nella notte gelata. Se si fosse addentrato di piú, lo straniero avrebbe visto le bandiere di varie nazioni, a indicare quanto il posto sia diventato cosmopolita e, in ossequio alla nostalgia, ci sono un vecchio macchinario agricolo, una mietitrebbia, la ruota di un mulino e la copia di un cottage irlandese risalenti a quando i contadini abitavano nei tuguri e per sopravvivere mangiavano le ortiche.
Si sofferma sulla sponda del fiume, come ipnotizzato dall’acqua.
Barbuto, un lungo cappotto scuro e i guanti bianchi, rimane sullo stretto ponticello a rimirare la corrente impetuosa, poi si guarda attorno, l’aria un po’ smarrita, la sua presenza l’unica curiosità nella monotonia di una sera invernale in un luogo gelido e sperduto che si spaccia per cittadina e di nome fa Cloonoila.
Molto tempo dopo qualcuno avrebbe riferito di strani fenomeni avvenuti quella stessa sera d’inverno; cani che abbaiavano all’impazzata, come se ci fosse il temporale, il verso dell’usignolo di cui non avevano mai udito il canto né i gorgheggi cosí a ovest. La figlia di una famiglia di zingari, che abitava in una roulotte vicino al mare, giurò di aver visto lo spirito maligno di quell’uomo entrare dalla finestra e puntarle contro un’accetta.
Dara, un giovanotto con una cresta di capelli impomatata di gel, s’illumina sentendo qualcuno smuovere esitante la maniglia della porta e pensa: «Un cliente, era ora». Quelle cacchio di leggi sulla guida in stato d’ebbrezza sono una iattura per gli affari, scapoli e ammogliati che abitano su in campagna si scolerebbero volentieri un paio di pinte, ma ci vanno cauti perché i vigili gli contano i sorsi, privando la vita delle gioie piú elementari.
– Buonasera, – dice quando apre la porta e si affaccia fuori commentando il tempo da lupi, poi i due, simulando un abbozzo di cameratismo, restano sulla soglia a riempirsi i polmoni da veri uomini.
Dara sentí il bisogno di genuflettersi quando guardò meglio la figura, una specie di santone con la barba e i capelli bianchi e un lungo cappotto nero. Aveva i guanti bianchi, che si sfilò lentamente, un dito per volta, guardandosi attorno a disagio, come se si sentisse osservato. Dara lo invitò ad accomodarsi sulla poltrona buona di cuoio vicino al fuoco, e lanciò una pila di bricchette e una punta di zucchero per attizzare le fiamme. Era il minimo che potesse fare per uno straniero. Cercava una sistemazione e Dara gli disse che avrebbe fatto mente locale. Gli prepara un whisky bollente con miele e chiodi di garofano e come sottofondo mette i Pogues nella versione piú scatenata. Poi accende qualche vecchio mozzicone di candela per creare l’«atmosfera». Lo straniero rifiuta il whisky e chiede se invece non sia possibile avere un brandy, che fa girare e rigirare nel grosso bicchiere e poi beve senza una parola. Dara, che ha la lingua sciolta per natura, snocciola tutta la sua cronistoria, tanto per fare due chiacchiere: – Mia madre una santa donna, mio padre un fanatico delle associazioni giovanili ma contrarissimo a droghe e alcol… una nipotina che è la luce dei miei occhi, ha appena cominciato la scuola, ha una nuova amichetta che si chiama Jennifer… Lavoro in due bar, qui al TJ e nel fine settimana al Castle… ci vengono i calciatori, al Castle, dei veri signori… mi sono fatto la foto con loro, ho letto l’autobiografia di Pelé, roba tosta… ho in programma una puntatina in Inghilterra, al Wembley, per un’amichevole contro l’Inghilterra… abbiamo prenotato il volo, siamo in sei, dormiamo in un ostello, sarà uno spasso. Vado in palestra, faccio un po’ di cardio e la panca, il mio lavoro mi piace da impazzire… il mio motto è: «Se fallisci nei preparativi… preparati a fallire»… Non tocco un goccio sul lavoro, ma quando esco con gli amici una bella pinta di Guinness non me la leva nessuno, vado pazzo per il calcio, mi piacciono pure i film… ne ho visto uno strepitoso con Christian Bale, ah, lui fa il Cavaliere oscuro e via dicendo, ma non è che gli horror mi sconfinferano poi tanto.
L’ospite si è un po’ animato, si guarda attorno e sembra incuriosito dalle cianfrusaglie negli angolini e negli anfratti, roba che Mona, la proprietaria del locale, ha collezionato negli anni: bottiglie di birra chiara e scura, pacchetti di sigari e sigarette con i caratteri ornamentali, un mini barile di ceramica con il rubinetto d’oro e il nome della regione spagnola famosa per lo sherry da cui proviene e, in memoria di un giorno triste, un cartello di legno con sopra inciso: «Pericolo: letame profondo». Il cimelio, spiegò Dara, era per commemorare un contadino di Killamuck caduto nella sua fossa del letame una sera buia, seguito a ruota dai due figli andati per salvarlo e poi dal cane Che, tutti annegati.
– Che brutta sciagura, che brutta storia, – dice.
Si lambicca il cervello, si gratta la testa con la matita e annota i nomi di vari b&b, dispiaciuto perché molti sono chiusi in quella stagione. Provò al Diarmuid, dopodiché chiamò il Grainne ma non rispose nessuno, mentre in altri tre la segreteria telefonica disse chiaro e tondo di non lasciare messaggi. Poi gli venne in mente Fifi, che dopo l’Australia era un po’ svampita, solo che non era in casa, Dara disse che con ogni probabilità era a qualche seduta di meditazione o di canto, una fanatica della New Age con una passione per il prana, il karma e compagnia bella. Non rimane che il Country House Hotel, anche se sapeva che era chiuso e che marito e moglie stavano per andare in India a fare trekking. Rispose Iseult, la moglie. – Per carità. Non se ne parla –. Ma la insapona un po’ e lei s’ammorbidisce: una notte, non di piú. La conosceva, lui. Andava da loro a fare le consegne, vino e pesce fresco, incluse le aragoste della zona intorno al molo. C’era un viale d’accesso chilometrico, tutto curve e giravolte, ombreggiato da vecchi alberi enormi, un parco di cervi su un lato e il loro bravo fiumiciattolo, fratello del fiume cittadino, un ponte a schiena d’asino e poi ancora il viale, su su fino al prato davanti all’albergo dove i pavoni incedevano impettiti e facevano i loro bisogni. Una volta, scendendo dal furgone, ha visto per caso una meraviglia, il pavone che fa la ruota, come una fisarmonica, il verde e il blu intensi del vetro colorato, uno spettacolo, davvero. Pare che certi ospiti dell’albergo si siano lamentati delle urla che lanciano i pavoni di notte, hanno detto che sono strane come quelle di un neonato che si sente male anche se, aggiunse, a volte la gente si mette in testa idee stravaganti.
Entrò un ragazzotto, guardò a bocca aperta lo straniero con gli occhiali scuri e uscí sbellicandosi dalle risate. Poi arrivò una delle sorelle Muggivan e cercò di attaccare bottone con lui, che però era perso nel suo mondo, pensava alle sue cose e borbottava fra sé, in un’altra lingua. Quando lei se ne andò, lo straniero cominciò a rilassarsi, si fece scivolare il cappotto dalle spalle e disse che era in viaggio da diversi giorni, senza specificare da dove era partito. Dara gli versò un altro brandy, piú abbondante stavolta, e disse che potevano metterlo in conto, perché si augurava di vederlo spesso.
– È un onore averla qui, – e lasciò quell’uomo stanco alle sue meditazioni annotando sul piccolo registro la data e i due brandy. L’ospite disse che dalle sue parti il brandy si faceva con le prugne e le susine selvatiche, si chiamava rakija e aveva come minimo quaranta gradi. Era d’obbligo ai battesimi, ai matrimoni e sulla tomba dei guerrieri.
– D’obbligo –. A Dara piaceva riempirsi la bocca con quell’espressione. E quali sarebbero le sue parti, si azzardò a chiedere.
– Il Montenegro.
Alla parola Montenegro si ricordò che un altro straniero venuto da lí, un mezzo eremita, aveva abitato in una grande casa affacciata sul mare e la mattina prestissimo portava a spasso i cani meticci. Era morto che aveva sí e no sessant’anni, e la cosa gli puzzava un po’. Al funerale giú a Limerick erano soltanto in tre, tutti assiepati sotto lo stesso ombrello. Mai conosciuto di persona, ma a sentire quello che andava dicendo il sergente di polizia era ricercato da qualche parte. Ma non era aneddoto da raccontare a un ospite del genere.
Era uscito da dietro il banco sbalordito, avrebbe dichiarato in seguito, dalla sagacia di quell’uomo, dalla cultura, un’università ambulante, ecco cos’era. Venne a sapere del meraviglioso paesaggio montenegrino, montagne da fare invidia alle Alpi, forre profonde, laghi glaciali che venivano definiti gli occhi delle montagne e valli profuse di erbe aromatiche. Chiesette e monasteri incastonati nella roccia, senza finestre, dove la gente andava a pregare come hanno fama di pregare gli irlandesi. Quello gli disse che i Celti avevano vissuto nelle forre delle Dolomiti e lungo il fiume Drina nei secoli avanti Cristo, e il legame fra l’Irlanda e i Balcani era innegabile. Gli studiosi che avevano esaminato i geroglifici delle pergamene e i reperti nei tanti musei erano risaliti a una somiglianza nelle armi e nelle armature che indossavano.
– Perciò la sua gente ha subito ingiustizie proprio come la mia, – disse.
– Eccome se le abbiamo subite… Mia madre, che è del Kerry, ci raccontava sempre il massacro di Ballyseedy, nove uomini legati insieme con una granata al centro. Un solo sopravvissuto, mio nonno, che le appariva ogni anno il giorno dell’anniversario, il 24 maggio, quant’è vero Iddio… se lo vedeva lí, ai piedi del letto.
Lo straniero rifletté su quelle parole, poi chinò la testa in segno di cordoglio.
– Ha presente Siddhartha? – dice dopo un lungo silenzio.
– Non proprio, – replicò Dara.
Siddhartha, raccontò l’altro, era vissuto migliaia di anni prima e un bel giorno, a una gara di aratura, aveva avuto una visione in cui gli erano state rivelate tutte le sofferenze dell’umanità e gli era stato detto di fare il possibile per alleviarle. Pur non essendo Siddhartha, si affrettò a dire lo straniero, anche lui a un certo punto aveva cambiato il corso della propria vita. Si era ritirato a meditare e a pregare in vari monasteri. La domanda che lo disorientava era come riavere la cosa che aveva perso. La cosa che era preclusa all’uomo moderno: anima, armonia o Dio che fosse. Ritirandosi dal mondo e dedicandosi al tappeto magico della cultura, era entrato, disse, nel roseto del sapere, dell’esoterismo, dell’oniromanzia e della trance. Dopo attenti studi era giunto a una semplice osservazione, e cioè l’analogia degli opposti, e da lí gli era venuta l’idea di combinare la medicina antica con la scienza moderna, una sintesi di vecchio e nuovo che si arricchivano a vicenda.
– La porto a voi, – disse, e gli offrí la mano come garanzia.
– Caspita, – fu l’unica parola che Dara riuscí a trovare.
– È stata una donna a condurmi qui, – disse poi con una punta di malizia, raccontando che una notte in un monastero gli era apparsa, pallida e col viso rigato di lacrime, una donna che diceva: «Sono dell’Irlanda» e lo supplicava di recarsi in quel Paese. Dara, che aveva un’infarinatura di storia, disse che la donna in lacrime era una vecchia conoscenza nei libri di tutti i bambini e si chiamava Aisling, che significa sogno. Poi l’ospite gli diede il suo biglietto da visita, con il nome «Dr Vladimir Dragan» scritto in nero e seguito da una miriade di titoli. Al fondo lesse: «Guaritore e sessuologo».
– Ma tutti mi chiamano Vuk, – disse l’uomo con un sorriso esitante. Vuk era un nome diffuso tra i figli maschi del suo Paese perché era legato alla leggenda di una donna che dopo aver perso una sequela di neonati aveva deciso di chiamare l’ultimo Vuk, che significa lupo, perché le streghe che mangiavano i bambini avrebbero avuto il terrore di affrontare un cucciolo di lupo. Stava andando tutto a meraviglia quando lo squillo di quel maledetto telefono fece saltare i nervi a Dara. Era Iseult, chiamava dalla casa in campagna per sapere quando sarebbe arrivato l’ospite e se le chele di granchio andavano bene per cena.
Dara rimase sulla soglia sotto una scheggia di luna a guardare l’uomo percorrere la strada scivolosa, lo scricchiolio del ghiaccio sotto i piedi, il progressivo attutirsi dei passi mentre attraversava il ponte lasciandosi alle spalle il rombo del fiume per andare incontro a un fiume gemello molto meno impetuoso. Ingollò l’aria a sorsate e si preparò, sapendo che di lí a poco il bar si sarebbe riempito e lui avrebbe dovuto raccontare quell’incontro per filo e per segno.
La prima fu Desiree, una ragazzona in miniabito rosa, con le robuste braccia nude e il cappotto sopra la testa, smaniosa di notizie.
– Dio quanto vorrei un uomo, sono sei mesi che non ho un uomo, – disse, curiosa di sapere se il tipo era presentabile e sposato o single. Aveva la fede? Poi fu la volta delle sorelle Muggivan, che entrarono di soppiatto in cappotto grigio e berretto di lana e ordinarono un cordiale alla menta. Fifi si portò dietro qualche amica e Mona, allertata dalle risate, calò dai suoi appartamenti, prese posto come una cliente qualsiasi su uno degli alti sgabelli e ordinò il solito, vale a dire un porto abbondante con una fetta d’arancia. Vedova da oltre vent’anni, era sempre benvestita con abiti di crêpe scuri e un mazzolino di viole di stoffa sull’ampio petto e parlava con voce sommessa e ansante. Mona aveva due capisaldi nella vita: uno era Padre Pio, per il quale aveva una fede incrollabile, l’altro erano i romanzi rosa dei quali non si saziava mai. Li divorava, come la sera a letto divorava cioccolatini, e guardandosi attorno fu contenta che il bar si riempisse poco alla volta perché era da Natale che le cose andavano di male in peggio. C’erano anche il poliziotto plantigrado, Diarmuid l’ex maestro di scuola e Dante, il punk del paese, in dreadlocks e tenuta nera, seguito dal suo codazzo: Ned, che era stato dentro per aver coltivato la marijuana nei vasi sul davanzale, e Ambrose, che aveva rubato i tubi di piombo all’imprenditore edile per il quale lavorava. Gli affari erano in ripresa. Dara, in preda all’entusiasmo,...