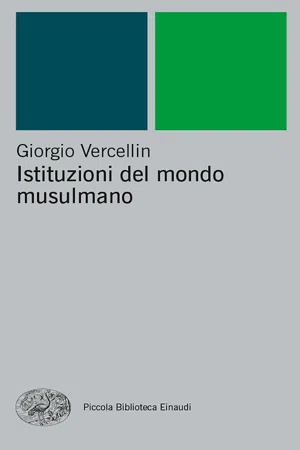1. Islam ufficiale e Islam popolare.
Dicevo nell’Introduzione che mentre numerosi sono gli studi relativi all’Islam in quanto «fenomeno religioso» e alle forme ufficiali delle sue espressioni, rare sono invece le analisi sulle prassi e le usanze che nel mondo musulmano sono state elaborate e praticate concretamente, ossia sulle istituzioni pertinenti all’attuazione effettiva, quotidiana dell’ideologia e in particolare dei precetti religiosi. Come ha ben esplicitato ad esempio Baber Johansen nel suo Des institutions religieuses du Maghreb1, un articolo apparso nel 1988 sulla rivista «Arabica», la caratteristica piú impressionante della secolare produzione scientifica europea sull’Islam è il fatto che non solo è stata quasi del tutto trascurata la storia sociale ed economica, ma è mancata pure l’attenzione alla storia culturale e religiosa. Vero è che si sono date indagini pure su questi aspetti della civiltà musulmana, ma esse erano prioritariamente fondate sulla lettura – magari puntigliosa e accurata – di testi, spesso oltretutto legati a peculiari tipi di esperienze spirituali come il misticismo. In fin dei conti perciò questi lavori si risolvevano in un’ennesima conferma della supposta «essenza islamica» eterna e immutabile.
Tale tipo di approccio, tutt’altro che scomparso anche se ormai non piú predominante, coincideva come accennato con l’assunto per cui il «fenomeno Islam» e le sue pratiche erano di fatto qualcosa di non influenzato da cambiamenti storici. Di piú: oltre all’immobilità, una simile lettura presumeva una sostanziale uniformità, anche diacronica, su tutto il vasto territorio del dār al-Islām. Orbene: questa congettura è certo in parte giustificata e ha una sua validità per un nucleo di istituzioni e di pratiche (per esempio gli arkān al-dīn). Tuttavia focalizzando l’attenzione solo su di esse si lascia in ombra un’enorme serie di varianti locali, di mutazioni storiche e soprattutto di forme e di consuetudini «popolari» della religiosità spesso oltretutto avallate dalle stesse autorità islamiche.
Il nodo di questo malinteso sta nel paradosso per cui – come ha affermato G.-H. Bosquet – l’Islam non conosce «culto» propriamente detto, cosí come non conosce «diritto» né «morale»2. Infatti ciò che noi chiamiamo «culto» è nell’Islam parte dei doveri prescritti da Dio nella sharī‘a e definiti in maniera minuziosa dai dotti (‘ulamā) nelle opere di fiqh. Di conseguenza mentre in altre religioni lo scopo del rituale è di avvicinare il credente alla divinità, nell’Islam si tratta «semplicemente» di adempiere ad una precisa volontà divina, cosa che avviene a livello individuale. Ciò tuttavia vale in pura linea teorica, perché dal punto di vista antropologico, psicologico e sociologico il mondo musulmano conosce a sua volta senza possibilità di dubbio forme di culto intese come mediazione fra l’uomo e il soprannaturale, al punto che si danno vere e proprie istituzioni di quello che potremmo chiamare un «Islam parallelo», pur se vissuto alla luce del sole e accettato da tutti3.
Si pensi per esempio al fatto che la dottrina islamica afferma prepotentemente l’impossibilità di intermediazione fra Dio e il credente. Eppure è indiscutibile che nel mondo musulmano esistono ‘ulamā e mullā e mujtahid e imām e via via tutta una concreta varietà e persino gerarchia di autorità (para)religiose4. E altrettanto innegabile è che vi esistono e vi operano e vi sono venerati personaggi carismatici come shaykh, pīr, marabutti, awliyā, ecc. Ancora: è davanti agli occhi di chiunque si occupi di Islam che i fedeli musulmani compiono veri e propri pellegrinaggi a veri e propri santuari locali con festeggiamenti che ricordano le nostre feste dei santi patroni, o che scansioni cruciali della vita (nascite, matrimoni, morti) vengono segnate con celebrazioni ad alto contenuto religioso, per non parlare dei momenti connessi a riti di passaggio come la circoncisione (khitān).
È infatti indubbio, che dal punto di vista della penetrazione di pratiche rituali o ritualizzate, l’Islam – come già detto – percepisca l’esistenza tanto dell’individuo quanto della comunità come una continua e perpetua ‘ibāda5. Da ciò deriva che ad entrambi gli estremi dello spettro della religiosità musulmana – dall’ortoprassi normativa alla pietas delle masse – rituali e pratiche ritualizzate danno forma e cadenza ai cicli della vita in base a ritmi orari, giornalieri, mensili e annuali.
Non interessa certo esaminare qui nel dettaglio tali rituali, con le loro tecniche e varianti, né tanto meno eventuali analogie fra usi consimili da parte di fedeli delle diverse religioni (e sette religiose) presenti in ambito mediterraneo o altrove6. Mio obiettivo volendo trattare di storia delle istituzioni del dār al-Islām è piuttosto quello di evidenziare come accanto alle forme «ufficiali» delle manifestazioni religiose ne esistessero e ne esistano anche di «popolari». Si badi che con quest’ultima qualificazione faccio riferimento a realtà con numerose sfaccettature; «popolare» infatti non va inteso come contrapposto a «illustre» o «nobile», ma come distinto da «colto», da «ufficiale» e soprattutto da «sancito dalla norma». Ma ciò non basta: «popolare» nel presente contesto rimanda ad altre dialettiche, ad altre distinzioni peraltro quasi sempre interconnesse e interagenti. Parlo di quelle tra religiosità dei sedentari versus quella del mondo nomadico, oltre che tra religiosità pubblica versus quella privata e infine tra religiosità maschile versus quella femminile.
Per quanto riguarda la prima dicotomia, le religiosità dei centri urbani e delle campagne ancorché differenti trovavano un punto di incontro nell’osservanza degli arkān al-dīn e nel rispetto per comuni luoghi di culto. Inoltre molti ‘ulamā urbani appartenevano a confraternite ṣūfī con ramificazioni diffuse nelle campagne circostanti, senza contare che gli abitanti dei villaggi, pur privilegiando il diritto consuetudinario, non di meno in linea di principio rispettavano la sharī‘a e se ne servivano per esprimere accordi o sancire avvenimenti importanti e impegni comuni.
Ben piú profonda la divaricazione fra l’Islam dei sedentari e quello dei nomadi, la cui religiosità – criticata come si è visto dallo stesso Corano – appare quasi piú un complemento ai vincoli comunitari che non una tensione metafisica.
Le differenziazioni pubblico/privato e maschile/femminile meritano una sottolineatura particolare. Nelle questioni di culto infatti l’Islam per cosí dire «istituzionale» assegna alle donne un ruolo subordinato, considerando al limite le manifestazione religiose femminili come faccende autonome, riservate. Si pensi per esempio alla preghiera comunitaria: una donna non può esserne imām7 (a meno che non si tratti di un gruppo di sole donne), anzi assai spesso le donne vengono relegate in appositi spazi.
Per proporre subito un rovescio della medaglia bisogna riconoscere in primo luogo che nulla nella sharī‘a impedisce alla donna di compiere gli arkān al-dīn. Lasciando da parte, per i motivi segnalati, la shahāda e trascurando quanto già accennato a proposito dell’impurità mestruale8, le donne possono e devono (salvo gli usuali impedimenti peraltro non legati al sesso) pregare, digiunare, pagare l’elemosina e compiere il pellegrinaggio. Senza contare che dalle fonti sappiamo con certezza che esistevano donne shaykha, faqīha, wā‘iẓa, ṣūfīya, ecc.
Il fatto è che se si ricorda la già discussa segregazione della donna in uno spazio interno, riservato, ḥarīm, si capisce come mai i maschi tendano ad identificarsi con l’esercizio religioso pubblico, lasciando eventualmente alle femmine attività marginali, spesso compiute da donne e a beneficio di altre donne. È il caso ad esempio dei mawlūd, le feste che si tengono in occasione dell’anniversario della nascita di Muḥammad o di qualche altro «sant’uomo». Non a caso tali mawlūd sono a parole piuttosto disprezzati dagli uomini, che peraltro non solo di fatto li tollerano ma addirittura spingono le donne della famiglia a parteciparvi (e alla fine vi prendon parte essi stessi). Cosí celebrazioni (para)religiose similari hanno luogo anche in occasione di matrimoni o di commemorazioni funebri e proprio la partecipazione ad. esse fornisce alle donne un’opportunità di espressione personale e di leadership (semi)pubblica al di fuori della sfera domestica.
Conclusione di questa lunga premessa è che come sempre la comprensione della storia delle istituzioni del mondo musulmano deve di necessità superare l’approccio orientalistico, ossia testuale, filologico, «colto», «normativo», «pubblico», per integrarlo con il complementare esame delle credenze e delle pratiche tanto degli uomini quanto delle donne, tanto dei sedentari quanto dei nomadi, e cosí via.
La citata pratica della circoncisione o khitān9 è significativa di quanto sto affermando. Se infatti essa non è mai menzionata nel Corano10, nei ḥadīth al contrario è spesso trattata: se vi si riconosce sempre che faceva parte delle istituzioni pre-islamiche, da essi emergono posizioni assai difformi per quanto ne concerne l’applicazione. Cosí in una tradizione conservata da Ibn Ḥanbal viene qualificata come mandūb (‘raccomandata’) per i maschi e ‘tradizionale’ (sunna) per le femmine, mentre secondo al-Shāfi‘ī e altri giuristi è invece addirittura ‘obbligatoria’ (wājib).
Il problema vero però è che pur non essendo di derivazione coranica e pur essendo oggetto di discussione tra i dotti, la circoncisione è usanza diffusa e praticata in tutto il dār al-Islām, dal Marocco all’Indonesia, dall’Africa subsahariana all’Asia centrale, accompagnata da grandi feste e celebrazioni pubbliche. A tal punto che l’orientalista olandese Snouck Hurgronje notava: «Per la massa incolta11 dei musulmani come anche per l’enorme massa dei non musulmani l’astensione dalla carne di maiale e la circoncisione sono diventate in una certa misura le caratteristiche dell’Islam»12.
Senonché su tale multiforme realtà si innestano ora le conseguenze dell’occidentalizzazione e dell’emigrazione di masse non trascurabili di musulmani in terre al di fuori del dār al-Islām. Quest’ultimo fenomeno in particolare sta provocando mutamenti piú profondi di qualunque altra innovazione introdotta da leaders tradizionali nelle variegate forme di «Islam ufficiale». Emergono cioè forme di laicizzazione di stampo occidentale, cosicché molti musulmani cercano di razionalizzare atti religiosi tradizionali in termini secolari o addirittura igienici, affermando per esempio che digiunano per ragioni di salute o semplicemente per tener compagnia all’(unica) moglie che a sua volta sta digiunando13.
2. Varianti negli «arkān al-dīn».
Come accennato, sarebbe tuttavia errato contrapporre in maniera netta le diverse realtà citate. In effet...