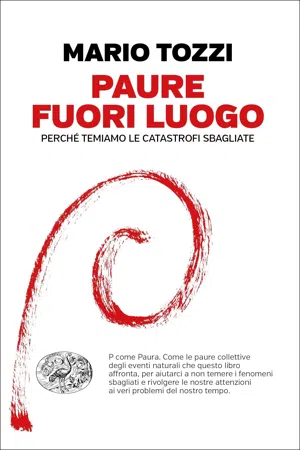Le catastrofi naturali e i disastri costituiscono effettivamente una delle paure piú gravi del nostro tempo. Una paura che ci verrebbe da definire atavica e trasversale ai popoli e agli Stati, ma che scopriamo, in linea di principio, diffusa soprattutto in certi livelli sociali e in certi Paesi. Non voglio dire con questo che un terremoto non sia in grado di terrorizzare chiunque, nel momento in cui accade, ma che non per tutti il tempo fra una catastrofe e l’altra trascorre nella paura. Una paura legata a tre elementi: gli atteggiamenti, la conoscenza e la memoria.
Da un punto di vista psicologico esiste ormai una vera e propria scienza attinente alla sopravvivenza psichica in condizioni di emergenza. Sotto quest’angolo visuale spesso le catastrofi subíte compromettono addirittura la capacità di pensare. E la paura del disastro imminente anestetizza le capacità di reazione dei viventi, come dimostrano molteplici casi di comportamenti inadeguati, per esempio chi durante piogge incessanti esce di casa e chi in auto imbocca un sottopassaggio nei pressi di un corso d’acqua. O chi si precipita per le scale durante un terremoto. Si potrebbe arrivare a dire che, soprattutto in Italia, la negazione e la rimozione del ricordo degli eventi catastrofici, pure necessarie per ripartire, siano forse elementi di ritardo della risposta istituzionale, soprattutto di quelle istituzioni che, nel corso del tempo, minimizzano il rischio. La paura dunque viene fugata, fra un evento e l’altro, perché, a differenza per esempio della paura del terrorismo, non viene alimentata e non resta attiva a monito di futuri comportamenti inadeguati.
Il meccanismo di difesa, una volta subita una catastrofe, è tipicamente quello che si mette in atto durante un qualsiasi trauma psichico personale per poterlo superare e mantenere tollerabile il livello di dolore. Si nega inizialmente la perdita, poi ci si rifugia nella fantasia e perfino nella negazione della realtà stessa. Come notano Rita Di Iorio e Daniele Biondo, psicologi delle emergenze, si deve quasi recuperare, per sopravvivere, una certa illusione di onnipotenza, quella che ci era cara da bambini, facendo ricorso alle risorse psichiche piú profonde.
Ma perché oggi sembra piú difficile convivere con il rischio naturale rispetto al passato? Qui entra in campo un altro elemento, quello della memoria che indirizza le decisioni e i comportamenti. Nella società contemporanea la negazione del trauma per eccellenza, la morte, ha portato alla scomparsa anche delle parole e dei riti necessari per elaborarla. E la memoria di quei processi non si tramanda piú, lasciando spazio all’inconsapevolezza: come un’espulsione di tutti questi elementi dalla riflessione culturale. Da questo punto di vista, si riscontra una certa somiglianza tra l’evento catastrofico e il cancro, nel senso che entrambi incutono timor panico e che per nessuno dei due si è trovata ancora una risposta univoca da parte della scienza, e si continua a morire di terremoti e di tumore. Quel panico e quelle incertezze inducono comportamenti spesso paradossali, come quello di non voler sapere: paura di una Tac come di una sezione sismica che disveli cosa c’è sotto i nostri piedi. Quando è noto che in entrambi i casi solo la prevenzione potrebbe salvarci la vita.
Con la rimozione di ogni elemento naturale dalla vita quotidiana metropolitana è diventato piú difficile affrontare gli eventi naturali, specialmente in una società contemporanea sempre piú scientista, con la scienza in grado di risolvere ogni problema. Ma, a pensarci bene, è l’impatto della catastrofe stessa a smentire la concezione lineare e positivista del processo storico. Le catastrofi sono elementi di discontinuità spaziotemporale ciclici, come il momento della svolta drammaturgica nella tragedia greca o del deus ex machina. Per questo ci risulta difficile portarle dentro il nostro patrimonio culturale: come già detto, essere uccisi da una faglia non piú attiva dall’era glaciale deve sembrare incredibile quasi quanto essere ammazzati da un mammut.
Un’antica novella talmudica, ripresa molte volte in racconti, ci spiega come al destino non si possa sfuggire: un servo andò al mercato per far provviste, ne ritornò pallido e tremante; al suo padrone disse che aveva incontrato la Morte e che lei l’aveva urtato minacciandolo. Per sfuggirle gli chiese di prestargli il suo cavallo, con cui sarebbe andato a Samarcanda (Samarra in altre versioni), dove la Morte non l’avrebbe potuto trovare. Il padrone acconsentí, e il servo partí al galoppo. Quando l’uomo fu lontano, il padrone si recò nella piazza del mercato e tra la folla scorse la Morte. Le chiese perché aveva spaventato il suo servo e lei rispose che non era stata sua intenzione, aveva solo fatto un gesto di sorpresa, stupita di vederlo in quella città, dato che aveva un appuntamento con lui per quella notte a Samarcanda (di questa fiaba rende, meravigliosamente, conto anche Roberto Vecchioni nel brano omonimo del 1977, solo apparentemente una filastrocca per bambini).
Le catastrofi, invece, a differenza della Morte di questa storia, possono essere evitate o, almeno, mitigate. Chi teme un disastro raramente lo subisce (scrive Publilio Siro già nel I secolo a.C.) e non si vuole qui certo negare il ruolo positivo della paura come protezione dei viventi, a patto che non divenga, come spesso accade, spavento, angoscia o panico, indipendenti dalla gravità della situazione e causa di incapacità di elaborare strategie di sopravvivenza. Volendo schematizzare, la strategia corretta di preparazione al rischio naturale deve iniziare da una conoscenza di base dei processi che presiedono alle catastrofi e dalla loro incorporazione nella memoria personale. I meccanismi corretti di difesa, spesso controintuitivi, come per esempio quello di non scappare per strada al momento di un terremoto, debbono diventare automatici, ricorrendo anche a esercitazioni simili a quelle che avvengono sulle navi per prepararsi a un naufragio. Questa automatizzazione è indispensabile per muoversi correttamente in fase di stress, quando l’ultima cosa che riesce bene è proprio agire razionalmente.
Apocalisse pagana.
Se nella breve storia dei sapiens c’è stata gente che ha fatto della paura un cardine della propria esistenza collettiva, quello è stato il popolo maya. Se vi siete mai domandati perché i Maya fossero cosí ossessionati da stelle e pianeti da riuscire a identificare perfettamente l’anno solare e inscriverlo per sempre nella pietra delle loro piramidi, e perché sacrificassero i loro migliori giovani agli dèi del cielo, la risposta è che avevano paura. Paura della fine del mondo.
Non molti lo ricordano ma, qualche anno fa, anche noi ci siamo andati molto vicini. Proprio a partire dai Maya e dalla presunta profezia sulla fine del mondo, che sarebbe arrivata il 21 dicembre 2012. Accade spesso: una cultura lontana nello spazio, e nel tempo (i Maya non erano certo antichi come gli Egiziani, visto che raggiunsero il loro culmine ben dopo Greci e Romani), che arriva all’apice e poi scompare improvvisamente, desta curiosità e si ammanta di un alone ingiustificato di mistero.
A differenza di altri popoli precolombiani americani, i Maya erano perlopiú agricoltori che dovevano sopravvivere in un ambiente particolarmente ostile a causa del clima e della scarsezza delle risorse: acqua, cibo, foresta. Quando divennero troppo numerosi l’ecosistema non fu piú in grado di sostentarli. Tutto qui. Peraltro i Maya non scomparvero affatto: dopo essere arrivati fino a quattordici milioni di individui, all’approdo degli spagnoli furono massacrati e ridotti forse a trentamila, che giunsero alla soglia dell’estinzione nel XVIII secolo, quando rimasero solo in tremila (oggi i discendenti sono circa cinquecentomila). Anche per i Maya, come oggi per noi, il clima è stato un fattore determinante: tre periodi di gravissima siccità fra il IX e il X secolo portarono all’abbandono di molti centri importanti. Il tutto condizionato dall’eccessivo sfruttamento dell’ecosistema della foresta pluviale, che non può mantenere numeri elevati di uomini. Ad esempio, i Maya producevano la calce per costruire i loro enormi templi con il fuoco, che, a quei tempi, poteva essere alimentato solo dal legno della foresta. La stessa che avrebbe dovuto proteggerli e sostentarli.
I conquistatori spagnoli non ebbero ragione dei Maya per abilità strategica o per tattica, né solo perché sapevano montare cavalli, ma soprattutto per le armi da fuoco e le malattie sconosciute portate nel Nuovo Mondo. Ma la crisi delle materie prime e la sovrappopolazione furono il contesto senza il quale quegli accadimenti, da soli, non avrebbero forse provocato la fine. In fondo, quella dei Maya è una tipica storia di sapiens che non si avvedono di quanto in fretta si deteriorino le risorse. Neanche loro si rendevano conto che vivere nella foresta in condizioni critiche è difficile, tant’è che affidavano il futuro a una misura ossessiva del cielo e del tempo. Nessun altro popolo mai si è interessato a tal punto del tempo da trasformare i giorni stessi in divinità. Il Tempo era un dio, e si ripeteva ciclicamente per l’eternità, ma c’erano date propizie o nefaste che venivano interpretate come la chiave per il ripetersi di alcune situazioni ricorrenti.
In questo senso la siccità non dipendeva da cause meteoclimatiche, ma dall’andamento di stelle e pianeti. Se un particolare periodo secco avveniva in corrispondenza, per esempio, della levata di Venere (c’è sempre qualche alba o tramonto in cielo), ecco che, a ogni levata, si doveva sacrificare per evitare le conseguenze della siccità. Un tipico tentativo pratico di placare forze esterne e soprannaturali. I Maya erano ignoranti e si affidavano al rito e alla religione, non avendo risposte dalla scienza. Esattamente come accade a molti sapiens contemporanei, nonostante qualche risposta la scienza abbia cominciato a darla. A parte i sacrifici umani, molti sapiens di oggi non sono cosí differenti da quell’antico popolo.
Cosí i Maya, unici fra i popoli antichi, ricostruivano i cicli all’indietro nel tempo fino a quattrocento milioni di anni prima. Il katun (7200 giorni) era l’unità temporale fondamentale: tredici katun sono circa 257 anni dei nostri e sono il ciclo base in cui la storia torna a ripetersi. Il megaciclo temporale Maya relativizzato al XXI secolo era iniziato l’11 dicembre del 3114 a.C. e sarebbe terminato il 21 dicembre 2012, dopo oltre 5125 anni astronomici (in simbologia maya 13.0.0.0.04).
E qui arriva la catastrofe.
Nella visione maya l’era del mondo in cui vivevano fu preceduta da altre tre epoche, tutte terminate con cataclismi devastanti: diluvi o uragani (vocabolo peraltro di origine locale). Era naturale attendersi un’altra catastrofe per la fine, ma non esistono profezie maya: tutto quello che ci hanno lasciato riguarda sempre e soltanto il passato, le congetture le abbiamo fatte noi. E, in ogni caso, ciclicamente, dopo la fine c’era comunque un nuovo inizio.
In ultima analisi si tratta di una storia semplice, che, esaminata scientificamente, non porta ad alcuna preconizzazione di una fine catastrofica. Ma gli uomini del XXI secolo amano pensare alla fine facendo finta di temerla. Ed è sempre meglio affidarsi ai Maya che affrontare i problemi ambientali. Cosí, appena prima del 21 dicembre 2012, ovunque i sapiens si sono interrogati sull’imminente fine del mondo. E molti ne avevano paura. Nessuna voce, invece, che si levasse contro le conseguenze dell’inquinamento atmosferico che, come si andava scoprendo a partire da quel periodo, portava a morte prematura milioni di sapiens in piú ogni anno.
La rassicurazione del mito.
Prima che arrivassero gli scienziati, i sapiens tentavano di esorcizzare la paura dei fenomeni naturali attraverso il racconto, in cui l’intervento del divino era fondamentale. Veramente ci provano ogni tanto anche adesso, ma perlomeno ora sono a disposizione spiegazioni scientifiche piú convincenti che in passato, quando i terremoti venivano interpretati da Aristotele come l’effetto di correnti atmosferiche. Per la verità, anche oggi molti parlano di «tempo da terremoti», ma, insomma, pare che non tutti ci credano. Per fortuna.
Le catastrofi erano spesso interpretate come un castigo degli dèi, almeno fino a che Plinio il Giovane non scrisse la prima cronaca (seppure per interposta persona) dell’eruzione del Vesuvio nel 79, una cronaca che non lasciava spazio alle divinità, ma solo alla Terra. O ai bassorilievi rinvenuti a Pompei in cui si raffigura la distruzione causata dal terremoto del 62. Il Tempio di Giove è basculato, come per l’effetto di un fenomeno di liquefazione delle sabbie, che lascia gli edifici intatti, seppure ribaltati (fenomeno tipicamente riscontrato in molti terremoti e dovuto alla risalita repentina delle acque sotterranee per lo shock tettonico che fa perdere stabilità alle fondamenta). Un’iconografia della catastrofe senza riferimento alcuno agli dèi, senza simbolismi, come una vera e propria fotografia. Molto lontana da quanto registrato, quasi sempre, in epoca medievale, quando il terremoto sarà invariabilmente associato alle eclissi, ai crolli di statue di santi e imperatori e perfino alle piogge di sangue. Non che da quel momento le cose siano cambiate, specialmente nel caso del terremoto, la cui dimensione socioculturale ha comunque attirato l’attenzione di molti umanisti. Fuori dal campo strettamente scientifico, il terremoto non è solo un flagello, come lo sono alluvioni o vulcani, ma è l’evento per definizione, la catastrofe palingenetica, l’indizio del nume.
È capovolgimento (anche etimologicamente) della civiltà e del sistema di potere: come nel passaggio di consegne tra Festo e Cnosso, in corrispondenza del terremoto, nella Creta minoica. È l’Apocalisse (non a caso scritta da Giovanni nell’Egeo, dove i sismi sono ricorrenti) che colpiva anche i ceti ricchi, anzi li colpiva piú duramente, visto che avevano molto da perdere e che abitavano in palazzi in muratura, destinati a subire danni e crolli piú gravi rispetto alle casupole di fango. Il terremoto accelerava i processi di rinnovamento urbanistico e di riorganizzazione territoriale. Resta semmai da domandarsi perché, in tempi moderni, il terremoto sia piuttosto diventato strumento di consolidamento del potere e non provochi eccessivi ribaltamenti (non piú catastrophé). Come negli anni Novanta in Iran, dove è stato usato per dare una giustificazione divina al potere dispotico degli ayatollah.
Ma per molto tempo chi sosteneva l’origine naturale del terremoto veniva ritenuto un eretico (come affermato, per esempio, da Filastrio nel IV secolo) che negava l’esistenza stessa del nume. Successivamente si arrivò al compromesso della doppia origine dei sismi, divina e naturale, la prima per chi si era ben comportato (allora dipendeva dal caso), la seconda per chi aveva peccato (e allora era punizione).
Fra i miti che hanno le catastrofi come minimo comune denominatore due sono persistenti e universali, il diluvio e la civiltà scomparsa di Atlantide. Hanno entrambi senso in questo libro e li esamineremo. Ma, infine, cosa ci resta di questi racconti? Forse l’insegnamento piú profondo è che le società degli uomini esistono solo grazie a un temporaneo consenso geologico, soggetto a essere ritirato senza preavviso. Un concetto difficile da digerire. E che per questo abbiamo rimosso troppo in fretta.
I miti del passato mettevano in guardia proprio su questo.
Diluvi «universali».
Di un diluvio, causa della sommersione temporanea della Terra sotto l’acqua, narrano quasi tutte le antiche tradizioni che si trovano tanto nel mondo classico, quanto presso i popoli orientali e cosiddetti primitivi. In particolare, le leggende del diluvio si tramandano nelle regioni fluviali e costiere come in Mesopotamia e lungo il Nilo, sul litorale della Grecia e dell’Europa settentrionale, nel Pacifico meridionale (Oceania), in molte aree dell’America meridionale e settentrionale. Dall’epopea di Gilgamesh alla Bibbia, alla narrazione egizia intorno alla «distruzione degli uomini», al Śatapatha Brāhmaṇa indiano, ai canti scandinavi dell’Edda, i temi della catastrofe naturale ritornano con una coincidenza sorprendente in quasi tutte le culture umane.
Siamo spesso costretti a dare ragione alla Bibbia, come qualche volta abbiamo dovuto fare con l’Iliade (qui li vogliamo considerare come due racconti mitologici collettivi, tenendo presente che la prima è un po’ meno religiosa...) E a rivedere molti di quei racconti sotto un altro profilo. Il crollo delle mura di Gerico sembra possa essere un tentativo di spiegare la distruzione di un terremoto, identificandolo nel suono delle trombe del Giudizio (visto che si tratta di onde acustiche in entrambi i casi). Del resto la grande faglia del Mar Morto, lungo la valle del Giordano, segna la vita della Palestina da piú di diecimila anni, come testimoniano i pavimenti delle capanne di antichissime comunità umane inclinati di oltre settanta gradi, o le colonne romane di Beit She’an abbattute proprio a causa dell’attività della faglia e dei terremoti. Cosí come l’apertura delle acque del Mar Rosso sembra possa corrispondere a uno o piú tsunami. Come è andata davvero per il diluvio universale?
Circa 7600 anni fa l’acqua sommerse la Terra, uccise gli animali, distrusse i raccolti, costrinse a lunghe migrazioni gli uomini, cambiò le pianure in laghi e sconvolse gli equilibri del pianeta. È comprensibile che si pensasse a una punizione divina. Si trattava, invece, di un diluvio vero, reale, qualcosa di concreto come l’acqua e il fango, non una metafora di catastrofi mandate a punire gli uomini superbi. E non c’era un’arca salvifica di anime perdute e di animali a coppie, ma canoe, tronchi scavati, piccole imbarcazioni rimediate all’ultimo minuto, a causa del fatto che le acque di un mare intero si rovesciano in quelle di un immenso lago, invertendo i rapporti e stravolgendo le prospettive. Le acque scacciano gli uomini verso un esodo che crea i miti e informa le religioni: cosí nascono quei racconti che si basano su eventi naturali cui oggi diamo una spiegazione scientifica. Cosí nasce la tradi...