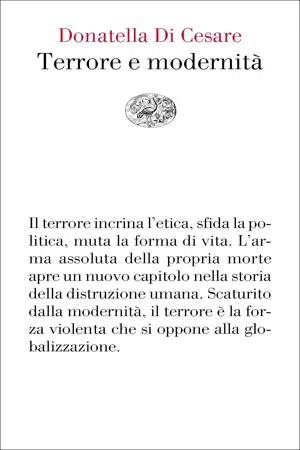1. Radicalizzazione.
Nel frastagliato paesaggio globale la negatività assume non di rado la forma della radicalizzazione. Proprio quando il mondo va raggiungendo lo zenit della sua apertura, sorge paradossalmente il pericolo più inatteso e imperscrutabile. Nella parola «radicalizzazione», che ha invaso lo spazio pubblico, è condensata la carica esplosiva, è racchiusa la genesi del terrore a venire. Apparati di sicurezza e servizi di intelligence, seguendo i criteri di una inedita semiologia della radicalizzazione, un presunto sapere indiziario della distruttività, tentano di insinuarsi telematicamente in questa anticamera del terrore, per intercettarne i segni premonitori, per sorvegliare la nascita di un nuovo tipo umano, il «radicalizzato», che viene anche definito born again.
Se molti concetti prima sparsi e slegati, come estremismo, fondamentalismo, integralismo, fanatismo, sembrano aver trovato posto nel campo esteso della radicalità, più difficile è precisare il nesso fra terrorismo e radicalizzazione. Dato che è indubbia la convergenza, i due termini potrebbero apparire sinonimi. Ma la differenza, come ha spiegato Farhad Khosrokhavar, sta nella prospettiva, per certi versi opposta e speculare1. L’indagine sul terrorismo indirizza lo sguardo sull’azione violenta: da un canto sui mezzi tecnici che la consentono e, variando nella storia, la modificano, sino al dispositivo della tecnica che manovra il terrore, dall’altro sugli effetti devastanti, sulle stragi e i massacri prodotti. La radicalizzazione focalizza invece lo sguardo sull’autore, sulla sua storia, sui motivi dell’azione, sulle scelte che, in quel complesso gioco di specchi, in cui si dispiega il rapporto con il mondo, ne hanno delineato la traiettoria individuale, sul fine ultimo che lo ha spinto verso la violenza – prima del passaggio all’azione.
Si tratta, dunque, di una ricerca complementare, di uno studio psicopolitico che ha almeno due pregi. Il primo è porsi la domanda decisiva, altrimenti elusa, quella cioè sul «perché» dell’azione. Perché quell’attentato? Perché quella scarica di colpi contro persone inermi? Che cosa ha mosso il terrorista ad agire, fino al punto di annientare, oltre quella altrui, anche la propria vita? Si potrebbe sbrigativamente parlare di «delirio fanatico», «follia omicida», «terrore cieco», come avviene per lo più nel flusso frenetico delle news. L’alternativa a questa comoda risposta, che riduce ogni volta il fenomeno a una patologia, è la via dischiusa dai grandi diagnostici della modernità che, a partire da Dostoevskij e Nietzsche, non si sono arresi al giudizio morale sul crimine, ma hanno invece tentato di comprendere, senza per questo giustificare, moventi e impulsi, per quanto reconditi, e spesso inconfessabili. Il che vuol dire non solo immergersi nelle tenebre della psiche, ma anche riconoscere che il terrorista resta nella sfera umana, legato agli altri umani da un filo, scabroso e imbarazzante, che nessuno può recidere e che diventa, anzi, la chance per sondare l’abisso dell’umanità all’epoca del terrore globale.
Il secondo pregio, che la prospettiva della radicalizzazione offre, è quello di interrogarsi sui fini politici che l’attenzione ai mezzi tende invece a lasciare in ombra, o a occultare, avallando l’idea diffusa del nulla a cui mirerebbero i terroristi odierni, gli attuali nichilisti. Questo vale tanto più quando i fini sfuggono ai canoni della politica tradizionale, quando valicano le frontiere, eccedono il nómos della terra, si rivelano ultra-politici o addirittura extra-mondani.
Il termine «radicalizzazione», con tutti i suoi annessi e derivati, tra cui il più recente «radicalizzarsi», rinvia al latino tardo radicale(m) e, più oltre, a radix, radice. In tal senso radicalizzazione designa sia il processo attraverso cui un individuo si è spinto verso la radicalità, sia l’esito, cioè il suo essere radicalizzato.
La radicalizzazione si dice in molti modi – al presente e al passato. Perciò Khosrokhavar impiega il concetto per uno studio retrospettivo, in particolare sulle organizzazioni europee di estrema sinistra, dalla RAF in Germania alle BR in Italia, ad «Azione diretta» in Francia. E di nuovo occorre ribadire che i paragoni, se per un verso fanno emergere aspetti illuminanti, per l’altro spingono non di rado a semplificare.
La novità, altrimenti ignorata, dell’era globale, è che la radicalizzazione viene intesa in gran parte anche come un radicamento. Il desiderio di radicalità si esaudisce grazie a un ritorno alle radici. L’estremo, che prima era la meta, non basta più. Deve essere un estremo che scaturisca dal fondo, inconcusso e puro, di una radice. Così viene riattivata la metafora potentemente icastica della radice, che già nel mondo antico, attraverso la simbologia dell’albero, indica l’origine. Non si può, d’altronde, fare a meno di ricordare che il tema delle radici perdute, dello sradicamento, drammatico e forse irreparabile, a cui è consegnata l’esistenza umana nell’universo planetario, agita quasi tutta la filosofia dell’ultimo secolo. A cominciare dalle riflessioni parallele di Franz Rosenzweig e di Martin Heidegger. Che ne sarà di chi è stato strappato per sempre alla terra, cui tutte le fibre sembravano legarlo? Nell’erranza ebraica si intravvede l’esilio di tutti, nella spaesatezza un «destino mondiale»2. Viene riconosciuto qui il marchio lasciato dall’età della tecnica, il segno della globalizzazione incipiente.
La ricerca della radice perduta è una reazione alla spaesatezza avvertita come una sorte ingiusta e inaccettabile. Il che risponde inoltre all’insofferenza del radicalizzato verso l’insostenibile peso del nulla. Il radicalizzato non è un nichilista. Questo «no», che convoglia il vento impetuoso della negatività, è una risposta reazionaria alla globalizzazione, i cui due esiti opposti sono il tentativo di abbarbicarsi prepotentemente alla terra, oppure, là dove la condizione diasporica prevalesse, quello di cercare un radicamento in cielo. Nel primo si scorge la posizione della destra estrema, attestata ormai, nelle sue numerose ramificazioni, quasi più nella difesa del suolo che del sangue, e alla quale vanno ricondotte stragi come quella compiuta da Anders Breivik a Utoya, in Norvegia, il 22 luglio 2011. Al secondo esito giunge il radicalismo islamico che nello scenario odierno svolge il ruolo del protagonista. Al punto che, nel vocabolario dei media, radicalizzazione equivale a islamismo.
Ciò dipende non solo dall’impatto che sulla opinione pubblica occidentale hanno prodotto gli attentati di matrice islamista, ma anche da quella stranezza di un terrore che si richiama al cielo, che tira in ballo Dio nelle faccende intramondane della politica, che sfida il progresso con i suoi tratti neoarcaici, che sceglie forme di lotta estreme, come il martirio, ripugnanti per la ragione. La stranezza diventa allora estraneità piena e conclamata, benché il terrorismo possa essere homegrown, possa, cioè, essere sorto all’interno. Dall’altra parte, però, si deve riconoscere la islamizzazione della rivolta radicale. Non c’è dubbio che il radicalismo islamico abbia occupato, almeno in parte, il posto che in passato avrebbero preso altre ideologie di salvezza o altri progetti di futuro. Segno dei tempi – o forse qualcosa di più. Perché la radicalizzazione islamica offre sia una forma di vita alternativa, che altrove è mancata, sia l’appartenenza a una comunità che, per quanto immaginaria o virtuale, chiede l’apporto del born again, del rigenerato, per realizzare una utopia transnazionale.
2. Teologia politica del neocaliffato planetario.
Il terrore scatenato dal jihadismo globale è stato finora inteso in prevalenza come un «terrore cieco», non solo per la sua furia distruttrice, ma anche per l’apparente assenza di un fine politico. Tanto più che ogni scambio è impossibile, che l’arma assoluta del martirio annulla ogni negoziato. Di qui l’immagine terrificante del jihadista vestito di nero che, come un’onda anomala proveniente da un passato recondito, irrompe nei nonluoghi dell’Occidente, aeroporti, metro, centri commerciali, per rivendicare la sua utopia fatta di nulla.
Il combattente che agiva, magari con modalità analoghe, per un progetto politico concreto, anzitutto per l’indipendenza nazionale, ha lasciato il posto al terrorista che non sembra avere scopi pragmatici. Questo mutamento, che talvolta, ad esempio in Afghanistan, si è compiuto d’un tratto, sicché il combattente per la libertà è divenuto l’adepto del jihad, ha rappresentato una cesura inaudita nell’ottica occidentale. Se prima la condanna morale dell’atto violento poteva essere accompagnata da una comprensione per la causa politica, in seguito il terrorismo appare insensato e folle. La differenza non sta, però, solo nel passaggio da un progetto nazionale, forse realizzabile, a uno transnazionale, impossibile da realizzare. Né la questione si limita alla terra, perché non cambia quando, dopo il terrore seminomade scatenato da al-Qaida sulla superficie del pianeta, il jihadismo si riterritorializza in parte proclamando lo «Stato islamico».
Il neocaliffato, questa sorta di città ideale, a cui l’Isis ha dato vita, sarebbe per molti un «fantasma», la chimera di un’entità ideologica, fondata su un patto di morte, i cui confini vengono quotidianamente ritracciati sulla carta del globo, a seconda delle battaglie, e le cui ambizioni sono nondimeno planetarie. Quale sarebbe infatti la sua strategia, quale la prospettiva politica? Il neocaliffato avrebbe l’unico vantaggio di inscriversi nell’immaginario religioso islamico, di articolare la disperazione in una «teologia della folle speranza». A parte la volontà di umiliare la boria occidentale, il suo piano si riassumerebbe nel lanciare un’azione jihadista che, con l’intervento divino, dovrebbe instaurare una teocrazia universale guidata dall’islam. Ma per l’Occidente questa non è solo una causa persa, che si proietta in un futuro imprevedibile – rappresenta per di più una inaccettabile commistione tra teologia e politica.
Quando si parla di teologia politica, anche negli studi specialistici, molte ovvietà restano sullo sfondo. Che si pensi a una tensione sincronica fra teologia e politica o si consideri invece, come avviene per lo più, la genealogia della politica dalla teologia, nel senso della secolarizzazione, in ogni caso si resta rigidamente all’interno del cristianesimo, visto con lo sguardo della modernità. Ebraismo e islam vengono ignorati. Si conferma così, e si approva tacitamente, l’idea che nella tradizione occidentale la religione per eccellenza sia il cristianesimo. Peraltro un cristianesimo astratto dalla sua storia e fortemente grecizzato. Il modo di intendere il rapporto fra teologia e politica è allora cristiano-moderno. Fa testo la separazione introdotta da Agostino fra la «città terrena» e la «città di Dio». Non solo appare indubbia questa separazione, ma qualsiasi presenza della religione nella sfera pubblica viene giudicata come un’intrusione illegittima. La politica deve emanciparsi dalla teologia: questo è il motto del pensiero laico che, nella sua versione più esasperata, diventa laicismo3. Tutto ciò è possibile perché il cristianesimo, rinunciando, seppure non definitivamente, a molte prerogative, ha accettato molto presto, a partire già da Costantino, una sottomissione al potere politico riconoscendone la sovranità. Il cives si piega e il fedele attende giustizia nell’al di là.
Diversamente stanno le cose per l’ebraismo e per l’islam che non sono solo religioni. La separazione tra teologia e politica non può non risultare fittizia, così come forzata e miope appare la proiezione di categorie della modernità cristiana. Si cela qui un motivo profondo di conflitto nel contesto attuale. Perché questa proiezione impedisce non solo di vedere le peculiarità di altre tradizioni religiose, ma anche di scorgerne le diverse fasi e capire i temi che sono all’ordine del giorno.
Qual è stato e qual è oggi il rapporto fra teologia e politica nell’islam? Come va interpretato il gesto con cui è stato inaugurato il neocaliffato? Si parla spesso di «islam politico», intendendo quell’ingresso della religione islamica sulla scena politica, foriero di tutti i mali. A ben guardare, però, nel mondo musulmano la politica non è mai stata separata dalla religione. Se si esclude il periodo della predicazione di Maometto, e forse di qualche immediato successore, questa è stata la regola per secoli, fino all’Impero ottomano. Fondamento imprescindibile e vincolante delle leggi, della sharia, la religione si è rimessa per la sua realizzazione al potere temporale e a chi, di volta in volta, lo deteneva, cioè al califfo, al malik, al sultano, all’emiro. Quest’ultimo, benché come califfo si presentasse nelle vesti di «comandante dei credenti», non ha mai esercitato una carica religiosa, affidata invece agli ulema sunniti o ai mullah sciiti. Si è trattato di un difficile equilibrio all’interno, però, di un rapporto teologico-politico ben delineato. Non si può dunque parlare, nel mondo musulmano, di «teocrazia», che invece è stata sempre l’ideale ultimo nell’ebraismo.
Nel Novecento alcuni eventi storici, particolarmente traumatici, portano a una implosione di quell’equilibrio. Nel 1924 viene abolito il califfato, mentre le potenze occidentali frazionano l’Impero ottomano. Il mondo islamico perde per la prima volta la sovranità teologico-politica. Il generale Kemal Atatürk accoglie il principio occidentale della nazione – in arabo tradotta con il termine watan, che prima significava natale – e recide il legame con la umma, con la comunità musulmana, eliminando il califfato. La fondazione, in Turchia, del primo Stato laico, antinomico alla teologia islamica, è un duplice affronto: prova che l’ordine politico può fare a meno della sharia ed esautora Dio dalla funzione pubblica. La cesura è profonda, perché l’islam subisce la separazione della sovranità politica dalla comunità dei credenti – senza che l’Occidente riesca a intuirne la gravità. Anche in seguito, durante le lotte anticolonialiste, resterà sempre la tensione tra cittadinanza nazionale e fratellanza musulmana. Non si comprenderebbero i movimenti islamisti di oggi, senza considerare questa ferita ancora aperta. Al 1928 risale la prima organizzazione islamista, quella dei Fratelli musulmani.
Segna, però, una svolta soprattutto la rivoluzione iraniana del 1979. Il rapporto fra teologia e politica muta, si rovescia, con una innovazione che porta un ayatollah al potere. Una guida religiosa diventa la prima carica dello Stato. Si dà avvio così a una forma politica ibrida, che non ha precedenti nella tradizione islamica e che a torto si definirebbe teocrazia, dato che è invece una ierocrazia, cioè un regime retto da capi religiosi. In modo analogo non si può parlare di teocrazia per l’Arabia Saudita che è piuttosto una monarchia familiare seguace del wahhabismo, movimento rigorista sunnita.
Nell’Afghanistan, dilaniato dai conflitti e dalle sanguinose lotte interne, i talebani prendono il potere e nel 1996 inaugurano l’Emirato islamico guidato dal mullah Omar. La furia iconoclasta si scatena. Nonostante gli appelli degli organismi internazionali e le proteste del mondo intero, le due statue giganti del Buddha, situate nella valle di Bamiyan, vengono polverizzate da un’immensa carica di dinamite. Il 19 marzo 2001 il canale televisivo Qatar Al-Jazeera trasmette le immagini della devastazione. Secondo le regole più strette del wahhabismo, che richiede l’applicazione letterale della sharia, devono essere eliminate le opere d’arte precedenti all’avvento dell’islam. Così è stato in seguito per Palmira. Ma sarebbe riduttivo interpretare quell’esplosione, che ha suscitato enorme sdegno nell’opinione pubblica occidentale, solo come l’esito estremo di una superstiziosa avversione per le immagini. Se nell’emirato sono stati distrutti gli idoli, se alle donne è stato imposto il burqa, affinché il loro volto e il loro corpo non potessero inviare pericolosi messaggi di desiderio, se sono stati vietati gli aquiloni, che prima solcavano allegramente il cielo di Kabul, se è stato proibito il possesso degli uccelli, che con il loro canto avrebbero potuto distogliere i fedeli dallo studio del Corano, se sono stati sradicati tutti i segni, in grado di distrarre dalla irrappresentabilità di Dio, è per esporne quotidianamente, sempre e ovunque, la sovranità. Già nell’emirato, la cui esistenza è durata cinque anni, la politica è stata ridotta a strumento della teologia.
Un passo ulteriore e decisivo viene compiuto il 29 giugno 2014 quando Abu Bakr al-Baghdadi proclama lo «Stato islamico» presentandosi come califfo, vicario del Profeta, con l’intento di ricostituirne l’originaria comunità islamica. Fondato sulla sharia più stretta, l’Isis è la forma ultima, più radicale dell’islamismo, l’utopia di una inoperosità compiuta della politica che lascia il posto alla teologia. Quest’ultima, però, è intesa come lógos, discorso di Dio, nel senso che è...