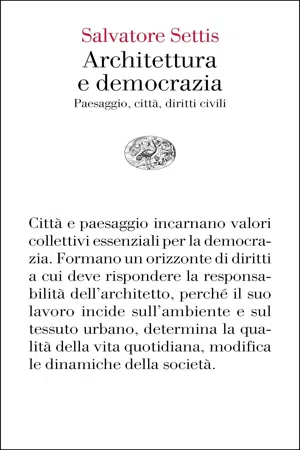In questo libro mi ero riproposto innanzitutto di disincagliare la nozione di «paesaggio» dalle secche disciplinari, suggerendo un percorso argomentativo dal quale risultasse evidente in primo luogo la molteplicità degli approcci necessari (architettura e antropologia, storia e diritto, sociologia e storia dell’arte, economia e geografia...) Da questo approccio plurimo, i cui termini ho potuto solo accennare, credo debbano emergere, ancor piú importanti, le costanti di una morfologia del «paesaggio» intesa in forte relazione con chi vi abita: uomini e donne, cittadine e cittadini, con le loro aspirazioni e i loro diritti. Una tal concezione del paesaggio considera come primario l’equilibrio fra le comunità umane e la natura, in funzione della salubrità dell’ambiente, dell’equità, dell’«interesse del genere umano» (Montesquieu). A gran contrasto, all’inizio del terzo capitolo ho richiamato la legislazione italiana sul paesaggio, dove il sovrapporsi di distinte nozioni giuridiche ha condotto nel tempo alla creazione di un inestricabile labirinto di norme, il cui effetto non è la tutela del paesaggio ma la sua devastazione.
Quattro sono in tal senso le parole-chiave: paesaggio, territorio, ambiente, suoli agricoli. Non voglio certo negare che ciascuno di questi termini abbia una propria legittimazione storica, un valore euristico-descrittivo, un potenziale normativo; fattori, tutti, che contribuiscono a fare del paesaggio la cornice operativa della riflessione e del lavoro dell’architetto. Voglio però affermare che nessun approccio, né legislativo né architettonico o urbanistico, sarà mai razionale ed efficace se non avrà tenuto conto del fatto elementare che questi termini definiscono di fatto uno stesso spazio di vita delle comunità umane, e che pertanto ogni separata regolazione dev’essere esplicitamente e accortamente raccordata con le altre. Si ha viceversa l’impressione che la legislazione italiana in quest’ambito abbia raggiunto un livello record di schizofrenia, poiché contempla non solo norme separate e contrastanti per paesaggio, ambiente, suoli agricoli, territorio, ma anche diverse autorità pubbliche a cui spettano le relative competenze; con l’ovvia conseguenza che le stesse istituzioni sono perpetuamente in conflitto fra loro, e l’interesse privato dei singoli facilmente prevale sul bene comune.
Questo caso estremo, tuttavia, mi è apparso paradigmatico, a causa della particolare qualità del paesaggio italiano ma anche perché la legislazione italiana in materia è fra le piú antiche e complesse del mondo. Il caso italiano può dunque risultare utile a indicare quanto sia di fatto sempre piú difficile (non solo in Italia) circoscrivere e definire la gestione dello spazio; e dunque, a maggior ragione, come sia arduo immaginarne o proporne un uso regolato sulla base di principî condivisi. La città si espande, si tramuta in agglomerato di periferie, divora al tempo stesso il suo cuore antico (il «centro storico») e la circostante campagna. Questa insistita metamorfosi obbliga a considerare sotto una stessa rubrica e sotto la stessa luce nozioni un tempo chiaramente distinte, anzi opposte: centro vs. periferia, oppure paesaggio (extraurbano) vs. paesaggio urbano, o ancora città vs. campagna.
La prodigiosa conservazione della cinta muraria di Lucca (1504-1648, perimetro di oltre 4 km) serva qui da simbolo e metafora di quella chiara separazione fra il perimetro storico della città e ogni sua estensione, che sia «campagna» o «periferia». Nate per la difesa militare della piccola ma prospera Repubblica di Lucca, le sue mura non subirono mai alcun assedio, e furono usate qualche volta soltanto (sprangando le porte) per contenere le inondazioni di un fiume vicino: ma proprio per questo diventarono e restano segno di indipendenza e di identità. Esse anzi generarono intorno a sé non solo un confine forte fra la città e i suoi contorni, ma anche un vasto parco pubblico, voluto già nel primo Ottocento dalla duchessa Maria Luisa di Borbone-Spagna. Intitolando Confini difficili il terzo capitolo di questo libro, intendevo da un lato respingere la divaricazione fra nozioni complementari e convergenti come le quattro parole-chiave che ho sopra richiamato, dall’altro sottolineare il legame forte e necessario fra paesaggio urbano e paesaggi periurbani o extraurbani: suggerire, in altri termini, che la continua spola fra spazi urbani e spazi non-urbani è strettamente necessaria per qualsiasi riflessione sia sulla città sia sul paesaggio. Un altro dato storico e antropologico è necessario tener presente: ogni città storica è diversa, ha una propria personalità (spesso fortissima in Italia e in Europa) che storicamente è stata capace di innescare l’orgoglio dei propri cittadini, la loro capacità creativa, il potere di attrazione dello spazio urbano. Ogni città è di per sé unica, e perciò è tanto piú sorprendente che, anziché preservare la propria unicità, molte città storiche sembrino oggi aspirare a diluire se stesse entro un indeterminato e piatto modello «globale». Rinunciando al monopolio su se stessa per appiattirsi su un modello urbano omogeneizzato e indifferenziato, la città storica commette suicidio; eppure nemmeno se ne accorge, perché prima ancora di consegnarsi ai feticci della globalizzazione ha perso memoria di sé.
L’erosione della memoria storica delle città comincia dalle periferie, uguali dappertutto e quasi dappertutto straripanti e invadenti. Le periferie delle città italiane sono tra le piú brutte d’Europa, ma sono di fatto, quantitativamente, il maggior contributo architettonico del XX secolo italiano: inutile rimuovere dalla coscienza questo dato indubitabile ricorrendo a distinzioni pretestuose come quella fra «architettura» ed «edilizia» che ho analizzato sopra (quarto capitolo). La crescita urbana, in quanto legata a movimenti demografici, a nuove prosperità, a nuovi assetti sociologici (come l’instabilità e la frammentazione dei nuclei familiari) era non solo necessaria ma fatale; ma non fu né fatale né necessario che avvenisse con una qualità costruttiva ed estetica cosí costantemente miserevole. Lo diamo talmente per scontato che abbiamo totalmente rimosso un punto essenziale: costruire periferie di assai miglior qualità era non solo genericamente auspicabile, ma operativamente possibile. Ben poco si è fatto però in tal senso, anche nelle città di altissima tradizione architettonica (cito per tutti il caso di Firenze). Oggi una grande quantità della popolazione residente in Italia (secondo alcune valutazioni, già intorno al 50 per cento)1 vive in periferie che divorano non solo la preziosa cesura città-campagna, ma la stessa idea di città, trasformandola radicalmente con un drammatico gioco al ribasso in cui lo sprawl urbano, l’assenza di servizi, l’abusivismo, il degrado, l’abbandono di edifici fatiscenti congiurano creando un paesaggio di assenze e di rovine: un processo che genera profitti ai detentori della rendita fondiaria, ai progettisti e ai costruttori, ma comporta solo perdite a chi abita quelle periferie, e soprattutto alla società nel suo insieme. Ma chi in tali periferie nasce e trascorre infanzia e giovinezza finirà con il considerare «normale» quel desolato orizzonte, e se avrà occasione di visitare un centro storico lo vedrà come estraneo, bizzarro, disfunzionale, residuale: questo sarà il punto di vista di moltissimi italiani di domani, e dunque il loro criterio di giudizio di fronte a progetti di conservazione o di distruzione del patrimonio storico delle città.
Periferie, spazi residuali, infrastrutture, «non-luoghi», «zone grigie», junkspace, rovine urbane: queste ed altre categorie del discorso, che sotto-articolano gli «spazi non-urbani» o «periurbani», vengono oggi esplorate separatamente da architetti, urbanisti e critici da un lato, sociologi e antropologi dall’altro. Fra l’uno e l’altro filone di studi corre una netta opposizione: da un lato, infatti, si manifesta la tendenza a una generale e spesso generica estetizzazione dell’esperienza dello spazio, dall’altro emergono croniche topografie del disagio individuale e sociale. L’imperioso ritorno della natura, che si riappropria gradualmente degli spazi già occupati da architetture anche di prestigio, può darci l’illusione di un ritrovato equilibrio fra le devastazioni dell’uomo e gli orizzonti di una composta naturalità. Non è cosí: le rovine urbane segnano infatti essenzialmente la sconfitta della civiltà industriale, l’incapacità di gestirne i residui, l’arretramento di una frontiera culturale piú che il trionfo di una dimensione «naturale» del vivere umano. Stanno prendendo piede dappertutto, anche in Italia, le pratiche dette di «esplorazione urbana»: per esempio, nelle Marche un gruppo di giovani fotografi che ha scelto per sé l’etichetta di «Urban Intruders» ha censito e fotografato quasi cinquecento siti abbandonati: ospedali, monasteri, parchi di divertimento costruiti con soldi pubblici e chiusi dopo pochi anni, case, fabbriche, insediamenti agricoli e alimentari, piccole industrie2. Questa esplorazione urbana viene innescata precisamente dalla presenza di confini inesplicabili: perciò gruppi di cittadini, anziché arrestarsi davanti a un muro o a un divieto d’ingresso, vi si intrudono. Appositi siti web (anche in italiano, per esempio derelicta.net) illustrano le modalità e i rischi di queste avventure civili nei luoghi di una strisciante apocalissi della forma urbana: una scia di rovine che stiamo disseminando per il mondo, perché nel dubbio equilibrio fra interesse pubblico e profitto privato non esistono regole chiare su chi debba decidere, di fronte a un edificio (abitativo o industriale) in recente rovina, se riusarlo per altra destinazione, abbatterlo per far posto a qualcos’altro o destinarlo a verde pubblico.
Il rapporto fra natura e cultura, su cui ho insistito specialmente nel quarto capitolo,...