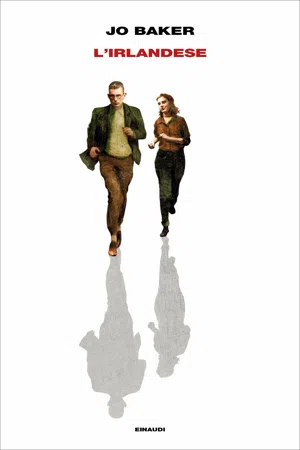Settembre 1939.
Ha la pancia gonfia e sottosopra. Gli trema la mano e ha un dolorino alla testa, proprio in mezzo agli occhi. I raggi obliqui di sole che entrano dalla finestra sul porto vengono deviati dal vetro intagliato e rimbalzano sulle stoviglie, provocandogli una smorfia di fastidio. Gli altri hanno già fatto colazione, e gli avanzi sono diventati freddi.
– Vuoi che ti faccia portare dell’altro bacon?
Scuote la testa; gli duole.
L’alcol gli sembra sempre necessario; la soluzione di tutto. La realtà ogni volta smentisce questa sua convinzione. Beve fino a farsi schifo, per ritrovarsi come adesso, dopo qualche ora insonne con la gola riarsa, a tremare di disgusto e sudare whiskey, spalmando burro su un toast freddo e deglutendo con lei che osserva ogni sua mossa, che nota ogni suo fremito. Sembra capace di annusarlo, l’odore del whiskey e del suo sconforto. Per quello diventa graffiante e goffamente propositiva.
– Uova? Ti andrebbero delle uova? – Accenna ad alzarsi dalla sedia: – Chiedo a Lily di prepararti delle uova fritte.
Risponde precipitosamente, mentre la nausea lo attanaglia: – No, grazie.
Lei si risiede. – Bisogna pure che mangi qualcosa.
Morde un angolino di toast, poi lo rimette giú. Mastica e ingoia. Ma lui sta mangiando.
– Qualcosa di sostanzioso, cioè. Di nutriente. Non del pane tostato.
– A me piace il pane tostato.
– Mangi come un uccellino. Sei malato, per caso? No che non lo sei.
Come mangiano gli uccelli? Gli aironi, le pulcinelle di mare e le sule infliggono colpi mortali, raccolgono e inghiottono dopo lotte cruente; le aquile e i falchi scagliano la preda a terra e la riducono in poltiglia. Le civette ingoiano il loro pranzo tutt’intero e rigurgitano pallottole di ossa e peli. Lui spezza il pane e ne mangia un frammento: starà mangiando come un pinguino?
Qualcosa atterra pesantemente sopra la loro testa: una spazzola o una scarpa caduta sul pavimento del primo piano. Trasalisce, senza guardare in su, mentre la madre ha un attimo di distrazione, alza gli occhi verso le crepe sul soffitto, e cambia espressione. Si sentono voci e passi. Una porta sbatte.
– Se continuano cosí, verrà giú tutto.
Che edificio traballante, questa piccola casetta che hanno affittato vicino al porto, con le finestre che sbattono e i camini che non tirano. La soluzione della madre, per impedire ai muri di cedere e al tetto di crollarle sulla testa, è di riempire le stanze di ospiti. Sheila e Mollie, le cugine, e Jill e Diana, le figlie di Sheila: tutte le femmine che la madre non ha avuto. E non vuol sentir parlare di partenza, benché si sia già a stagione inoltrata. Non soffiano ancora i venti freddi. L’estate non è finita. Il cielo è sgombro di nuvole.
– Quelle bambine! – La madre scrolla la testa e sorride.
Manda giú un altro pezzetto di pane mentre lei si versa una tazza di caffellatte. Sull’orlo della brocca si raccoglie una goccia lustra che entrambi guardano cadere. Proprio mentre sta per spingere indietro la sedia, la madre alza gli occhi e dice: – Ah, l’altro giorno in città ho visto un tuo amico. Un ragazzo molto simpatico. Un dottore. Non mi ricorderei come si chiama neanche sotto tortura. Mi sembra che facesse un paio di classi meno di te a Portora.
Ha capito a chi si riferisce. – Immagino si tratti di Alan Thompson.
– Ah, sí. Il dottor Thompson, proprio lui. Aveva un ottimo aspetto.
– Ne sono convinto.
Se lo ricordava, pallido ranocchietto, nelle acque limacciose dell’Erne; a confabulare in biblioteca, in tenuta bianca da cricket, con il sorriso birichino di chi viene colto in flagrante. Piú tardi, tra i compagni di medicina al Trinity College, mentre attraversava la corte centrale con un branco di amici chiassosi, una bottiglia di vino in mano e un sigaro in bocca. Sembrava trovarsi sempre al centro delle cose, sapere semplicemente come essere. Si erano rivisti, in seguito, avevano bevuto qualche bicchiere insieme; gli aveva dato una mano quando ne aveva avuto bisogno. Una brava persona.
Toglie la pellicina dalla superficie del suo caffellatte, viscida come una membrana intestinale, e la deposita nel piattino. È un dispetto, lo sa, ma aggiunge: – A meno che non fosse suo fratello Geoffrey.
La madre stringe le labbra. Geoffrey è uno psichiatra. – Non so se la si possa considerare medicina, quella.
Però come palliativo funziona. Adesso ogni tanto riesco a dormire, avrebbe voglia di dirle. Sono in grado di respirare: l’aria mi entra e mi esce dalla bocca correttamente. Lo si può considerare un buon risultato. Si può dire che è stato denaro ben speso. Non consiste in questo, dopotutto, la medicina?
– Beh, – dice. – Sarà contenta la vecchia madre; dev’essere molto fiera di loro.
Alza il coperchietto d’argento del barattolo di marmellata e prende il cucchiaino.
– A Parigi hai… scritto qualcosa? – gli chiede lei.
Osserva la marmellata che gocciola dal cucchiaino. È fluida e scivolosa come la saliva. Capisce la pena di sua madre, la sua ambizione. Non potrebbe, per una volta, scrivere qualcosa di rispettabile, qualcosa da poter sottoporre allo sguardo ammirato dei suoi ospiti? Rimette il cucchiaino nel barattolo, lo richiude accuratamente con il coperchietto d’argento.
– No, – risponde, – non molto.
– Allora tanto vale che rimani qui.
Le guarda il volto ossuto e aggrinzito. – Ah, davvero?
– Puoi combinare molto di piú qui, dove ci siamo noi a prenderci cura di te. Puoi scrivere quegli articoli per il giornale. So che a Parigi si vive con poco, ma non è un gran vantaggio se l’unico risultato è che dilapidi i tuoi soldi; se il tuo appannaggio…
Si irrigidisce. È diventata brava, sua madre: un’incisione chirurgica di grande precisione, cosí come la pausa.
– … se laggiú non riesci a vivere decentemente con il tuo appannaggio, e non riesci a scrivere perché hai troppe distrazioni, allora non hai scelta, devi restare qui. Per il tuo bene.
E per sentirsi rimproverare ogni spesa. Come se non sapesse già perfettamente che il cibo che mangia, l’aria che respira, l’acqua – e il whiskey – che beve, e lo stesso spazio che occupa nel mondo, costituiscono un terribile spreco.
– Potresti per lo meno aiutare tuo fratello in azienda.
– Non me ne sarebbe grato.
– Ha bisogno di una mano.
– L’ultima volta che gli sono stato fra i piedi ho combinato un disastro. Frank non ha bisogno di altri problemi.
La madre reagisce alle sue parole con una smorfia, come se avessero un gusto acido.
– Sono sicura che se almeno ci provassi, se facessi uno sforzo, se… – Lascia cadere la frase. – Eri cosí bravo al college! Lo dicevano tutti.
Dopo questa uscita, dovrebbe aver quasi concluso.
– Mi dispiace, Madre –. Si rialza, distendendo il corpo lungo e magro, e spinge indietro la sedia. – Dove vai? – gli chiede lei.
– Una boccata d’aria.
– Già, ma non hai finito di mangiare.
– Basta cosí, grazie.
Uscendo dalla stanza, le sente fare un profondo sospiro; quel suono gli irrigidisce le spalle.
Rimasta sola, attorniata dagli avanzi della colazione, con le voci delle bambine che risuonano al piano di sopra, la madre si preme le dita sugli occhi. Che esistenza precaria, poco solida, conduce suo figlio; talmente incerta, talmente alla giornata. Le sue amicizie parigine: ne ha una vaga idea, qualche sospetto, e francamente preferisce non sapere. Ma l’ha visto in quel letto d’ospedale, con il petto bendato, circondato dal chiacchiericcio incessante di infermiere francesi: le vengono le lacrime agli occhi. Se pensa a che cosa avrebbe potuto diventare! Il suo bambino cosí bello, cosí intelligente. Sta sprecando tutto, gettando tutto al vento. La farà morire di crepacuore.
Perché non è neppure felice, giusto? Almeno fosse felice!
Le bimbe fanno un gran fracasso scendendo le scale per andare a salutare il loro pseudo-zio, che le accoglie con voce allegra e affettuosa. Un’immagine fugace, da lontano, di suo figlio. Del perché debba sempre partire.
Con i loro bei cardigan e le scarpette lucide con la fibbia, Jill e Diana stanno per uscire a fare un giro mattutino. Si sente un catorcio, bilioso e colpevole, rispetto alle due bambine tirate a lucido, fresche in volto, adorabili e piene di bizzosa energia come due pony.
– Ehi, ferme un attimo, piccole pesti, – dice.
Si cava di tasca qualche moneta, gliene lascia cadere una manciata nel palmo della mano. – Compratevi delle caramelle.
– Accipicchia! Grazie!
Le bambine scendono di corsa dai gradini d’ingresso ed escono in strada, e lui dietro. Chiacchierano giulive, con il loro accento cosí inglese; cammineranno a grandi passi sul lungomare, stringendosi l’una all’altra, passando davanti ai giornali ripiegati nelle edicole, alle bancarelle con le cassette di mele, prugne e pomodori; in confetteria troveranno scaffali pieni di vivaci barattoli di bonbon color pastello, mentine bianche come il gesso, caramelle dure istoriate come vetrate di chiesa. Sbavando, succhiando e sgranocchiando i loro dolciumi guarderanno le barche piegarsi al vento e lo sciabordio delle onde, sentiranno sbattere il sartiame. Lui è attento a questi momenti, al loro accumulo. Si augura che si possano infilare uno dietro l’altro come perline da contare negli anni a venire.
Lascia le bambine andare per la loro strada e si incammina lungo la spiaggia nell’altra direzione, scivolando sui sassi che gli sfuggono sotto i piedi, sotto la stretta suola delle sue scarpe italiane, buone solo per i lastricati e gli acciottolati di città. Approfitta del precario conforto di una striscia di alghe in putrefazione, camminandoci sopra a larghi passi guardingo come un trampoliere, sgraziato e frettoloso. Poi passa deciso attraverso cespugli di cavoli marini e ciuffi slavati di armeria, con i capolini sbattuti dal vento. Segue uno stretto passaggio battuto in mezzo all’erba salata che lo porta in su, verso la strada e le ultime case del paese. Il sole è basso. Le ombre sono lunghe. Folate di vento arrivano dalla montagna.
Di fronte a lui c’è il piccolo cimitero. Si avvicina, seguendo il richiamo del cancello, e si ferma davanti all’ingresso. Dalla fines...