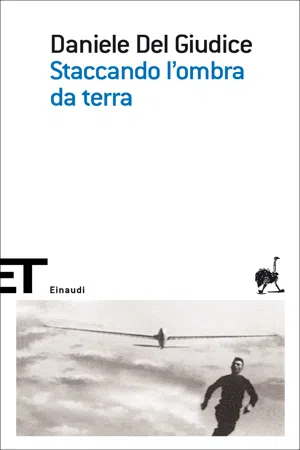![]()
Al tramonto mi sedevo a uno dei tavoli del bar nella vecchia terrazza, non proprio una terrazza, un piano di mattonelle screpolate con ringhiera, appena rilevato, dal quale si vedeva l’intera pista deserta in un colore d’erba e in un contrasto col mare che solo l’ora e la stagione rendevano possibili. Parlavo con la signora del bar, lei si lamentava del figlio che passava il suo tempo negli hangar coi meccanici invece di aiutarla, io tessevo le lodi dei meccanici e facevo apologia del valore altamente formativo della loro frequentazione; lei senza badarmi finiva di arrotolare la tenda scolorita, serrava dall’interno le porte a vetri, andava via, e con lei i pochi ancora rimasti dopo le effemeridi, al cui compiersi l’aeroporto chiudeva. Restavo lí con una birra e un manuale dopo aver volato tutto il giorno; in quella sopravvivenza di luce, nella quiete che conservava memoria dei voli, mi disperavo sugli errori che avevo commesso e su ciò che non riuscivo a fare. Quella sera mi disperavo sul doppio tre e sessanta, una procedura per l’atterraggio col motore in avaria, una spirale in due giri in discesa sul campo da eseguire a motore spento perdendo tanti piedi al primo giro e altrettanti al secondo, tenendo l’aereo senza piú motore alla velocità di massima efficienza, quella con cui avrebbe fatto piú strada, dividendo intanto mentalmente la pista in tre segmenti, decidendo per tempo dove toccare con le ruote e toccando esattamente dove s’era deciso. Non ce l’avrei mai fatta.
Le sembra difficile?, domandò il signore anziano sedendosi al mio tavolo, avesse visto cosa facevamo noi, mi creda non è cambiato nulla, le figure sono sempre le stesse, questo suo tre e sessanta lo faceva già Lindbergh in addestramento militare a Brook Fields, San Antonio, sarà stato il millenovecentoventitre o il ventiquattro, le figure sono come passi di danza, looping, tonneau, – un, due, tre, pas de deux, pas glissé, pas floré – sempre gli stessi, a proposito lei sa ballare?, guardi che è importante saper ballare, a me riusciva benissimo l’Otto Cubano, neanche difficile da fare, un gran bel passo di danza nel cielo. Oppure il looping d’ala, io lo facevo con un aeroplano non nato per l’acrobazia, lo facevo con il Settantanove, il piú famoso trimotore da guerra italiano, un bestione da diecimila chili.
Non m’ero accorto del signore anziano prima che il bar chiudesse, adesso eravamo le uniche due persone nel piccolo aeroporto, il sole scendeva lentamente dietro la fila di alberi, il signore indugiò con le dita sul suo bel fermacravatta che insieme al fazzoletto nel taschino della giacca di lana estiva gli dava un’aria composta e ironica, poi riprese: sa come facevo?, partivo da un passaggio veloce rasoterra, un’affondata a quattrocento chilometri l’ora, poi richiamavo, insistendo all’inizio e restituendo il volantino a poco a poco, tiravo l’aereo in parabola nel cielo, fino al culmine, fino al punto in cui s’arrestava nella salita, lí dovevi manovrare, né prima né dopo, se volevi che apparisse una circonferenza perfetta, quando ti sentivi appeso come un salame e senza piú saliva in bocca e guardavi l’anemometro quasi a zero e i motori affogavano nell’aria impotenti a tirare ancora piú su, allora toglievo manetta al sinistro e affondavo il pedale dalla stessa parte, il Settantanove ruotava sull’ala e puntava il muso a candela verso terra. Subito tagliavo anche gli altri due motori, la velocità aumentava a dismisura, mettevo il trim a cabrare e tiravo il volantino, accidenti se tiravo. Con un lungo arco di cerchio in discesa l’aereo riprendeva la linea di volo, sfiorava gli eucalipti, filava via basso sui prati. La prima volta che provai a farlo mancò poco che mi ammazzassi ma volevo festeggiare il ‘mio’ Settantanove; è arrivato il tuo aeroplano, Aichner, disse il comandante, io lasciai a terra l’equipaggio, presi con me solo il motorista, andammo su in volo e nel fare quel looping d’ala ancora un po’ ci restavamo secchi, era una mattina di primavera del millenovecentoquarantadue, sí questa data me la ricordo bene, avevo ventitre anni ed ero comandante pilota. Aerosilurante, cosí si chiamava la macchina e cosí la specialità, dunque l’aereo e l’aviatore, io ero un aerosilurante. Il Settantanove, l’aeroplano, un vero gioiello, uno splendido trimotore Savoia Marchetti, formidabile incassatore di colpi della contraerea, una macchina dall’aria cattiva, una di quelle macchine che già nella forma hanno qualcosa di corsaro, e un po’ corsari lo eravamo anche noi, costretti alla guerra di corsa dalla disparità di mezzi, dalle circostanze, dalla dabbenaggine di chi ci mandò in quel conflitto nel Mediterraneo secondo la migliore tradizione italiana, talento individuale e nessuna struttura alle spalle. Un gioiello le dicevo, uno splendido trimotore, maculato come un leopardo nella mimetizzazione mediterranea, la gobba subito sopra il cockpit era per il mitragliere, una mitragliatrice in avanti, una verso la coda, due canne che spuntavano da quella gobba, la gobba del «gobbo maledetto» come qualcuno soprannominò l’aereo, sul timone la croce sabauda, e quante volte dal battellino di gomma al quale eravamo aggrappati dopo un ammaraggio vedemmo quella croce affondare per ultima insieme ai tre fasci inscritti nei dischi sul dorso delle ali, mentre l’aereo si inabissava, croce sabauda e fasci compresi. Però restava a galla per ore prima che questo accadesse. Un bel trimotore, non c’è che dire, un gioiello, pilotarlo era un’emozione, oltre alle mitragliatrici in caccia nella gobba ce n’era un’altra nella fusoliera per sparare attraverso i portelli laterali, ma il pezzo forte, il vero pezzo da guerra era sotto la pancia, un siluro da mille chili; scendere a filo delle onde, sganciare e piazzare il siluro nel fianco di un incrociatore era un complesso esercizio di alta matematica istintiva, arrivavamo bassi sul mare, non per evitare i radar che nemmeno sapevamo che gli inglesi li avessero, arrivavamo bassi sul mare per sfruttare la curvatura terrestre ed essere visibili solo all’ultimo momento, ogni aereo sei persone, due piloti, un armiere, un marconista, un fotografo, le foto erano importanti, dopo se vuole le spiegherò perché, e un motorista. La statistica per l’aerosilurante – aeroplano e uomo – era di tre missioni, forse quattro, dalla quinta difficilmente si tornava per via del calcolo delle probabilità, ossia del fuoco di sbarramento delle navi, eppure eravamo tutti fieri di essere aerosiluranti, ci sarebbe piaciuto esserlo anche nella vita aerosiluranti, ma eravamo troppo giovani e candidi, avevamo tutti vent’anni, un bel gruppo, mi creda, unito dalla paura e dalle preoccupazioni, proprio un bel gruppo, il comandante di anni ne aveva ventisei, un eroe, quando sembrò che fosse morto prendemmo il suo nome, noi eravamo il Gruppo Buscaglia, il piú sorprendente circo aeroacquatico mai visto nella guerra del Mediterraneo.
Il signore anziano si arrestò un attimo, mi fissò piegando leggermente la testa, poi sorrise gentile; la sto investendo di parole disse, mi perdoni, non vorrei che lei mi prendesse per uno di quei vecchi dalla memoria incontinente. Gli risposi che no, anzi, ero curioso e l’ascoltavo volentieri. La paura, ecco, riprese allora, debbo parlarle subito della paura perché se le parlo della paura forse lei potrà sentire il racconto piú vicino; la paura non ti prendeva nell’azione, lí era questione di un terrore fisico immediato, immediatamente risolto in catastrofe o fortuna, la rapidità di quel che occorreva fare ti metteva in una specie di trance, si trattava di ballare, dovevi abbandonarti a un ritmo istintivo, concentrarti sul ritmo e non pensare ad altro, tanto se una cannonata ti colpiva in pieno eri morto prima di rendertene conto, dovevi abbandonarti all’istinto, al puro ritmo delle traiettorie che solo il destino incrocia, coincidere con quel destino, e danzare. Graziani, per esempio, Giulio Cesare Graziani lo conosce? no, non importa, è ancora vivo anche lui come me, attaccando un convoglio davanti a Tobruk, al momento di sganciare il siluro, una mano sul volantino l’altra sulla leva, notò delle macchie nel parabrezza e avvertí qualcosa di umido sul collo, ma era troppo preso dalla sensazione che dopo lo sgancio non ci fosse stato il consueto sobbalzo che indicava l’alleggerimento di dieci quintali di siluro, troppo preso dalle virate e derapate e impennate che bisognava fare nello scampo, e solo quando ebbe oltrepassato il fuoco delle navi portò una mano al collo e la ritrasse con orrore, nel palmo c’era mezzo cervello umano, era il cervello del fotografo in fusoliera scoperchiato da una granata, si voltò terrorizzato verso il suo secondo pilota, lo trovò piegato sul fianco con la camicia piena di sangue, dietro le spalle sentí il motorista che si lamentava, in cabina di pilotaggio arrivò l’armiere, ferito anch’egli, e annunciò che il fotografo era morto e che il siluro non era partito. Tutto in un istante, un istante di grande complessità come si direbbe oggi. Fece il viaggio di ritorno con l’equipaggio di morti e tramortiti, prima che scendesse il buio ebbe modo di rendersi conto che sul parabrezza oltre alle macchie di materia cerebrale c’erano dei fori di proiettile, uno corrispondeva alla sua posizione abituale ai comandi, al passaggio del colpo lui era leggermente incurvato sulla leva di sgancio, il proiettile gli aveva strappato la spallina della combinazione di volo, per poi tranciare due dita al motorista dietro. Atterrò a Gadurrà che era notte. Dall’esterno aprirono il portello, sbarcarono il morto e i feriti, lui lo trovarono seduto ai comandi con le mani sul volantino, piangeva, dovettero prenderlo di peso e portarlo a terra.
Vede, la paura non era nell’azione, era prima e dopo, quando ce ne stavamo pronti sotto l’ala dell’aereo in attesa che arrivasse qualcuno di corsa con un foglietto in mano, o alla vigilia di una missione, quando studiavamo le rotte e cercavamo di indovinare dalle carte quel che c’era da aspettarsi; lottare con la paura era ricacciare indietro ad ogni gesto quotidiano il pensiero che fosse l’ultimo, ultima rasatura, ultimo nodo alla cravatta, ultimo caffè, ultima lettera, ultima notte in un letto. Buscaglia confessava spesso di avere paura e di essere preoccupato del rischio, combatteva quei sentimenti come tutti noi, eppure era il comandante. Ce n’erano che del rischio non avevano il sentimento, e questo li sottraeva a quella estenuazione dello spirito e del corpo che la consapevolezza del pericolo produce nelle persone normali; ma certe volte penso che i migliori siano proprio quelli dall’aria preoccupata, preoccupati e taciturni, anche se non è una norma. Buscaglia comunque era cosí.
Partivamo da Pantelleria o da Decimomannu in Sardegna, da Gerbini alle falde dell’Etna, ma soprattutto da Rodi, nell’Egeo; lí la Regia Aeronautica aveva allestito una pista con baracche, Gadurrà, il campo d’involo scendeva verso il mare fino alla riva, difficile decollare in salita nel senso opposto a pieno carico quando il vento spirava dalle colline. Tra una missione e l’altra, se c’era il tempo, andavo a sedermi tra le rovine del tempio di Lindos, certe sere il mare e le alture e gli ulivi e le colonne doriche apparivano un paesaggio cosí materno e pacificato che stentavo a credere d’essere in guerra. Guerra, dalle mie parti a Trento, era un’idea di grigio, di pioggia, d’inverno, di gelo, ma come si poteva provare dolore o morire in un paesaggio cosí?
Decollavamo da Gadurrà verso convogli da guerra e da carico; l’azione cominciava molto prima, quando i nostri agenti segreti appostati ad Algesiras o a Tangeri segnalavano a Roma le navi al loro ingresso nel Mediterraneo attraverso Gibilterra. Le ho detto che si trattava di un’opera di alta matematica istintiva, potrei forse dire meglio di una matematica interiore, compiuta con un aereo da dieci tonnellate e sei persone a bordo correndo a filo del mare e tra le navi, nel fuoco di sbarramento e le granate: il siluro andava sganciato a sessanta metri sull’acqua, a una velocità di trecento chilometri l’ora, tenendo l’aeroplano alla mano in volo perfettamente orizzontale; sulla coda del siluro c’era un piccolo impennaggio che lo aiutava a planare, nell’impatto con l’acqua l’impennaggio si staccava e il siluro si trasformava da siluro aereo in siluro marino, e già questo ci imparentava ai sommergibili. Si trattava di posare in corsa sulla superficie del mare un oggetto che dopo non potevi piú controllare, tutto dipendeva dallo sgancio, dopo era come pretendere di muovere le orecchie; la quota e la velocità nonché l’impennaggio servivano per contenere l’angolo di impatto del siluro, evitando che s’insaccasse nelle onde o guizzasse o piastrellasse sull’acqua come un ciottolo lanciato da un ragazzo sulla riva. Il siluro nella sua traiettoria volante conservava la velocità dell’aereo da cui s’era separato, trecento all’ora, ma quando ammarava la velocità subacquea scendeva a settanta. Per questo bisognava sganciare il piú vicino possibile alla nave; vicino, le dico, ma non troppo vicino, perché il siluro dopo essersi immerso compiva una sinusoide prima di stabilizzarsi, e in un avvallamento della sinusoide avrebbe potuto passare sotto la chiglia della nave, scavalcandola in profondità, andando via dall’altra parte. Dunque mi segua, come a scuola o come in un giro di walzer: considerando che da settanta metri d’altezza la traiettoria aerea del siluro è di circa trecento metri, considerando che il siluro una volta entrato in acqua impiega altri duecento metri per stabilizzarsi a una profondità tarata a terra e che varia dai due agli otto metri secondo la nave che si intende silurare, ne risulta che la distanza minima dalla quale il siluro deve essere sganciato è di cinquecento metri. D’altronde, se sganciavi il siluro da piú lontano, mettiamo da mille metri, il tempo che avrebbe impiegato per raggiungere anche la piú lenta delle navi consentiva a questa di manovrare e sottrarsi. Un pluff nell’acqua sotto un aereo in avvicinamento a corsa folle: questo scorgevano dalla nave, da quel momento toccava a loro muovere passi di danza, per noi era impressionante vedere una corazzata al di là del parabrezza, dato che volavamo alla stessa altezza delle murate, vederla evoluire in piena velocità sollevando con la prua cascate d’acqua, in lotta contro il tempo che il siluro impiegava per colpirla. Quella virata affannosa e scarrocciante era l’unica possibilità di scampo per la nave, se l’angolo d’impatto del siluro era troppo sfuggente o troppo tangente, al momento dell’urto non esplodeva la spoletta, l’intera faccenda, matematica interiore e danza tra le cannonate, si risolveva in un semplice cozzo tra due pezzi di ferro, un ammacco, un bozzo, s’immagini, tutta quella fatica di precisione e quel rischio mortale per un tamponamento, una piccola innocua collisione in mare tra una nave e un qualsiasi metallo che scivola via lungo la carena disperdendosi poi chissà dove.
Sganciando da cinquecento metri occorrevano venti secondi perché il siluro colpisse la fiancata, nemmeno la piú rapida delle navi avrebbe potuto sfuggire all’arma se il pilota avesse calcolato bene lo spostamento del bersaglio e l’angolo di mira, l’angolo Beta. Perché al cuore della matematica interiore c’era l’angolo Beta, angolo formato dalla direzione della nave in movimento con la retta congiungente la posizione della nave e dell’aereo al momento dello sgancio; un angolo che è come un’ipoteca, o una canzone, sgancio mirando dove tu non sei ma dove tu sarai, tra venti secondi, se il mio conto è esatto. Non tutte le volte, come lei può immaginare, le ipoteche si riscuotono. Se il siluro aveva venti secondi per raggiungere la nave, noi, dopo averlo sganciato, noi aereo ed equipaggio ne avevamo appena quattro o cinque: era questo lo scampo, la fase piú critica, ma c’era poco da scampare, certe volte finivamo cosí a ridosso della nave che non c’era tempo né spazio per virare, non restava che passarci sopra, cosí bassi da sfiorare le antenne e le torrette, derapando, impennando, scivolando d’ala, tirando l’aereo in arrampicate rapide e rovesce nel cielo, numeri d’acrobazia non previsti per un trimotore da siluramento ma utilissimi per ingannare i puntatori della contraerea che al passaggio potevamo scorgere mentre ruotavano impazziti cannoncini e mitragliere.
Difficile uscire dal convoglio, ma col tempo divenne difficile anche entrarci. All’inizio, nei primi siluramenti, gli inglesi ci sparavano con le armi in caccia puntando ai singoli aerei, poi fu la volta del grand barrage, non una figura di danza ma una muraglia di fuoco, vedendoci arrivare giravano verso di noi tutta l’artiglieria innalzando nel cielo una parete di granate coi cannoni da interdizione, rifinita a pelo d’acqua da raffiche di mitragliere a quattro e a otto canne che rastrellavano a pettine il mare. Quel muro di ferro e di fuoco, muro per noi del calcolo delle probabilità, dovevamo attraversarlo in volo perfettamente livellato, obbligati all’assetto orizzontale e alla quota stabile per la deposizione in mare del siluro. Quando entravi in quel cielo a nuvolette nere l’aereo apriva per suo conto le danze sull’onda balistica delle esplosioni, gli occhi cominciavano a lacrimarti per il fumo delle granate, non soltanto per il fumo a dire il vero, la saliva ti si asciugava in bocca, t’infilavi in un corridoio tra un cacciatorpediniere e un incrociatore volando piú basso delle murate, cosí basso che le colonne d’acqua sollevate dai proiettili ti ricadevano sulle ali e sul parabrezza, finché dopo lo sgancio e lo scampo davi una gran pedata sui pedali e poi inarcavi l’aereo nel cielo, con l’equipaggio che si reggeva ai montanti come piú poteva.
In tutto quel trambusto micidiale nessuno sapeva dire con certezza, a meno di un’evidente esplosione, se il siluro avesse colpito oppure no; per questo c’era il fotografo, mentre tu col secondo ti occupavi lacrimando delle danze e delle matematiche, il fotografo tenuto per i piedi dall’armiere si sporgeva fuori dalla torretta sulla gobba per scattare con la Leica e il teleobiettivo, scattare una foto dopo l’altra, istantanee che servivano non soltanto a procurarti una medaglia, dato che gli inglesi non sempre ammettevano gli affondamenti o i danni delle loro navi; Buscaglia le voleva per studiare lo svolgimento dell’azione, la nostra, la loro. Appena atterravamo al campo i fotografi si precipitavano nelle camere oscure e ne uscivano mezz’ora dopo con le foto gocciolanti che finivano sul tavolo del comandante; belle foto, altroché, involontari e straordinari reportages, per noi foto ricordo incancellabili, nel rivedere a caldo lo scenario avresti creduto impossibile esserci stato in mezzo, esserne uscito vivo. Dalle fotografie valutavi se la colonna d’acqua sul fianco di una nave era effetto del marasma o se si trattava dell’esplosione del siluro, e con quanto danno; ma anche i danni nostri s’intuivano dalle fotografie, potevi trovare inquadrato un Settantanove in fiamme al momento in cui finiva in mare, e dal tipo di spruzzi sollevati indovinare se c’era speranza per quelli a bordo d’essere salvi o meno. Gli ammaraggi erano frequenti, questo anche c’imparentava ai sommergibili, ma dipendeva da come entravi in acqua con l’aereo, se stavi bruciando, se potevi ancora governare: fuori i flap, giú le manette, all’ultimo momento puntavi i piedi e il braccio destro sul cruscotto, col sinistro davi uno strattone al volantino cabrando l’aereo che veniva ingurgitato dall’onda e risputato qualche secondo dopo, se tutto andava bene dopo un tremendo contraccolpo vedevi l’acqua spumeggiare e defluire giú dal parabrezza, e il Settantanove s’arrestava galleggiando. A quel punto mettevamo in mare il battellino, se c’era il tempo si portava via ogni cosa utile e si distruggevano i codici dei cifrari, che per il loro affondamento il piú rapido e irrecuperabile erano rilegati in piombo.
In mare, deve sapere, io ci sono finito diverse volte, la prima per stupidità, al rientro da un volo d’allenamento nella rada di Pola, per salutare degli amici sulla spiaggia di Sistiana mi abbassai cosí tanto sull’acqua che le eliche dei motori laterali toccarono le onde, ci fu un tremendo boato di campane e le punte delle pale si incurvarono in fuori; riuscii a riprendere quota ma l’aereo tenuto su dal solo motore centrale scadette rapidamente; l’equipaggio si precipitò in cabina con un atteggiamento di forte riprovazione, poi mentre sudavo sette camicie divenne curiosità per come me la sarei cavata, e infine apprezzamento per un ammaraggio riuscito senza che nessuno mai mi avesse spiegato cosa succede di un aereo terrestre quando finisce in acqua. La seconda volta ammarai nelle acque di Pantelleria dopo aver affondato il mio cacciatorpediniere, lei perdonerà se lo definisco mio, in realtà era d’un comandante inglese che molti anni dopo ho conosciuto a Londra, un tipo simpatico, assai buffo; già prima che sganciassimo il siluro eravamo stati colpiti, al passaggio sopra la nave fummo impallinati ulteriormente, sentii l’aereo mancarci sotto i piedi. Una volta in mare, mentre l’equipaggio s’imbarcava sul battellino mi sistemai su un’ala e col martello cominciai a lavorare a un alettone per ricavarne un timone nautico, intanto il secondo pilota smontava dal cruscotto la bussola che può sempre tornare utile; chiamati dal battellino, ci voltammo appena in tempo per vedere la nave che alzava oscenamente la prua in aria e affondava di poppa. Questo avveniva nella battaglia di Mezzo Giugno, giugno del quarantadue intendo. La terza volta, beh, la terza volta, semmai gliela racconterò dopo.
Ripensando al rischio, il passo successivo agli aerosiluranti poteva essere soltanto il kamikaze, e qualcosa del genere dovette passare per la mente dello Stato Maggiore se nella battaglia di Mezzo Agosto, dopo che la portaerei Furious all’altezza del meridiano di Algeri ebbe lanciato una quarantina di Spitfire destinati alla difesa di Malta, dall’aeroporto di Villacidro in Sardegna decollò un Settantanove con nessuno dentro, guidato via radio da bordo di un Cant Z che lo seguiva; il Settantanove, imbottito di esplosivo, doveva colpire una delle navi piú grosse del convoglio, tutto funzionò a dovere fino in vista della formazione inglese nei pressi dell’isola di La Galite, qui un condensatore del radiocomando fabbricato con la povertà di sempre si surriscaldò, il Settantanove insensibile agli impulsi sorvolò il convoglio e proseguí dritto filato in Algeria dove si schiantò. Per i soccorritori fu un gran mistero non trovare traccia di uomini fra i resti dell’aeroplano. Mezzo Giugno, Mezzo Agosto, buffi nomi per delle battaglie, nomi temporali e non di luogo, comunque furono le ultime due grandi battaglie aeronavali del Mediterraneo, entrambe combattute per impedire agli inglesi di rifornire Malta. Ma Malta ormai era per noi perduta, e ben altri erano i problemi: volando oltre ogni linea di fronte, noi avemmo il triste privilegio di percepire prima di altri che la guerra era perduta, bastava vedere l’impressionante volume dei convogli che entravano nel Mediterraneo e si ammassavano nei porti e dei quali noi andavamo in caccia, lo avremmo capito meglio piú tardi, attaccando le navi nella rada di Algeri o a Gibilterra, azioni di guerra, certo, ma anche azioni di propaganda, piccole imprese per alimentare i bollettini e tenere alto il morale e magari illudere un alpino in Albania che il mare nostrum fosse ancora di nostra proprietà; rischiavamo la pelle con paura, tre o quattro missioni e non di piú, ricorda?, da ogni missione tornavamo con le idee sempre piú chiare su come sarebbe finita male, e questa consapevolezza, mi creda, rendeva tutto ancor piú doloroso e senza speranza. Poi a Comiso fu catturato un bombardiere nemico, l’equipaggio era inglese ma l’aer...