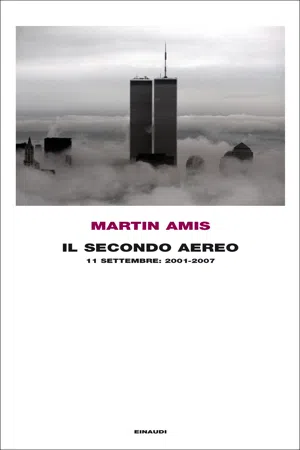![]()
Era metà ottobre del 2001, e calava la sera su Peshawar, città di confine del Pakistan, quando il mio amico – reporter e letterato politico – si avvicinò a una bancarella e si mise a mercanteggiare per una partita di magliette con il ritratto di Osama bin Laden. È vietato, nell’Islam sunnita, riprodurre la figura umana, si rischia di cadere nell’idolatria; ma lí c’era il viso altero e ottuso di Osama, in bella vista e in vendita proprio davanti alla moschea. Moschea che si andava svuotando, dopo le preghiere serali, e il mio amico si ritrovò ben presto interamente circondato da una confraternita che spingeva, sgomitava, sbeffeggiava: i giovani di Peshawar.
In quello stesso momento della giornata, i loro corrispettivi, nelle grandi conurbazioni europee e americane, potevano aspettarsi di alleviare le loro sopportabili frustrazioni ingollando alcol in quantità, ingurgitando pasti luculliani senza restrizioni dietetiche, recandosi l’uno a casa dell’altro a bordo di costosi bolidi, ingollando altro alcol con l’aggiunta di stimolanti e rilassanti, dimenandosi per ore su piste da ballo sferzate da luci stroboscopiche, e (in un discreto numero di casi) facendo sesso galvanizzante con persone sconosciute o quasi. Diversivi non disponibili ai giovani di Peshawar.
Piú vicino, appena oltre il confine, l’Occidente si predisponeva a invadere l’Afghanistan e a massacrare i talebani – clienti devoti, frutti dell’ingegno e fratelli pashtun del Pakistan – e a spianare l’Hindu Kush con il suo potere e la sua ira. Piú vicino ancora, le orecchie di quei giovani continuavano a fischiare per le grida di battaglia dei mullah infervorati, e gli occhi ricominciavano a bruciare per il fumo che si levava come gesso dalle centinaia di migliaia di falò – falò accesi dalle masse sterminate di esiliati e rifugiati afghani accampati tutt’intorno alla città. C’era, forse, anche la consapevolezza che, nell’ultimo mese, la Repubblica islamica del Pakistan aveva sovvertito anni di politica decidendo di immolare, oltre confine, i suoi clienti musulmani, frutti dell’ingegno e fratelli pashtun, in cambio dei contanti americani. Perciò alla domanda risentita della folla, bisognava fornire una valida risposta.
– Perché le vuoi, ti piace Osama?
Mi sembra quasi di sentire il tono della replica che avrei fornito io: esile, esitante, totalmente disfattista. Quanto alla sostanza, sarebbe stata la replica dell’opportunista stretto all’angolo, intesa, in realtà, soltanto a darmi il tempo di cercare la posizione fetale e portarmi le mani sulla faccia. Una cosa del tipo: «Altroché se mi piace, ma secondo me a New York ha un po’ esagerato». No, sarebbe servito a poco. Lí ci volevano estro e faccia tosta. Lo scambio proseguí:
– Ti piace Osama?
– Per forza. È mio fratello.
– Tuo fratello?
– Tutti gli uomini sono miei fratelli.
Tutti gli uomini sono miei fratelli. Mi sarebbe piaciuto dirlo allora, e mi piacerebbe dirlo adesso: tutti gli uomini sono miei fratelli. Ma tutti gli uomini non sono miei fratelli. Perché? Perché tutte le donne sono mie sorelle. E il fratello che nega i diritti a sua sorella: quel fratello non è mio fratello. Fratellastro, tutt’al piú, con le sue implicazioni. Osama non è mio fratello.
La religione è un terreno delicato, com’è giusto che sia. Si cammina sulle uova. Perché la religione è di per sé un guscio vuoto. Oggi, in Occidente, non esistono scuse valide per il credo religioso – a meno di non considerare scuse valide l’ignoranza, il conservatorismo e il sentimentalismo. Altrettanto non si può dire per l’Oriente dove, constatiamo, quasi ogni singolo cittadino dei tanti paesi sterminati e popolosi è intimamente definito dal credo religioso. Le scuse, in questo caso, sono quanto mai convincenti; e ammettiamo doverosamente che la «fede» – descritta in tempi recenti e in toni quasi affettuosi come «il desiderio di approvazione da parte di esseri soprannaturali» – è una forza e una protagonista della storia mondiale. Non sorprende che tutte le religioni abbiano i loro terroristi: cristiani, ebrei, induisti e perfino buddisti. Ma non è di quelle religioni che sentiamo parlare. Sentiamo parlare dell’Islam.
Vediamo di chiarire la nostra posizione. Cominciamo col dire che non solo rispettiamo Muhammad, o Maometto, ma che una persona seria non mancherebbe mai di rispettare Maometto – personaggio storico unico e mirabile. Rimane una figura titanica che si presta, per i musulmani, a ogni esigenza: un rivoluzionario, un guerriero, un sovrano, un Cristo e un Cesare, «con il Corano in una mano, – come l’ha immaginato Walter Bagehot, – e una spada nell’altra». A giudicare dagli elementi di continuità che è riuscito a mettere in moto, può rivendicare a buon diritto il ruolo di uomo piú straordinario che sia mai vissuto. E sempre uomo, come ha sempre sostenuto, non dio. È naturale che rispettiamo Muhammad. Chi non rispettiamo è Muhammad Atta.
Fino a non molto tempo fa si diceva che ci ritroviamo di fronte a una «guerra civile» intestina dell’Islam. E in effetti doveva essere proprio questo: non già uno scontro di civiltà né altro del genere, bensí una guerra civile intestina dell’Islam. Be’, la guerra civile sembra finita. E l’ha vinta l’islamismo. Il perdente, l’Islam moderato, ha sempre un’ingannevole posizione di spicco negli editoriali e nel dibattito pubblico; altrove è inerte e impercettibile. A noi la voce dell’Islam moderato non arriva. Mentre quella dell’islamismo, che innesca e plasma gli eventi mondiali, ci assorda.
Perciò ribadiamo il nostro rispetto per l’Islam – che ha elargito benefici a non finire all’umanità, e può vantare una storia avvincente. Ma l’islamismo? No, non possono certo chiederci di rispettare una corrente avventizia che invoca la nostra eliminazione. E poi consideriamo il «grande balzo all’indietro» un tragico sviluppo della storia islamica, e ora anche della nostra. È naturale che rispettiamo l’Islam. Ma non rispettiamo l’islamismo, proprio come rispettiamo Muhammad e non rispettiamo Muhammad Atta.
Tra breve arriverò a Donald Rumsfeld, architetto e garante del cataclisma in Iraq. Prima, però, devo rivolgermi dalle grandi cose alle piccole, per un paragrafo, e parlare di scrittura e della strana cosa che mi è capitata stando alla scrivania in quest’Era della Normalità Svanita.
Tutti gli scrittori di narrativa si ritrovano prima o poi ad abbandonare un’opera – o a «metterla da parte», come diciamo in modo piú gentile. L’idea originaria, il «palpito» iniziale (Nabokov), incontra determinati «punti di resistenza» (Updike); e questi punti di resistenza, in certi casi, sono semplicemente troppo ostinati, numerosi e pervasivi. Fai per scrivere la pagina seguente, e la scopri morta – quasi che il tuo subconscio, quella parte di te che in silenzio si accolla tutte le fatiche quotidiane, fosse neutralizzata, o spenta. Norman Mailer ha detto che uno dei pochi aspetti davvero incresciosi dell’«arte spettrale» è che ti costringe a passare troppi giorni in mezzo a cose morte. Di recente, e per la prima volta in vita mia, ho abbandonato non già una cosa morta, bensí un racconto in pieno rigoglio; e l’ho fatto per motivi completamente a parte. Non è certo un evento tellurico, lo so bene; ma per me è stato un episodio di portata esistenziale. In Occidente, gli scrittori si sono acclimatati alla libertà – a una libertà ghiotta e illimitata. E ho scoperto una cosa. La scrittura è libertà; e non appena su tale libertà cala un’ombra, lo scrittore non riesce piú a proseguire. L’ombra non era la paura di ripercussioni. Era come se ricevessi, con estrema riluttanza, una nuova vibrazione o una nuova frequenza dal baluginio planetario. Il racconto era una satira dal titolo Il noto ignoto.
Il segretario Rumsfeld è stato ingiustamente deriso, secondo alcuni, per la sua tassonomia in stile haiku della minaccia terroristica:
Questo il messaggio: ci sono cose note note. Ci sono cose che sappiamo di sapere. Ci sono cose ignote note. Vale a dire che ci sono cose che sappiamo di non sapere. Ma ci sono anche cose ignote ignote. Ci sono cose che non sappiamo di non sapere.
Questo, al pari dell’abitudine di parlare in «terza persona passiva di secondo grado», è «molto rumsfeldiano». E Rumsfeld sa essere anche piú rumsfeldiano di cosí. Stando a Piano d’attacco di Bob Woodward, nel corso di una riunione senatoriale a porte chiuse del settembre 2002 (l’idea era quella di promuovere il cambio di regime in Iraq), Rumsfeld aveva esasperato tutti i presenti con una valanga di rumsfeldismi, inclusa la seguente strofa: «Sappiamo quello che sappiamo, sappiamo che ci sono cose che non sappiamo, e sappiamo che ci sono cose che sappiamo di non sapere che non sappiamo». Fatto sta che le tre categorie tornano molto utili come strumenti analitici. E di sicuro hanno avuto grande presa sulla voce narrante del Noto ignoto: Ayed, un minuscolo terrorista islamico che esercita la sua attività in Waziristan, il malconcio territorio al confine settentrionale dove si vocifera che sia ancora nascosto Osama bin Laden.
Una volta l’impresa di Ayed, che si chiama «il “Prisma”», era composta da tre settori indicati, senza troppa fantasia, come Settore Uno, Settore Due e Settore Tre. Ma Ayed e i suoi colleghi sono lettori attenti della stampa occidentale, e i settori recano ora nuovi titoli. I Noti Noti (Settore Uno) si occupa della logistica quotidiana: bombe, mine, granate e vari congegni esplosivi improvvisati. Il lavoro degli Ignoti Noti (Settore Due) è piú itinerante e a lungo termine; implica, per esempio, scorribande in tutta la Corea del Nord nella speranza di procurarsi i leggendari venticinque chili di uranio arricchito, o il giro di tutte le fabbriche dell’Uzbekistan alla ricerca di tossine e gas asfissianti migliori. Nei Noti Noti i fratelli sono tormentati da incendi, fuoriuscite di gas ed esplosioni quasi quotidiane; i fratelli degli Ignoti Noti sono angustiati da emicranie e mal di gola e hanno nell’alito l’aroma ben percepibile di potenti pastiglie per la tosse, che si sparge intorno mentre si aggirano fra tinozze di acido e vasche di pesticidi non raffinati. Tutti vogliono lavorare dove lavora Ayed, cioè nel Settore Tre, o gli Ignoti Ignoti. Il Settore Tre si dedica alle conquiste concettuali – ai cambiamenti nel paradigma.
Cambiamenti nel paradigma come l’attacco dell’11 settembre 2001. I cambiamenti di paradigma aprono una finestra; e, una volta aperta, la finestra si richiude. Ayed osserva che l’11 settembre è stato da subito irripetibile; anzi, la tattica era obsoleta alle 10 di quella mattina stessa. La sua efficacia è durata settantuno minuti, dalle 8,46, quando l’American 11 ha colpito la Torre Nord, alle 9,57, inizio della ribellione a bordo dello United 93. A bordo dello United 93, i passeggeri hanno appreso la nuova realtà dai telefoni cellulari, e non hanno indugiato a lungo nel vecchio paradigma – i quattro giorni di assedio sul cemento equatoriale, lo scarseggiare di cibo e acqua, i bagni sempre piú pestilenziali, le condizioni e le richieste, il rilascio scaglionato di donne e bambini; poi la resa, o l’irruzione delle forze speciali. No, sapevano di non essere su un aereo di linea, non piú; erano su un missile. Perciò sono insorti. E alle 10,03 lo United 93 è precipitato al rovescio a novecentotrenta chilometri orari a Shanksville, in Pennsylvania, a venti minuti dal Campidoglio.
Io trovavo di una difficoltà rassicurante escogitare cambiamenti di paradigma. E lo trovano difficile anche Ayed e i suoi amici del Settore Tre. Sinergia, massimalizzazione – questi i concetti che rimpallano da un cuscino a una stuoia nel settore degli Ignoti Ignoti. Qui un compagno parla di far saltare con la dinamite la faglia di Sant’Andrea; lí un altro prospetta una diffusione della rabbia su vasta scala (mischiata con vaiolo, metamfetamine e steroidi) tra la fauna di Central Park. Segue un silenzio meditabondo. E molto spesso tali silenzi durano giorni e giorni. Dal settore degli Ignoti Ignoti arriva solo il raro battito di un palmo che ammazza una mosca, o lo scricchiolio di uno scarafaggio schiacciato sotto un piede. Ayed si sente, o si sentiva, superiore ai colleghi, perché ha già avuto il suo momento di genio. L’ha avuto nella primavera del 2001, e il suo progetto – la sua «creatura», se preferite – è stato varato nell’estate dello stesso anno, ed è tuttora in corso. Ha un nome in codice: II: SC/G,C.
La conquista concettuale di Ayed non ha riscosso grande successo nel Settore Tre, come si chiamava allora; anzi, è stata ampiamente derisa. Ma, avvalendosi di un amico di famiglia, Ayed ha ottenuto un’udienza con il Mullah Omar, il religioso islamico con un occhio solo che per un breve periodo ha governato l’Afghanistan – una figura imponente con quella sua tunica e le infradito. Ayed gli ha illustrato il progetto e il Mullah Omar l’ha accolto a sorpresa con un sorriso. Una condizione imprescindibile, perché il cambiamento di paradigma di Ayed era realizzabile solo con tutte le risorse di uno stato nazionale. L’II:SC/G,C è andato avanti. L’idea era, come avrebbe detto Ayed, di una semplicità ingannevole. L’idea era battere tutte le prigioni e i manicomi in cerca di ogni singolo stupratore compulsivo del paese, e poi di sguinzagliarlo a Greeley, in Colorado.
All’inizio della vicenda, gli SC (stupratori compulsivi) marciano da cinque anni alla volta di G,C (Greeley, Colorado), e attraversano l’Africa, a bordo di minibus e a piedi, subendo vari rovesci sanguinari (un’orda di circa trentamila janjaweed in Sudan, una «milizia infantile» armata di machete in Congo). A coronare il tutto, come se non avesse già abbastanza motivi di preoccupazione, Ayed non va troppo d’accordo con le sue mogli.
Chi conosce il campo non si stupirà della scelta di Greeley, in Colorado. Perché è stato a Greeley, in Colorado, che nel 1949 l’islamismo come lo conosciamo oggi ha assunto una fisionomia decisiva. È una storia grottesca e incredibile – ma del resto lo sono anche le sue conseguenze. E continuiamo pure a ripeterci quanto sia grottesca e incredibile la realtà attuale, cosí imprevedibile, cosí del tutto inconoscibile, anche dalla prospettiva dei tardi anni Novanta. Alla fine degli anni Novanta, se ben ricordate, l’America aveva tanto di quel tempo da perdere, politicamente e culturalmente parlando, da poter dedicare un intero anno a Monica Lewinsky. Perfino Monica, si direbbe ora, perfino Bill, vivevano in un’epoca innocente.
Da lí in poi il mondo ha subíto un tracollo morale – l’equivalente spirituale, quanto a profondità e portata globali, della Grande Depressione degli anni Trenta. Da parte nostra, trasferimenti di prigionieri con procedure straordinarie, sistemi psicologici coercitivi, miglioramento delle tecniche di interrogatorio, Guantánamo, Abu Ghraib, Haditha, Mahmudiya, due guerre, e decine di migliaia di cadaveri1.
E questo andrebbe paragonato a mente fredda alle prodezze dell’ideologia opposta, un’ideologia che, nella sua forma piú millenaristica, evoca l’immagine di un mattatoio all’interno di un manicomio. Voglio dirlo chiaro e tondo, perché non è stato assimilato nella giusta misura. Gli islamisti sunniti piú estremisti vogliono uccidere tutti gli abitanti della terra eccezion fatta per gli islamisti sunniti piú estremisti; ma anche i jihadisti di bassa lega capiscono la necessità di eliminare tutti i non-musulmani, vuoi con la conversione vuoi con la pena capitale. E ora sappiamo che cosa succede quando l’islamismo mette le grinfie sull’esercito (Algeria) o su qualcosa che somigli a uno stato nazionale (Sudan). Nel primo caso il risultato è stato fratricida, con 100000 morti; nel secondo, in seguito al colpo di stato islamista del 1989, il risultato è stato una specie di genocidio rovinoso, e la cifra si aggira sui due milioni. E tutto risale a Greeley, in Colorado, e a Sayyid Qutb.
Le cose hanno cominciato a prendere una brutta piega per Sayyid quando è partito da Alessandria d’Egitto e, durante la traversata atlantica, «una donna ubriaca e seminuda» pare che abbia cercato di irrompere nella sua cabina. Ma prima di arrivarci, qualche antefatto. Nel 1949 Sayyid Qutb aveva appena compiuto quarantatre anni. Veniva da un’infanzia provinciale e religiosa. Quando, da ragazzo, era andato a studiare al Cairo, aveva mostrato propensioni letterarie ed eurofone e perfino blandamente cosmopolite. Nonostante una precoce – e, come da copione, disorientante – ammirazione per il naturismo, trovava già le donne cairote «indegne», e confessava di disapprovare «il loro attuale livello di libertà». Un racconto riferiva le sue prime delusioni negli affari di cuore; aveva il lacrimevole titolo di Spine. Be’, ci siamo passati tutti; e la maggior parte di noi segue la parabola descritta nella poesia di Peter Porter Once Bitten, Twice Bitten: rimane scottato ma ci riprova. Sayyid, però, non necessitava di ulteriori dissuasioni. Rinunciò all’istante a ogni speranza di trovare una donna di «sufficiente» purezza, e decise di attenersi al diavolo che conosceva: la verginità.
Avviata una modesta carriera di scrittore, Sayyid accettò un impiego al ministero della Pubblica istruzione. Questo lo rese ancor piú radicale. Si sentiva oppresso dalle vestigia del protettorato britannico in Egitto, ed era allarmato dal peso crescente della presenza ebraica in Palestina – altro crimine britannico, agli occhi di Sayyid. Divenne un attivista e rischiò la galera (per mano del licenzioso re Faruq), prima che il ministero lo spedisse in America per un paio d’anni di ricerche nel campo dell’istruzione. La galera, a proposito, l’avrebbe reclamato subito dopo il ritorno in patria. Fu tra le decine di Fratelli Musulmani messi in prigione (e torturati) in seguito al fallito attentato alla vita di Nasser, modernizzatore e laicista, nell’ottobre del 1954. Dopo una breve sospensione della pena nel 1964, Sayyid fu subito nuovamente arrestato – e torturato. Rifiutò fermamente un accordo di clemenza che vedeva nel ruolo di mediatore nientemeno che il giovane Anwar Sadat, e venne impiccato nell’agosto del 1966; un martirio strategico che ha ormai radici profonde nell’animo islamista. Il suo libro che ha esercitato maggiore influenza fu scritto, al pari di quello a cui viene spesso paragonato, dietro le sbarre. Pietre miliari è noto come il Mein Kampf dell’islamismo.
Forse Sa...