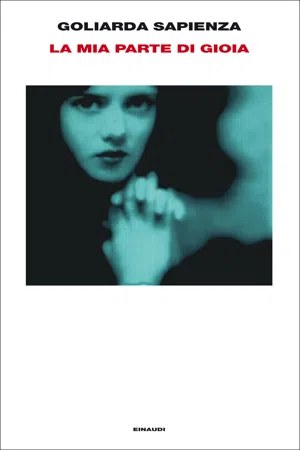![]()
![]()
Capodanno 1990 a Gaeta.
I piú piccoli sono piú buffi, a volte piú stonati e con canti piú elementari ma completamente pieni di «divertimento per il divertimento». Domani sera – come tutti gli anni – questi sciusci di tutte le età e provenienza, dopo aver impazzato per ogni cantuccio di Gaeta e dintorni, si incontreranno per la gran tenzone finale (con premio) nella piazza vicino al mercato del pesce, intorno al grande platano dai rami spogli, invernali – il solo segno d’inverno di queste contrade –, dove qualche pacchetto colorato ma poverissimo e qualche lampadina stanno a dire che quello è l’albero di Natale della popolosa famiglia gaetana.
Quando quindici anni fa approdai in questi lidi, temevo che questa usanza sarebbe scomparsa in pochi anni, ma non è stato cosí, e sentirli la sera, fino a notte alta, gridare la loro gioia giú per il nostro vicolo, o quello appena dopo, o quello ancora piú lontano chissà forse verso la foce di questo fiume di pietre, mi dà la stessa gioia di allora; come se quindici anni non fossero passati e io fossi ancora in quell’unica stanza tre metri per quattro, messa in bilico sull’antro dove si dice cominci un tunnel di una villa romana, che si svolge per chilometri percorrendo tutto il paese per approdare chissà dove – in un campo? O ai piedi di un monte? –, ma sicuramente dove un tempo c’era un’altra villa o fortezza. In quella stanzetta, con un pezzo di forno sopravvissuto da secoli e una scala interna di pochi gradini conducenti a una piccola «pennata» con tre metri di terrazzo, i due «grandi amici poeti» della romanità venivano spesso – la notte – a trovarci. Il loro luogo preferito per mostrarsi a noi era il pezzo d’arco del forno superstite, unico posto dove le loro lunghe sagome d’intelletto e amorosi sensi potevano dispiegarsi su per tutta la vastità sconfinata del loro sapere. Uno era come una scia corposa (modellata in un corpo che dolcemente tende con le braccia a cercare il cielo) e dai bagliori soavi della Via Lattea, l’altro nella stessa postura lanciava un fascio di luce blu opaca e nello stesso tempo luminescente. Sempre insieme, apparizione danzante su una melodia amorosa d’amicizia eterna. Non so se questi due amici-poeti ci hanno seguito nella nuova casa… non so se gli è permesso spostarsi nello spazio degli umani per tanti metri… Certo è che non li ho piú visti la notte, qui al n. 8 di vico IV Indipendenza. Forse indignati sono fuggiti dalla loro casa del forno cambiata in cassa di una birreria, sorta giú all’ingresso pieno di volte del lungo tunnel buio… chissà, tutto è possibile con queste apparizioni della fantasia, e nella mia fantasia mi osservano e io ascolto la loro presenza morale di poeti puri, presi solo dalla «poesia per la poesia».
Ruggiero mi viene a prendere alle otto di sera e andiamo da Isa, dove un quartetto di russi dall’aria niente affatto liberata ci attende e ammorba con la sua malinconia tutta la cerimonia. Lo sapevo da sempre, ma il constatare quanto sono lacrimosi questi russi mi turba. Anche se ridono, il loro riso è impastato di lagrime lamentose come il loro fonema.
Isa tenta una sortita contro Israele che non ottiene nessun commento. Ruggiero ha costruito con la carta da pacchi il piú bel pupazzo di fine anno che mai sia nato dalle sue piccole mani d’artista. A mezzanotte lo bruciamo fingendo di essere allegri e speranzosi verso questo 1990 che entra fra botti, sciusci e notizie falsamente speranzose di future libertà e pace…
All’una e mezza, sotto una pioggia viscida, aggravata dal sentore di polvere di fuochi d’artificio (o di cannoni?) torniamo a casa, quasi senza parlare: non c’è niente da dire ed è ragionevole nemmeno pensare ma rifugiarsi nei nostri rispettivi letti e dormire.
Primo giorno del nuovo anno.
Passeggiata lungo il porto, pescherecci in riposo con le ali ripiegate lungo i fianchi, un gabbiano lontano mantiene la sua posizione sulle onde grigie e brevi urtate dal Garigliano. Compro le sigarette dal gobbo che vive con la madre in quell’antica condizione casa-negozio di cui era piena l’Italia fino a trent’anni fa; questi negozi erano comodissimi perché non chiudevano quasi mai – la casa dietro o sopra dove dormire, mangiare, e il negozio a mo’ di salotto sempre aperto agli amici-avventori. La tranquillità con cui la madre segue il figlio gobbo è tipica di queste strane donne-madri (sia al sud che al nord) a cui un figlio informe o handicappato dà una sorta di tranquillità muliebre di averlo per sempre accanto.
Da anni non vedevo questo spettacolo inquietante, cosí come da anni non vedevo un gobbo. Questo è il gobbo per antonomasia: testa bellissima aquilina con movimenti regali, gli occhi azzurro-verde chiaro magnetici e sempre leggermente annoiati (anche verso la madre), o ritrosi e altezzosamente bonari di chi, sapendo di essere di una bellezza eccezionale, si prende il lusso di offrire ai tuoi sguardi il pane della sua beltà; sanno i gobbi quanto la loro mostruosità sia affascinante, e se questo ha un animo principesco e si limita (come Luchino) a lasciarsi «mangiare con lo sguardo», ne ho incontrati alcuni audaci, satireschi, pronti dopo averti fissato a lungo a saltarti addosso ferocemente.
In via Pistone c’era una ragazzina che, per seguire il gobbo sarto che aveva bottega a pochi bassi dal nostro portone, aveva abbandonato la famiglia senza dare piú notizie di sé. Vivevano insieme alla madre di lui… non ricordo altro. Io ero già a Roma da un anno quando il terzetto finí in tragedia come dissero alcuni, mentre altri parlarono di fuga dei tre mostri per paura di essere stati localizzati dal padre della bella adolescente… Pian piano questa fuga dal basso e da tutto il quartiere San Berillo si tramutò in una leggenda di sparizione e apparizione, qualcuno li vedeva apparire in via Etnea, o in un campo, o là dove Catania finiva e cominciava la sciara.
Il mio gobbo tabaccaio non mi guarda mai in viso, ma sento che sa tutto di me: sono dieci anni che l’ho scoperto, e a volte lo vado a trovare anche se è molto lontano da casa mia. Oggi mi ha anche sussurrato con voce scontrosa e amichevole guardando sopra la mia testa, cosí ch’io ho potuto ammirare il vetro vibrante di luce delle sue pupille con tutta calma: «Buon anno signora». Forse è l’ultimo gobbo che vedrò nella mia vita, e quel «Buon anno signora» mi ha colpito come un alto riconoscimento da parte di chi sa tanto di sventure, destini dolorosi, miserie. Che abbia riconosciuto in me la grande sofferenza che mi tiene e abbia voluto darmi un segno? Grazie, bel gobbo della marina di questo stupendo golfo di Gaeta.
Sono le 22:30, il primo giorno dell’anno è quasi terminato, Angelo telefona da Palermo. Mi racconta delle mangiate familiari: trenta individui di una stessa famiglia ammucchiati in una casa (quasi sempre della zia) che stanno otto o nove ore insieme. «Qui l’incuneamento è assoluto!», come dice Angelo. Invidio il suo viaggio in nave la notte di Capodanno, dice che erano solo sette passeggeri, e quando dopo la cena anche questi si sono ritirati, lui ha girato per la nave vuota, beato lui: una nave fantasma che fila nella notte è sublime. Dieci anni fa anch’io provai questa emozione curiosa d’altri tempi – stavo per dire d’oltretomba, perché andare su una nave vuota dà un senso d’avventura ultraterrena. Fu magnifico. Certo, quando dieci anni fa andammo in Sicilia la notte di Capodanno, era persino piú impressivo, perché ancora c’erano in funzione le vecchie navi che portavano i nomi dei poeti. Queste nuove navi con nomi di strade non hanno quel fascino esoterico, ma Angelo dice che anche se con un pizzico stonato kafkiano la bellezza della nave vuota è sempre enorme. Ha girato in lungo e largo per ore!
Ho ricopiato i numeri indispensabili dall’agendina verde scuro dell’89 a quella rosso scuro con strisce piú chiare del ’90. Novanta, che numero concluso: è terribile, auguriamoci bene… Dicevo: ho ricopiato i numeri, lavorato per casa, ieri primo dell’anno ho fatto pochissimo, e la casa è cosí piccola che basta un giorno per creare un disordine di una settimana. Dicono che le case piccole si sporcano di piú, ma non è vero, è solo che lo sporco e il disordine ti restano sotto il naso, si vedono di piú.
A Gaeta i vecchi litigano ancora – davanti alla cassa – per offrire la consumazione agli amici, questo rito cavalleresco nutrito da cortesia, bisogno di potenza, confronto finanziario e qualche misteriosa forma d’amore e omosessualità colpisce per la sua eleganza e la sua spocchia. In ogni caso è un modo gioioso di comunicare e stare insieme. I giovani, presunte monadi autosufficienti, non lottano piú fra di loro, e tristi spauriti e soli pagano ognuno la propria consumazione senza gioia. Cosa abbiamo fatto? O meglio, cosa hanno fatto i nostri educatori progressisti? Esattamente come per la legge Basaglia hanno azzerato le «feste» antiche invece di sostituirle in modo diverso, e questo non può che portare alla rovina.
Molto lavoro in casa, poi a mezzogiorno vado a fare una passeggiata a Serapo. La spiaggia è di una bellezza sconvolgente: sui muretti che fanno da limite fra la sabbia e l’asfalto della strada, i soliti gruppetti di ragazzi e ragazze, tutti in lutto stretto, stanno a combattere la noia, certo con qualche dolcezza dato il luogo ma nondimeno hanno un’aria cosí afflitta che inducono a pensare che oggi l’uomo – sia perché è un problema di fondo dell’essere umano, sia per millenaria cultura stratificata in ognuno di noi – o meglio i ragazzi non ce la fanno a godersi la pace senza l’assillo della guerra. Che anche la guerra sia un bisogno primario mi pare purtroppo un dato scontato, come l’amore-erotismo che non gode se tutto va troppo bene, ma arrivare a pensare che l’uomo senza guerra è infelice… Quello che è certo, questi ragazzi sembrano proprio degli orfani del grande padre guerra, pericolo, avventura, che non si sa perché ha loro voltato la faccia, costringendoli a una pace degli angeli che chiaramente non li soddisfa.
È incredibile con i guai che ho, ma da ieri sera sono quasi serena, e oggi mi accorgo del perché: è la vecchia storia del silenzio… Senza volerlo sono stata ventiquattro ore senza parlare con nessuno, e mi ha fatto bene. Ieri alle 18 sono andata al cinema, e la cassiera amica di Rosa è stata cosí contenta di vedermi dopo un mese d’assenza che alla mia domanda «dov’è Rosa» me l’ha indicata sulla porta in fondo, dove si passa per un largo corridoio carcerario e da una parte ci sono i bagni e dall’altra le varie entrate nella sala, dicendomi: «Vada, vada a salutarla, entri!» Al mio accenno imbarazzato, sorridendo nel suo bel faccione da bambina ha insistito: «E vada su!» Decisamente non voleva che pagassi! Eppure per quello che deve guadagnare lei, che ha due figli, io le dovevo sembrare elegante in pelliccia e colbacco… È un omaggio lo so, un omaggio partenopeo alla mia amicizia per Rosa di cui lei gode per le chiacchiere che facciamo insieme: è molto intelligente e ha un’appassionata fedeltà al cinema.
Rosa mi accoglie con un abbraccio virile, sta bene ed è felice di farmi entrare di soppiatto mentre lei è lí apposta per impedire che «gli altri» cerchino di infilare quella via per non pagare il biglietto. Chissà perché – certo non è per i soldi – ma questo trattamento mi dà un senso di approdo a casa che mi riempie di pace: è come se la grande famiglia dello spettacolo ancora mi accettasse come una di loro. Anche perché Rosa sa che sono tornata a recitare e sicuramente l’ha comunicato all’amica… Ma anche prima, quando persino tremila lire per me erano un lusso, avveniva lo stesso: allora non c’era la cassiera ma un incredibile tipo di manager dello spettacolo preindustriale, sempre a posto, grande parlatore e intenditore di «pellicole». Grosso come un armadio, ma con i piedi piatti, cosí che da lontano e visto da dietro sembrava un De Sica ingigantito da qualche maleficio partenopeo (pochi sanno che quell’andare incerto e affascinante del grande attore era dovuto a questo difetto, di cui Blasetti e compagni scherzavano in sua presenza!) Questo manager ante litteram aveva due particolarità molto graziose: una era quella di tingersi i capelli cosí male da dare ai suoi lineamenti, piuttosto belli, un che di marionetta diabolica e buffa nello stesso tempo; l’altra era che, oltre al suo amore sconfinato per lo spettacolo, amava con forza anche maggiore (parole sue) i libri, ma non aveva il tempo di leggere. Un pomeriggio, parlando con Angelo nell’atrio dell’Ariston prima di entrare per lo spettacolo delle sei, viene fuori il discorso sul Nome della rosa appena uscito e lui fa: «Oh, l’ho comprato subito, ma non per il clamore che questo libro ha suscitato, piuttosto perché compro sempre tutte le novità… vuole vedere?» Angelo, che non capisce cosa dovrebbe vedere, sussurra: «Cosa?», e lui: «I miei libri!», e si avvia, con noi dietro, nel suo ufficio. Lí, incredibile, pacchi e pacchi di libri stanno ammucchiati in attesa: ammucchiati in casse di cartone aperte da dove Sciascia, Bevilacqua e gli altri saltano fuori insieme all’ultimo arrivato di Eco, rosso fiammeggiante di gioia nelle belle mani lunghe da intellettuale del nostro, il quale nell’estrarlo ha un tremito di devozione nelle dita – il suo brillante incorniciato d’oro dà luci tremule di felicità. Stupiti non diciamo niente e lui: «Ecco, li compro e li metto qui, mia moglie non è d’accordo su questo tipo di spese, sa le donne, vorrebbero spendere tutto solo per i figli, ma io ho bisogno di questi, mi danno gioia e sono una garanzia per la mia vecchiaia…» «Vecchiaia?» chiede Angelo rispettoso. E lui: «E sí, cosí so che quando andrò in pensione avrò da leggere fino a che camperò, e finalmente mi metterò in pari con la cultura!»
Purtroppo questo delicato mastodontico manager (da quando lui non c’è, all’Ariston non si proiettano piú film di prima qualità) è morto prima di arrivare alla pensione… ma sono sicura che è morto tranquillo sapendo di avere casse e casse di libri interessanti da leggere là dove sarà!
Per me usare la chiave è un supplizio, chissà perché? In ogni caso, salendo le scale e aprendo la seconda porta (come se si fosse in un castello, tante sono le porte e le scale!) che immette nella camera con volte da moschea, noto il terzo cuscino – lasciato la mattina bianco di fodera – rilucente del suo giallo oro marrone di seta… Una fatina è entrata di soppiatto mentre ero fuori e ha dato l’ultimo tocco al mio divano. Vicino al cuscino un biglietto di Isa, con la spiegazione del piccolo miracolo: avendole io ieri sera dato la fodera riuscita troppo grande, lei in serata (quanto è difficile descrivere le cose piccole banali e quanto è facile scrivere cose sublimi o pseudotali!) l’ha «smacchinato» – parola inventata da lei, o da sua nonna – su una macchina da cucire del 1910 e poi stirato, e prima di partire per Roma me l’ha portato.
Ecco, in questo piccolo episodio c’è tutta Isa – figlia del grande laico socialista Bartolini Ezio, grande amico nei primi del Novecento di mia madre e mio padre – e tutta l’enorme tradizione che impregnava di eroismo sia le grandi idee che le piccole faccende spicciole della giornata, come saper cucinare, tagliare, cucire, ricamare. Ma non posso ora raccontare le avventure della mia amica, ci vorrebbe un romanzo: ora è tempo di divano orientale.
Alle 19 viene Ruggiero, insieme andiamo a cenare con una pizza e dopo suggerisco di andare nei paesi vicini, a vedere le luminarie che ogni anno arredano le piccole città dei dintorni. A Formia ci ritroviamo nel folto gruppo di ragazzi di tutte le età che non sapendo dove andare invade il marciapiede davanti alla villa comunale. Nel gelo, tutti in nero o quasi (quest’anno va lo scuro) con cappottoni anni Cinquanta, i piú battendo i piedi e sfregandosi le mani, questi ragazzi si radunano (come a Roma del resto) nell’unico spazio ancora concesso loro: non c’è un teatro dove recitare (il fascismo aveva pensato a questo) né una scuola statale di canto o altro luogo dove cantare insieme, né un biliardo o sala da gioco per gli scacchi (a questo anche se poveramente ci pensava la chiesa). E cosí, con queste asserzioni che non temo fare, protetta dal mio retaggio familiare di antifascismo provato, in due parole cerco di appuntare lo scandalo che dentro di me suscita sempre la visione di questi branchi di ragazzi che da veri e propri sbandati non sanno dove radunarsi la sera (non parlo del cinema perché sia a Formia che a Gaeta ne è rimasto uno solo, carissimo), e come possono sfogano il bisogno di vita chiacchierando fra loro. Per colmo l’unico ente – chiamiamolo cosí! – che se ne occupi è l’industria della moda: plagiandoli all’idea che ci si «realizza» nel look, giú a fare affari con gli stilisti, questi acuti indecenti inventori del falso modo «artistico» con cui sfogare il bisogno di crescere che quasi tutti i ragazzi hanno a quell’età. Anche sul piano etico-estetico siamo in mano al profitto; osservandoli mi sono fatta la convinzione che molti di loro approdano alla droga per pura noia: chi non sa che cosa terribile e annullante è la noia?! E non tutte le generazioni hanno il diversivo di un’occupazione tedesca, un Sessantotto, per non parlare del tempo della mia infanzia, che certo non lasciava un momento per annoiarsi.
Ruggiero scorge dei suoi allievi e veniamo accolti come salvatori: parlo coi ragazzi e accenno alla noia e, cosa che non mi sorprende, una caterva di approvazioni con esempi di loro amici e conoscenti spinti verso la droga mi cade intorno quasi allarmante. Pur essendo in un paese addormentato e pacifico c’è in questi ragazzi un’irritazione feroce contro tutti che mi turba. Per fortuna c’è Ruggiero, che con i suoi scherzi e barzellette ci riconduce al riso. Dopo un’ora di gelo finiamo in un locale, dove fra birra e salatini orrendi passiamo chiacchierando quasi tre ore. Sono tutti maschi, meno la sottoscritta e Francesca, un’allieva giovane anche se ritardataria a scuola; piú che bella ha una grossa personalità, cosa che mi sorprende, erano anni che non vedevo un viso cosí intenso e pieno di vita: due occhi bellissimi e una massa incredibile di capelli ricci quasi biondi di quel «quasi biondo» ora cenere ora rossiccio tipico di certe donne partenopee. Il corpo è di un’amazzone robusta, la voce franca e di una tonalità alta ma calda. Fra noi si stabilisce subito un’intesa briganteggiante… e sí: desiderio d’avventura o meglio un’avventura diversa da quella d’amore che purtroppo le ragazze continuano ancora a credere sia la sola a cui sono destinate per la vita. In questa c’è del ragazzaccio, come si diceva una volta, e mi stupisce un po’ essendo l’unica eccezione incontrata in questi quindici anni di mia frequentazione in questi luoghi. So che le differenze d’età non esistono, se non partono da noi stessi, ma nondimeno il suo entusiasmo per me, condiviso dai ragazzi – ma io mi occupo delle donne, o meglio sono le sole che posso capire e descrivere – per una volta mi stupisce: com’è possibile che piú invecchio e piú piaccio ai giovani? Oltretutto non faccio niente per piacere loro, anzi a volte sono severa di proposito perché proprio il vezzeggiarli mi appare, oggi, un gesto criminale tout court.
Maria Giudice: un amore sotto il fascismo.
Questa è l’idea che bimba avevo di mia madre.
E se il XX C...