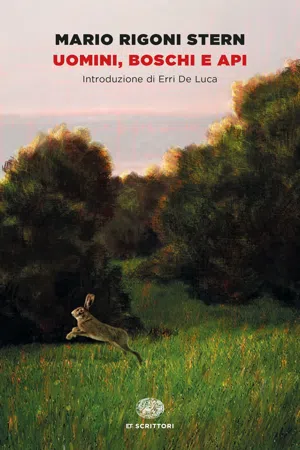Una domenica sul finire dell’inverno, come d’abitudine, ero sceso in piazza a far due chiacchiere con i paesani. La mattina era buona e la neve, ancora ben alta, appena accennava a mollare nelle ore piú calde del giorno. Me ne tornavo verso casa per il pranzo godendomi il sole quando, all’altezza della vecchia segheria, vidi sulla strada due chiazze vermiglie: proprio sulla carreggiata. Era sangue recente; ma attorno non v’erano segni di violenza: vetri rotti o tracce convulse di scarpe, niente; pareva che nessuno si fosse soffermato su quel sangue, d’altra parte in paese non avevo sentito voci in proposito.
Mi chinai ad osservare e, dalla neve rossa, raccolsi un ciuffo di pelo: era stato un lepre l’investito.
Guardando lontano vedevo la traccia che veniva dal margine del bosco, attraversava diritta per campi e prati tutti bianchi, saliva il cumulo fatto dallo spazzaneve. Da qui era saltato in strada nel momento che una macchina giungeva veloce. Povera bestia, pensavo, anche loro pagano la loro parte alla motorizzazione; certo che una volta una slitta tirata da un cavallo non l’avrebbe investito.
Dopo essermi spiegata la ragione di quel sangue fui per riprendere la via ma, guardando dall’altro lato della strada, per i prati dove il lepre avrebbe dovuto continuare la sua corsa, vidi dei segni strani e profondi, irregolari e segnati di rosso: erano ancora dello sfortunato lepre che si era allontanato tenendo la vita coi denti fino all’argine della sorgente: «Sarà andato a morire là dietro», mi dissi. E ripresi il cammino.
Arrivai a casa sulla scia del profumo della polenta domenicale e quando raccontai dell’investimento del lepre mi sentii scherzosamente rimproverare perché non ero andato a raccoglierlo.
– Bene, – dissi, – sono ancora in tempo per farlo. Dopo bevuto il caffè vado a prenderlo.
Dal luogo dove era avvenuto l’incidente guardavo ora la traccia con il binocolo: si fermava dove il rivo piegava dentro la valletta. Scavalcai il muro di neve al lato della strada e, sprofondando fino a mezza gamba, mi avviai lungo i suoi segni.
Doveva essere stato colpito alla testa o sul muso perché la macchia rossa era sempre accostata alle zampe anteriori, infossata nella neve come avesse ripiegato il capo dopo ogni passo.
Sulla riva ghiacciata non lo trovai; si era fermato lí come per riprendere forza perché c’era un covo tutto arrossato, e dopo aveva ripreso a camminare. «Con tutto il sangue che ha perso, – pensai, – non dovrebbe essere lontano».
Discesi lungo il ghiaccio del rivo; nella valletta la traccia riprendeva a salire verso un dosso dove una cappellina ricorda la peste del 1631 e una strada porta a una contrada fuori mano; ma non si era fermato dietro la cappellina, né dietro i cumoli di neve: aveva proseguito fino a delle villette disabitate, vicino al laghetto. Osservando, sempre con il binocolo, vedevo le tracce che si fermavano vicino a una catasta di legna.
Il sole ora scaldava, sudavo sprofondando nella neve a ogni passo. Quando giunsi vicino alle villette stagionali ripresi fiato e mi guardai attorno per non essere preso per un malintenzionato. Io già mi figuravo il lepre irrigidito in qualche angolo nascosto dove si era rifugiato a morire in pace. Povera bestia, ne aveva fatta di strada in quelle condizioni! Girai attorno alle abitazioni chiuse, guardai dentro i recinti, sotto i poggioli, nelle entrate delle rimesse: niente. Il lepre non c’era.
Sul pascolo lontano vidi dei corvi in fila; camminavano lentamente e ogni tanto affondavano il becco nella neve: «Ci siamo, – mi dissi, – è lí».
Difatti, dopo mezzo chilometro che aveva camminato sulla strada delle villette aveva ripreso per la neve vergine. I corvi l’avevano seguito; forse l’avevano scorto nel loro primo volo del mattino, o sentito il suo sangue. Già, i corvi se vedono un leprotto ci dànno addosso fino a dilaniarlo: gridano l’allarme e si radunano in tanti, e a volte uccidono. Un giorno raccolsi due starne e un giovane gufo lacerati dai loro becchi, e l’autunno scorso vidi un’aquila assalita da una nuvola di corvi dover fuggire oltre la cresta di un monte.
Accelerai il passo e davanti a me i corvi si levavano indispettiti, gracchiando. Camminai per altri due chilometri alzando corvi; il lepre aveva a gran fatica valicato una collina e attraversato la statale per Trento; era poi sceso nello stagno dei beccaccini dove ora solamente i falaschi ghiacciati uscivano dalla neve, era poi risalito ancora verso il cimitero di un villaggio.
Anch’io ero ormai spossato, e pure i suoi segni diventavano sempre piú faticati: in certi tratti camminava con tre gambe, in cert’altri si trascinava: si vedeva bene; dove si era fermato a riprendere fiato il sangue lasciato sulla neve non era piú vermiglio ma rosa e schiumoso. E allora supposi che avesse preso una botta interna e che questo sangue gli venisse dai polmoni. Sulle strade lontane sentivo il continuo brusio delle macchine degli sciatori domenicali, vedevo anche la gente formicolante sulle piste e attorno agli impianti di risalita; ma era un altro mondo, assolutamente estraneo, la mia attenzione era solamente sui segni lasciati dal lepre che voleva vivere, e quando vidi sette corvi attorno a una macchia scura rimpiansi la carabina che era a casa nella rastrelliera.
No! Non era il lepre quella macchia scura, erano solamente escrementi, sangue e pelo. I corvi non erano riusciti a prenderlo: – Forza! – gli dicevo, – che piú avanti vi è una valle boscosa e profonda e lí sei in salvo.
Aveva ancora proseguito, quel demonio, anzi: si era trascinato. Si vedeva bene. Dietro a delle lastre di pietra si era ancora riposato, ma sotto un fienile non aveva cercato rifugio: forse avrà intuito che lí poteva essere facilmente preso dalla volpe che la notte precedente aveva lasciato le sue impronte.
A ridosso del cimitero del villaggio vi è un rimboschimento di abeti e attorno, su tre lati, una fila di maggiociondoli. I maggiociondoli erano tutti rosicchiati e quello che affiorava dalla neve erano stecchi nudi senza piú gemme e corteccia: i lepri li avevano ripuliti in quel modo per la fame, attorno era tutto calpestato dalle loro zampe e la neve letteralmente coperta di escrementi.
La traccia sanguinosa mi fece fare un lungo giro per dossi e conche di prati dove la neve era farinosa e secca a causa della corrente fredda che viene giú dalle alte montagne a nord; ma era anche diventata difficile da seguire e sembrava vecchia di giorni e non fresca di ore perché il vento leggero aveva mosso la neve e confusa con altri segni, al punto che per sapere se fosse proprio di lui con le mani scostavo la neve per accertarmi del rosso nascosto sotto.
Proseguendo lentamente in questo modo giunsi nuovamente alla piantagione dietro il cimitero. Gli abeti erano molto fitti e i loro rami, a causa della neve scivolata giú durante tutto l’inverno, erano all’altezza del mio corpo. Il camminare lí dentro diventava come affrontare una giungla gelata.
Strisciai sotto graffiandomi il viso e le mani, impiastricciandomi di resina; la neve mi penetrava per il collo tra camicia e pelle e per le maniche facendomi rabbrividire nel contrasto con il sudore.
Ritrovai la traccia del sangue acquoso, la seguii con fatica e, finalmente, tra rami di ghiaccio e grumi di neve vidi lui che mi fissava immobile. Con gli occhi grandi e pietosi, le orecchie abbassate lungo il collo. Dalla bocca gli usciva una schiuma rossa.
Dopo un po’ allungai la mano per sfiorarlo come per dirgli bravo. Era dolce il contatto dei miei polpastrelli con il suo pelo folto e liscio, ma lui fece uno scatto come se fosse stato colpito da una scarica elettrica e corse via.
Quando riuscii a liberarmi da quel fitto gelato lo vidi che ancora correva sicuro verso la valle profonda, dove non ci sono strade ma poca neve ripari e pasture: – Vai! – gli gridai. – Vai e tienti lontano dalle automobili, e nell’autunno prossimo sono certo che farai ammattire i cani dei segugisti.
Come ogni mattina la squadra dei boscaioli era partita prima di giorno; il paese dormiva e solo quando giunsero in alto, lungo la costa del monte, sentirono suonare le campane dell’alba.
Deposti i sacchi incominciarono il lavoro. Ogni abete da tagliare era segnato al piede da un numero impresso dal martello della Forestale: secondo il piano economico del Comune in quella particella di bosco, e per quell’anno, si potevano ricavare trecento metri cubi di legname e, ovviamente, erano state scelte le piante mature che già avevano compiuto il loro ciclo di sviluppo.
La sega a motore rompeva il silenzio del bosco e quando si fermava, dopo due colpi dati con il dorso della scure sul cuneo infisso nel taglio, sentivi il fracasso della ramaglia dell’abete che schiantava. Cosí per ore; fino a mezza mattina quando c’era la sosta per la merenda.
In quella pausa si sentivano ritornare i soliti rumori del bosco: la famiglia delle cince, gli scoiattoli che giocavano sui rami, il ronzio degli insetti, il richiamo dei caprioli.
Da certi segni si può anche determinare l’ora del giorno, e il tempo. Per questo, quando sentirono il caprimulgo cantare fuori orario uno disse: – Il lattacapre chiama l’acqua. Oggi verrà il temporale.
Ripresero il lavoro con lena e continuarono fino a mezzogiorno, per il riposo piú lungo. In uno spiazzo accesero il fuoco e quando le pietre attorno furono arroventate ci misero sopra ad abbrustolire grosse fette di polenta; sui rami a forcella arrostirono la sopressa e il formaggio, e, intanto, nelle gavette affumicate si riscaldava il minestrone.
A mangiare si ritirarono nell’ombra, dentro il bosco; e restava ancora nell’aria l’odore della polenta misto a quello del salame e della resina trasudata dagli abeti scortecciati e tagliati a tronchi di quattro metri. Dopo, con le schiene appoggiate ai tronchi, fumarono in silenzio, chi pipa chi sigaretta di trinciato, e due, i piú giovani, si addormentarono con la testa sulla giacca piegata a cuscino e il corpo su una bracciata di rami.
Poco lontano si udiva lo scalpicciare di un capriolo e, da oltre la valle, il brontolare del tempo: – Viene il temporale, – disse uno dei due che fumava guardando il cielo, – e se non svampisce per strada, in una mezz’ora è qui.
Ascoltavano il capriolo, il temporale lontano, il respiro dei compagni che dormivano; improvvise caddero delle gocce che c’era ancora il sole e un tuono secco svegliò i due che dormivano: – Ve lo dicevo che il lattacapre non canta di giorno!… Qui ci conviene cercare un albero fitto che tenga fuori l’acqua.
Si guardarono attorno e decisero per un abete non grosso ma con i rami fitti e sottili e che non attirava le saette – i fulmini, sempre, colpiscono gli abeti bianchi o i larici. Se l’acqua non fosse venuta d’impeto, lí sotto potevano stare all’asciutto per almeno un’ora. Raccolsero i ferri e si acquattarono.
L’acqua scrosciava tra i rami e lampi e tuoni rompevano il cielo; moscerini quasi invisibili entravano nella pelle sudata e salata dei quattro come pungiglioni di vespe, ma piú acuti ancora.
– Sarebbe meglio coprire la motosega, sennò faticheremo a farla ripartire. L’ultima pianta che ha scortecciato Nardi mi sembra abbia dei bei pezzi di scorza, – disse il piú anziano dei quattro.
– Ci vado io a prenderla, quella scorza, – rispose il piú giovane. E corse fuori nel diluvio con la giacca tirata sopra la testa.
Raggiunse l’abete che sotto l’acqua si lavava tutto nudo, raccolse in fretta due larghi pezzi di corteccia e fece per ritornare dai compagni che lo seguirono con lo sguardo. Ma a mezza strada lo videro fermarsi dentro uno slargo di felci che si piegavano sotto la pioggia e poi riprendere la corsa gridando qualcosa che non riuscivano a capire per il frastuono dell’acqua e dei tuoni.
Quando arrivò posò le cortecce sopra la motosega e senza cercare riparo per sé gridò verso i compagni che ora lo potevano sentire:
– Venite! Venite a vedere: lí in quello spiazzo c’è un capriolo appena nato. Venite ad aiutarmi!
Uscirono nel temporale anche gli altri tre e lo seguirono di corsa. Quando giunsero nella radura videro tra le felci l’animaletto quasi senza vita, battuto dall’acqua che gli faceva colare sopra fili d’erba, aghi d’abete e petali rossi di fiori: aveva gli occhi spalancati e certo non si rendeva conto che il mondo dove era venuto alla luce da pochi minuti non era fatto solamente di temporali.
Un boscaiolo si chinò a raccoglierlo e portarlo all’asciutto, ma quello che l’aveva scorto per primo lo fermò: – Non toccarlo! – gli urlò tra lo scroscio, – se sente il tuo odore la madre lo abbandona. Non lo riconosce piú!
Incominciò a grandinare e i grani battevano giú dagli alberi strobili e rametti; il boscaiolo cacciatore si levò la giacca e la tenne stesa sopra il capriolo: – Andate a prendere delle scorze e dei rami, – disse ai compagni, – dobbiamo fargli un ricovero sennò la tempesta lo ammazza.
– Ma dove sarà andata la madre? E come ha pensato di partorirlo qui vicino a noi? – chiese uno.
– Avrà cercato aiuto. Gli animali capiscono certe cose… Adesso sarà spaventata dalle saette e magari è poco lontana, – riprese il piú anziano dei quattro.
Ormai erano bagnati fin dentro le scarpe e fin sotto la maglia di lana; con lena pulirono e spuntarono quattro grossi rami; con la testa della scure li ficcarono nel terreno attorno al capriolo e poi con attenzione e a regola d’arte, in modo che non gocciolassero sotto, posarono le cortecce a fare tetto. La piccola bestiola lasciava fare, solo sentiva che ora l’acqua e la grandine non la battevano piú: quei lampi improvvisi seguiti dal gran fragore del tuono che rimbombava nel bosco, ecco, la spaventavano un po’.
I quattro si ritirarono dove avevano lasciato gli attrezzi da lavoro. Ormai era uguale stare sotto gli alberi che fuori, tanto si erano inzuppati: si misero in piedi con la schiena contro un grosso tronco; ma anche il tabacco e i fiammiferi si erano inumiditi dentro le scatole di latta e faticarono ad accendere. Non parlavano, guardavano il bosco fra l’acqua come un fondo marino e ascoltavano il temporale. Dopo un bel poco uno disse: – Mah… –. E dopo un silenzio ancora piú lungo: – Mah. Non capisco. E tu sei anche cacciatore.
– Si sente, non si capisce, – rispose il cacciatore.
Continuarono a fumare: – E magari tra quattro anni lo ritrovi con il tuo cane e ci spari, – disse un altro.
– Mah. È la vita.
Continuava a piovere e a tuonare, fumavano in silenzio e tutti quattro pensavano al piccolo capriolo sotto il riparo che avevano fatto: – Chissà se la madre lo ritroverà; e se vivrà dopo un parto tra questa intemperia, – disse uno come a conclusione di un pensiero.
– Sono forti, loro, sono madri… – lo tranquillizzò il piú anziano.
Ora le saette erano cessate ma continuava a piovere; il temporale si era spostato verso l’altra valle ma non si vedevano sprazzi di azzurro: – Qui, ormai, ci conviene raccogliere sú e andare a casa. Bagnati siamo bagnati e riprendere il lavoro non conviene. Cosa dite?
– Aspettiamo ancora dieci minuti, la pioggia va calando.
Con gli zaini in spalla si avviarono verso il sentiero, ma prima si avvicinarono cauti al ricovero del capriolo. Il cacciatore alzò con precauzione una falda di corteccia e guardò sotto: il caprioletto era tutto rannicchiato, tremava per il freddo ma sembrava tranquillo; anzi, stava asciugandosi perché il pelo fumava: – Forse ce la farà, – disse ai compagni, – ma bisognerebbe che la madre lo ritrovasse.
Quando arrivarono in paese smise di piovere e lontano, verso il lago da dove il temporale era venuto, apparve una striscia di azzurro: – Ci vediamo dopo cena all’osteria, – disse uno, – adesso andiamo ad asciugarci.
In un angolo la televisione trasmetteva un telefilm che nessuno guardava; i quattro si giocavano un litro a scopa. Venne dentro il guardacaccia, salutò e dopo, senza parlare, si avvicinò ai quattro delle carte. Dopo la giocata disse: – Ho sentito che avete trovato un capriolo appena nato. Come è stata?
Gli raccontarono come e dopo lui ordinò un altro mezzo litro: – Domani mattina, – disse il guardacaccia, – verrei anch’io con voi a vedere. A che ora partite? E se la vecchia lo ha abbandonato ed è ancora vivo lo porterò giú, qui a casa mia. Non è il primo che allevo con il ciuccetto e latte di capra…
La mattina venne limpidissima che potevi contare gli alberi sulle creste dei monti lontani. Il guardacaccia salí con i quattro boscaioli e quando giunsero nei pressi dell’abbattuta andarono insieme al ricovero del capriolo. Con attenzione levarono le cortecce messe a tetto sopra i rami, ma sotto, il capriolo non c’era piú.
– Sarà venuta la madre a prenderselo, – disse il cacciatore. – Senti, il covo è ancora tiepido, – aggiunse tastando con una mano le felci schiacciate.
Stettero un poco in silenzio, e a monte, sulla costa del bosco, sentirono un breve scalpiccio e frusciare di rami. Poi belare.
– Sono loro, – disse il guardacaccia. – È venuta a prenderselo: ce l’hanno fatta.
2323__perlego__chapter_d...