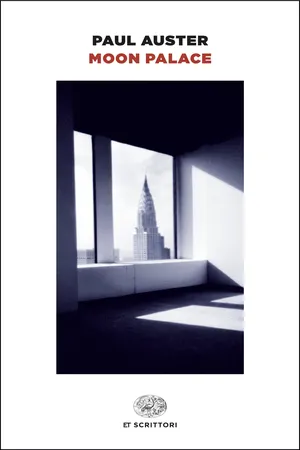![]()
Quel giorno ci fermammo lí. Non appena ebbe pronunciato l’ultima frase, Effing fece una pausa per riprendere fiato, ma prima che riuscisse a riattaccare il suo racconto arrivò la signora Hume ad annunciare che era ora di andare a tavola. Dopo le terribili cose che aveva raccontato, pensavo che gli sarebbe stato difficile recuperare la freddezza, invece l’interruzione non parve turbarlo affatto. – Bene, – disse, battendo le mani. – È ora di mangiare. Muoio di fame –. Ancora una volta rimasi meravigliato dalla rapidità con cui riusciva a passare da uno stato d’animo a un altro. Soltanto qualche istante prima aveva la voce rotta dall’emozione. Avevo addirittura temuto che rischiasse un collasso, e invece di punto in bianco eccolo lí traboccante entusiasmo e buonumore. – Adesso veniamo al punto, ragazzo, – disse, mentre lo spingevo con la carrozzina nella sala da pranzo. – Questo non era che l’inizio, quella che si potrebbe definire una prefazione. Aspetta che mi sia scaldato. Non hai ancora sentito niente.
Una volta seduti a tavola, però, non si accennò piú all’elogio funebre. Il pranzo procedette secondo la norma, con il solito accompagnamento di schiocchi e schifezze, né piú né meno di ogni altro giorno. Sembrava quasi che Effing si fosse già dimenticato ciò che mi aveva sviscerato davanti nelle tre ore appena trascorse. Facemmo le nostre solite chiacchiere su argomenti banali, e poi verso la fine del pasto ci occupammo delle previsioni meteorologiche per la giornata in vista del nostro giro pomeridiano. Alla stessa maniera procedettero le cose per le tre o quattro settimane successive. Al mattino lavoravamo all’elogio funebre, il pomeriggio uscivamo a fare le nostre passeggiate. Con i racconti di Effing riempii piú di una dozzina di quaderni, al ritmo di circa venti, trenta pagine al giorno. Per tenergli dietro dovevo scrivere molto in fretta, al punto che a volte le mie trascrizioni risultavano illeggibili. A un certo punto gli chiesi pertanto se non potevamo usare un registratore, ma non volle neanche sentirne parlare. Niente elettricità, replicò, né macchine. – Il rumore di questi infernali oggetti non lo tollero. Tutto un bzzz vrrr, roba da far stare male. L’unico rumore che voglio sentire è quello della tua penna che scorre sulla carta –. Gli spiegai che non ero un segretario professionista. – Non conosco la stenografia, – aggiunsi, – per cui non mi è sempre facile rileggere quello che ho scritto. – E allora tu battilo a macchina quando io non ci sono, – replicò. – Ti darò quella di Pavel. Un bel ferrovecchio che gli ho comperato quando siamo arrivati in America, nel ’39. Una Underwood. Adesso non le fanno piú. Deve pesare tre tonnellate e mezzo –. Quella stessa sera, riesumata la macchina da scrivere dal fondo dell’armadio a muro in camera mia, la sistemai su un tavolinetto, dopodiché passai diverse ore ogni sera a trascrivere le pagine prodotte dalle nostre sessioni mattutine. Un lavoro noioso, ma cosí almeno le parole di Effing le avevo ancora fresche nella memoria, e non ne andavano perse molte.
Dopo la morte di Byrne, continuò a raccontare, aveva perso ogni speranza. Procedette a qualche timido tentativo di districarsi dal canyon, ma si trovò ben presto perduto in un labirinto di ostacoli: dirupi, gole, scarpate inaffrontabili. Il cavallo crollò il secondo giorno, ma, non disponendo di legna da ardere, la carne macellata risultò praticamente inutile. L’artemisia non bruciava. Faceva fumo e scoppiettava, ma non produceva fuoco. Per placare la fame lui tagliò alcune fette di carne dalla carcassa, procedendo ad abbrustolirle con i fiammiferi. Quanto bastava per un pasto, ma una volta finiti i fiammiferi piantò l’animale dov’era, non avendo nessuna voglia di mangiarne la carne cruda. Era ormai convinto di essere arrivato alla fine dei suoi giorni. Continuò comunque a vagare a casaccio tra le rocce, tirandosi dietro l’ultimo asino sopravvissuto, tormentato a ogni passo dal pensiero che forse si stava allontanando sempre piú dalla possibilità di venire ritrovato. I suoi materiali d’arte erano tuttora intatti e disponeva ancora di cibo e acqua sufficienti per un paio di giorni. Ma sembrava non importargliene piú nulla. Anche se fosse riuscito a sopravvivere, si rendeva conto che la sua vita era finita. Effetto della morte di Byrne: impossibile trovare il coraggio di tornare a casa. La vergogna sarebbe stata troppa: le domande, le recriminazioni, la perdita della faccia. Pensassero pure che fosse morto, perché almeno in quel caso il suo onore sarebbe stato salvo e nessuno avrebbe scoperto quanto fosse stato debole e irresponsabile. Fu a quel punto che Julian Barber scomparve: lo fece sparire lí, in mezzo al deserto, tra le rocce e in una luce accecante. Sul momento non gli era parsa una decisione tanto drastica. Non c’era dubbio che stesse per morire sul serio, dunque non sarebbe cambiato niente in ogni caso. Nessuno avrebbe mai avuto la minima idea di che cosa ne fosse stato di lui.
Effing mi aveva detto di essere impazzito, ma non ero sicuro circa il senso preciso dell’espressione. Dopo la morte di Byrne, disse, aveva continuato a urlare per tre giorni quasi senza interruzione, spalmandosi sul viso il sangue che gli colava dalle mani escoriate dalle rocce. Comportamento che in ogni caso, date le circostanze, non mi parve insolito. Io stesso avevo berciato non poco durante il temporale in Central Park, in una situazione di gran lunga meno disperata della sua. Quando si pensa di avere tirato la fune della vita al limite estremo, è perfettamente naturale che venga voglia di mettersi a gridare. L’aria si accumula nei polmoni al punto che diventa impossibile respirare senza espellerla, e bisogna farlo urlando a tutta forza. Altrimenti si asfissia, si viene soffocati dal cielo stesso.
Il mattino del quarto giorno, finite le provviste di cibo e avendo non piú di una tazza d’acqua nella borraccia, Effing avvistò quella che sembrava una grotta in cima a una vicina rupe. Un bel posto per morire, pensò. Al riparo dal sole e fuori portata dagli avvoltoi, talmente recondito che nessuno lo avrebbe mai piú trovato. Fattosi coraggio, attaccò l’ardua scalata. Per raggiungere la meta gli ci vollero quasi due ore e quando vi fu finalmente arrivato era allo stremo delle forze, incapace di reggersi in piedi. La grotta risultò parecchio piú vasta di quanto sembrasse dal basso, tanto che ebbe la sorpresa di scoprire che non gli toccava chinarsi per entrarci. Quindi, liberata l’apertura dai rami e dagli arboscelli che la ostruivano, entrò. Contro ogni aspettativa, però, non era affatto vuota. Estesa un buon sei metri nell’interno della rupe, conteneva alcuni mobili: tavolo, quattro sedie, credenza, cadente stufa panciuta. Una vera e propria abitazione. Gli oggetti apparivano ben curati, e ogni cosa nel locale era sistemata con riguardo, in un ordine quasi domestico. Accesa la candela che c’era sul tavolo, Effing se la portò dietro nella parte piú arretrata del locale, esplorando gli angoli bui, dove la luce del sole non arrivava. Lungo la parete di sinistra trovò un letto, con sopra un uomo. Sulle prime pensò che fosse addormentato, ma poi, dopo essersi raschiata la gola per annunciare la propria presenza senza ricevere alcuna risposta, si chinò, accostando la candela al volto dello sconosciuto. Cosí si accorse che era morto. Assassinato, per la precisione. Al posto dell’occhio destro c’era un grosso foro di proiettile. Quello sinistro invece era fisso nel buio, mentre il cuscino sotto la testa appariva lordo di sangue.
Allontanatosi dal cadavere, Effing tornò alla credenza, che trovò piena di cibo. Scatolame, carni salate, farina e arnesi da cucina: sui diversi ripiani c’erano provviste sufficienti per un anno. Si preparò pertanto immediatamente qualcosa da mangiare, spazzando una mezza forma di pane e due scatole di fagioli. Dopo di che, una volta placata la fame, si dedicò all’impresa di eliminare il cadavere. Aveva già elaborato un piano, si trattava semplicemente di metterlo in atto. Doveva trattarsi di un eremita, pensò, che viveva da solo lassú tra i monti. E se le cose stavano cosí, non dovevano essere molte le persone al corrente della sua esistenza. Da quanto gli era dato dedurre (la carne ancora non decomposta, l’assenza di odori forti, il pane non ancora raffermo), l’omicidio doveva essere stato compiuto assai di recente, forse non piú di qualche ora prima, e dunque l’unico a conoscere l’identità dell’assassino doveva essere l’assassino stesso. Non c’era pertanto nulla, pensò ancora, che gli impedisse di prendere il posto dell’eremita. Erano piú o meno della stessa età e della stessa taglia, avevano gli stessi capelli color bruno chiaro. Lasciarsi crescere la barba e mettersi gli indumenti del morto non avrebbe rappresentato un gran problema. Avrebbe fatto propria la vita dell’eremita, continuando a vivere per suo conto, comportandosi come se si fosse impossessato della sua anima. Se mai fosse venuto qualcuno in visita, avrebbe semplicemente finto di essere un altro, verificando se era in grado di farla franca. Per difendersi, in caso qualcosa fosse andato storto, disponeva di un fucile, anche se riteneva di avere la sorte dalla sua, non essendo probabile che da un eremita venissero molti visitatori.
Spogliato lo sconosciuto, trascinò il cadavere fuori dalla grotta, portandolo al versante opposto della rupe, dove, una decina di metri sotto il livello della grotta, scoprí la cosa piú notevole, ovvero una piccola oasi, una zona fertile con due immensi pioppi, un ruscello con tanto di acqua e innumerevoli pianticelle il cui nome non gli era noto. Una sacca di vita in miniatura nel cuore del deserto totale. Mentre seppelliva l’eremita nel terreno morbido accanto al ruscelletto, si rese conto che in quel posto gli sarebbe stato possibile tutto. Disponeva di cibo e di acqua, aveva una casa, si era ritrovato una nuova identità, una vita nuova e del tutto inattesa. Un rovesciamento di fronte persino al di là del credibile. Soltanto un’ora prima era pronto a morire, ed eccolo invece lí tremante di felicità, incapace di trattenersi dal ridere mentre gettava una badilata di terra dopo l’altra sul viso del morto.
Passarono i mesi. Sulle prime Effing era troppo confuso dal colpo di fortuna capitatogli per occuparsi dell’ambiente circostante. Mangiava, dormiva, e, se il sole non era troppo forte, si sedeva sulle rocce fuori dalla grotta a guardare le lucertole dai molteplici e vivaci colori che gli schizzavano tra i piedi. Il panorama dalla rupe era grandioso, esteso per un’incalcolabile quantità di miglia, ma lui non lo guardava molto di frequente, preferendo restringere i propri pensieri alle immediate vicinanze: i viaggi al ruscello con il secchio per l’acqua, la raccolta della legna da ardere, l’interno della grotta. Di panorami ne aveva abbastanza, quello lí preferiva ignorarlo. Finché di punto in bianco il suddetto senso di pace lo abbandonò, e di conseguenza si trovò ad affrontare un periodo di solitudine quasi intollerabile. Si sentí sconvolgere dall’orrore dei mesi passati, al punto che nel corso del successivo paio di settimane arrivò pericolosamente vicino a uccidersi. La mente gli brulicava di fissazioni e paure, piú di una volta arrivò addirittura a pensare di essere morto nel momento stesso in cui era entrato nella grotta, e di trovarsi quindi prigioniero di un aldilà infernale. Un giorno, in preda a una crisi di follia, dato di piglio al fucile dell’eremita sparò all’asino, sembrandogli che si fosse trasformato nell’eremita stesso, spettro furente tornato a ossessionarlo con i suoi ragli fasulli. Quell’animale sapeva la verità, era testimone del suo falso, e di conseguenza non gli rimaneva che eliminarlo. Successivamente fu preso dall’ossessione di scoprire l’identità del morto, per cui si mise a frugare sistematicamente tutto l’interno della grotta in cerca di un qualsivoglia indizio, un diario, un pacchetto di lettere, il risvolto di un libro, qualsiasi cosa potesse rivelargli il nome dell’eremita. Ma non saltò fuori nulla, neanche un briciolo di notizia.
Dopo due settimane, infine, cominciò lentamente a tornare in sé, recuperando finalmente uno stato prossimo alla pace mentale. Non posso continuare cosí all’infinito, si disse, e tanto bastò a dargli conforto, insieme al coraggio di tirare avanti. A un certo punto le provviste alimentari si sarebbero esaurite, dopo di che gli sarebbe toccato andare da qualche altra parte. Si concesse approssimativamente un anno, un po’ di piú se avesse fatto attenzione. A quel punto la gente avrebbe rinunciato a ogni speranza che lui e Byrne tornassero a comparire. Dubitava che Scoresby avesse mai spedito la sua lettera, ma anche in caso contrario i risultati sarebbero fondamentalmente stati gli stessi. Sarebbe stata organizzata una spedizione di ricerca, finanziata da Elizabeth e dal padre di Byrne, i cui componenti avrebbero vagato per il deserto alcune settimane, procedendo a un’accurata ricerca degli scomparsi – sarebbe sicuramente stato offerto anche un premio –, senza tuttavia mai trovare alcunché. Avrebbero al massimo potuto scoprire la tomba di Byrne, ma anche questa eventualità appariva piuttosto improbabile. E seppure ciò fosse avvenuto, non sarebbe in alcun modo servito a portarli piú vicino a lui. Julian Barber non esisteva piú e nessuno lo avrebbe mai rintracciato. Era soltanto questione di tenere duro finché avessero smesso di cercarlo. I giornali di New York avrebbero pubblicato i loro elogi funebri, si sarebbe tenuta una funzione, e chi si è visto si è visto. Una volta conclusosi tutto ciò, avrebbe potuto andarsene dove preferiva, diventare chi piú gli piacesse.
Sapeva però che non era il caso di precipitare le cose. Piú si fosse tenuto nascosto, meno rischi avrebbe corso al momento di andarsene. Si accinse pertanto a organizzare la propria vita nel modo piú rigoroso possibile, facendo quanto poteva per allungare il periodo di tempo da passare lí, e quindi limitandosi a un pasto al giorno, raccogliendo una larga provvista di legna da ardere per l’inverno e mantenendosi in forma. Preparò schede e programmi, in base a cui ogni sera, prima di andare a letto, redigeva meticolosi rendiconti delle riserve consumate in giornata, imponendosi la disciplina piú rigida. Sulle prime gli era parso difficile raggiungere le mete che si era imposto, e di conseguenza aveva spesso ceduto alla tentazione di una fetta di pane e di un piatto di carne in scatola in piú, ma lo sforzo appariva valido in sé, poiché lo aiutava a stare all’erta. In tal modo poteva mettere alla prova la propria debolezza, tanto che, quando a poco a poco i limiti tra reale e immaginario cominciarono a farsi confusi, non poté fare a meno di considerarlo un trionfo personale. Sapeva che tutto ciò non era nulla piú di un gioco, ma un gioco per praticare il quale occorreva tuttavia una devozione fanatica: era proprio la straordinaria concentrazione a impedirgli di cedere allo scoraggiamento.
Dopo due o tre settimane di simile nuova vita e disciplina, gli tornò la voglia di dipingere. Una sera, mentre era seduto con la matita in mano, intento a scrivere la breve relazione circa le attività della giornata, sulla pagina opposta cominciò di punto in bianco ad abbozzare lo schizzo di una scena montana. Prima ancora di essersi reso conto di quel che stava facendo, già aveva finito. Non ci aveva messo piú di mezzo minuto, ma in quell’improvviso atto inconscio colse una forza mai prima di allora comparsa in nessuna sua opera. La sera stessa sballò i materiali d’arte, dopo di che continuò a dipingere finché i colori non furono finiti, lasciando la grotta ogni mattino all’alba e passando tutta la giornata fuori. Questo durò due mesi e mezzo, il tempo di realizzare una quarantina di tele. Senza ombra di dubbio, mi disse, il periodo piú felice della sua vita.
Lavorava sotto la spinta di una doppia coazione, che si combinava ad aiutarlo in diversa maniera. Anzitutto veniva la considerazione che questi suoi dipinti non li avrebbe mai visti nessuno. Un fatto scontato, ma che invece di tormentarlo con un senso di vanità pareva invece liberarlo. Lavorava per se stesso, senza piú doversi porre il problema del giudizio altrui, condizione che si rivelò sufficiente a produrre un cambiamento fondamentale nel suo modo di accostarsi all’arte. Per la prima volta in vita sua smise di preoccuparsi dei risultati, con la conseguenza che espressioni come «successo» e «insuccesso» persero improvvisamente ogni significato. Scoprí che la vera finalità dell’arte non è creare oggetti belli. Essa è piuttosto una tecnica conoscitiva, un modo per indagare piú a fondo la realtà fino a individuarvi il proprio ruolo: quali che siano i valori artistici di una singola tela, essi costituiscono quasi un sottoprodotto casuale dell’impegno nello sforzo di arrivare al cuore delle cose. Si impose quindi di dimenticare le regole imparate, utilizzando il paesaggio stesso come un proprio pari, abbandonandosi volontariamente ai capricci del caso, della spontaneità, dei particolari in sé. Come conseguenza, non ebbe piú paura del vuoto che lo circondava. L’impegno a metterlo sulla tela glielo aveva in qualche modo fatto soggettivare: ora era in grado di avvertirne l’impassibilità come un qualcosa di proprio, alla stessa stregua in cui lui stesso era ormai integrato nella silente poderosità di quegli spazi titanici. I dipinti che produsse, spiegò, erano rozzi, ricchi di un cromatismo violento e singolare, di non programmati soprassalti di energia, un turbine di forme e luce. Non sapeva minimamente se fossero brutti o belli, ma ciò non aveva probabilmente alcuna importanza. Erano suoi e non assomigliavano a nessun altro quadro che avesse visto. Cinquant’anni dopo, disse, se li ricordava ancora a uno a uno.
La seconda coazione era piú sottile, eppure esercitava su di lui un’influenza ancora piú forte, riassumendosi nel concetto che alla fine i materiali di cui disponeva si sarebbero esauriti. Il numero dei tubetti di colore e delle tele di cui disponeva non era illimitato: se voleva continuare a lavorare, doveva consumarli. L’esito finale l’aveva pertanto avuto presente fin dall’inizio. Già mentre dipingeva quei quadri era come se sentisse il paesaggio svanire davanti agli occhi. Sensazione che conferí una pregnanza particolare a tutta l’attività di quei mesi. Ogni volta che completava una nuova tela, infatti, la dimensione del futuro si riduceva, portandolo con graduale regolarità piú vicino al momento in cui esso si sarebbe esaurito. Dopo un mese e mezzo di lavoro ininterrotto, arrivò finalmente all’ultima tela. Tuttavia gli rimanevano ancora piú di una dozzina di tubetti di colore. Pertanto, senza assolutamente rompere il ritmo, rivoltò i quadri, iniziandone una nuova serie sul dorso delle stesse tele. Un sollievo straordinario, disse, al punto che nel corso delle successive tre settimane gli parve di essere rinato. A tale secondo ciclo di paesaggi lavorò con intensità ancora maggiore, dopo di che, quando tutti i dorsi furono ricoperti, si mise a dipingere sui mobili della grotta, tirando frenetiche pennellate sull’armadio, sul tavolo e sulle sedie di legno, finché, quando anche queste superfici furono coperte, consumò le ultime gocce di colore strizzandole letteralmente dai tubi per attaccare la parete meridionale, dove abbozzò i contorni di un dipinto panoramico rupestre. Che, disse, sarebbe stato il suo capolavoro se i colori non fossero finiti quand’era soltanto a metà.
Era ormai inverno. Disponeva ancora di diversi taccuini e di una scatola di matite, ma, invece di passare dalla pittura al disegno, durante i mesi freddi si mise tranquillo, passando il tempo a scrivere. In un taccuino annotò pensieri e osservazioni, tentando di fare con le parole ciò che aveva in precedenza fatto per mezzo delle immagini, mentre in un altro continuò a tenere il diario delle proprie attività giornaliere, procedendo a una contabilità esatta dei consumi: quanto cibo aveva mangiato e quanto ne rimaneva, quante candele aveva arso e quante erano ancora intatte. In gennaio nevicò ogni giorno per una settimana...