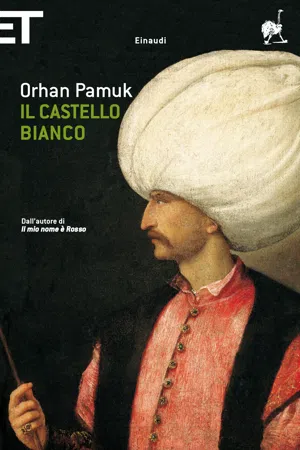![]()
All’inizio dell’estate, non appena venimmo a sapere che il Padiscià ci aspettava, con l’arma, a Edirne, il Maestro passò all’azione. Compresi allora che aveva predisposto ogni cosa, che durante l’inverno aveva continuato a intrattenere i rapporti con la disciolta squadra d’addetti all’apparecchio. Tre giorni dopo eravamo pronti a metterci in marcia. Quasi fossimo in procinto di traslocare in una nuova casa, il Maestro trascorse la vigilia a rimescolare i vecchi volumi dalle rilegature sdrucite, i trattati incompiuti, le ingiallite carte d’appunti, i propri oggetti, le cianfrusaglie. Fece suonare il campanello dell’orologio da preghiera arrugginito, spolverò gli strumenti d’astronomia. Rovistò fino al mattino tra i libri scritti in venticinque anni, gli schizzi degli apparati realizzati, i fogli di abbozzi. Sul far del giorno lo vidi intento a sfogliare le pagine consunte e sbiadite del quadernetto che io avevo riempito con le osservazioni condotte nel corso delle prove di quel primo spettacolo pirotecnico. Domandò imbarazzato: dovevamo portarle appresso, queste note? Potevano esserci di qualche utilità? Colse il mio sguardo vacuo, e gettò stizzito in un angolo ciò che teneva in mano.
Pure, durante il viaggio a Edirne, protrattosi per dieci giorni, eravamo ancora vicini l’uno all’altro, benché non con l’intensità dei vecchi tempi. Anzitutto, il Maestro era fiducioso; la nostra arma, che si muoveva torpida fra stridori da brivido e strepiti bizzarri, detta di volta in volta portento, insetto, demonio, testuggine, torre mobile, ferraglia, pacioccona, gagliardona, pignatta su ruote, gigante, ciclope, bestia, vile indole di porco, zingara, strega dal ceruleo sguardo, parente portasfortuna, la nostra arma, seminando il terrore tra gli astanti, proprio come desiderava il Maestro, piú veloce di quanto lui non supponesse, avanzava. Godeva, lui, al vedere che lungo il tragitto i curiosi arrivati dai villaggi vicini, allineati, addossati alle colline che fiancheggiavano il percorso, con lo sgomento che impediva loro di accalcarsi attorno alla macchina, l’ammiravano stupefatti. Di notte, quando i nostri ausiliari, sommersi dal sangue e dal sudore durante la giornata, piombavano in un sonno profondo nelle loro tende, il Maestro, in una quiete scalfita dal canto dei grilli, mi illustrava quali tiri la sua gagliarda pacioccona avrebbe giocato ai nemici. In verità, non ribolliva piú l’antica smania; anche lui, quanto me, era preoccupato dalla reazione che il seguito del Padiscià e l’esercito avrebbero manifestato davanti all’arma; era in pensiero per la posizione che a essa sarebbe stata assegnata nel piano d’attacco; ciò nonostante, poteva tuttora discorrere della nostra «ultima risorsa», dell’occasione di volgere il flusso del torrente nel verso da noi auspicato e, soprattutto, era in condizione di affrontare, con pace e convinzione in cuore, il tema che sempre pungolava il suo entusiasmo: «noi e loro».
L’arma fece il suo ingresso in Edirne con una cerimonia in cui nessuno, ad eccezione del Padiscià e di qualche adulatore senza dignità, l’accolse festoso. Il Sovrano ricevette il Maestro come se incontrasse un vecchio amico; si accennava all’eventualità di una guerra, ma non c’era nell’aria né eccessiva ansia né allarme esagitato; loro cominciarono a passare insieme i giorni, e anch’io mi associavo. Quando montavano a cavallo e andavano a sentire il cinguettio degli uccelli negli ombrosi boschi circostanti, oppure osservavano le ranocchie durante una gita in sandolo su Tungia e Marizza, o coccolavano le cicogne, rimaste ferite nella lotta con le aquile, che si erano posate nel cortile della moschea Selimiye, o si recavano a ispezionare l’arma per verificarne ancora le efficaci manovre, anch’io ero sempre accanto a loro. Eppure, lo constatavo con dolore, non avevo parole da aggiungere a ciò di cui discorrevano, niente che ascoltassero con interesse, e che io sapessi esprimere con sincera partecipazione. Può darsi che io fossi geloso di quell’intimità. Però, ne ero cosciente; io mi ero già stancato e il Maestro ripeteva la sua concione; si era scrollato ormai di dosso il peso della superiorità schiacciante degli altri, e io mi meravigliavo che il Padiscià si beasse alla solita fola sulla necessità che noi agissimo, per il futuro, sul contenuto delle nostre teste.
Un giorno di mezza estate, quando s’erano infittite le voci di guerra, il Maestro mi portò con sé, affermando che aveva bisogno di una persona robusta. Camminammo lesti in città, transitammo per i quartieri degli Zingari e degli Ebrei, in certe viuzze grigie dove già in precedenza avevo gironzolato con tedio, tra le case dei poveri musulmani che per la maggior parte si rassomigliavano. Notando che le abitazioni ricoperte d’edera che avevo visto alla mia sinistra erano passate ora alla mia destra, capii che ci aggiravamo per le stesse strade. M’informai: eravamo nel quartiere Fildamí. Improvvisamente il Maestro bussò a una porta. Ci aprí un bambino dagli occhi verdi, sugli otto anni. «I leoni, – gli disse il Maestro, – dal Palazzo del Padiscià sono scappati i leoni! Li stiamo cercando». Quando, scostando il bambino, lui entrò, lo seguii. All’interno c’era odore di polvere, legno e sapone; nella penombra, attraverso la scala scricchiolante, salimmo in fretta di sopra, in un salone. Il Maestro si mise a spalancare le porte che incontrava. Nella prima stanza sonnecchiava a bocca socchiusa, sdentata, un vecchio sfinito; due mocciosi allegri, chini sulla sua barba per chiedergli qualcosa, vedendo che la porta s’era aperta si spaventarono. Richiuse, e ne aprí un’altra: dentro stavano coperte ammucchiate e rotoli di stoffa per imbottite. Davanti alla porta della terza camera, precedendo il Maestro, si parò il bambino che ci aveva accolti: «Nessun leone, qui; c’è mamma con la zia». Volle aprire comunque: le spalle rivolte a noi, in una luce fioca, due donne pregavano. Nella quarta, un uomo intento a cucire trapunte, senza barba com’era, somigliava ancor di piú a me. Vedendo il Maestro si alzò: «Perché sei venuto, essere folle? – esclamò. – Che cosa vuoi da noi?» «Dov’è Semra?» chiese il Maestro. «È andata a Istanbul dieci anni fa, – ribatté l’uomo. – Pare sia morta di peste. E tu, non ce l’hai fatta, a crepare?» Il Maestro, senza aggiungere parola, scese dalle scale e uscí. Mentre gli stavo dietro, sentii alle mie spalle il bambino urlare: «Mamma, sono venuti i leoni!» E una donna rispondergli: «No, figliolo: erano il tuo zio paterno e suo fratello!»
Forse perché non riesco a dimenticare quanto è successo, forse al fine di predispormi alla mia nuova vita e di apprestare il libro che state leggendo con pazienza... chissà: il fatto è che, due settimane dopo, di mattina presto, tornai nel medesimo posto. Sarà stato per la scarsa luce che m’ingannava, ma sulle prime durai fatica a individuare quella via e quella casa; e quando ci riuscii, cercai di rintracciare la strada piú breve che portasse all’Ospedale della moschea di Beyazíd, del quale avevo già in anticipo intuito l’ubicazione. Può darsi che mi sbagliassi nel calcolare che loro avrebbero scelto la via piú breve, ma, insomma, non seppi trovare la scorciatoia ombreggiata dai pioppi che raggiungeva il ponte; e poi, sul ciglio della strada orlata da pioppi, che trovai, non scorreva un fiume sulla cui riva sedersi a rimirare e a mangiare helva. Quanto all’ospedale, in esso non esisteva nessuna delle cose che avevamo immaginato; non era sporco di fango, ma piuttosto assai lindo; però non si udiva risuonare l’acqua, né si vedevano bocce variopinte. Scorgendo un malato in catene, impaziente mi rivolsi a un medico: quel malato era impazzito d’amore e, al pari di tanti pazzi, si credeva un altro; si sarebbe dilungato, il medico, ma io senza ascoltarlo tornai indietro.
La decisione d’intraprendere la spedizione, che ormai davamo per tramontata, giunse alla fine dell’estate, per giunta in un giorno inaspettato: i Polacchi, non rassegnati a sopportare la sconfitta dell’anno precedente e i grevi tributi, mandarono a dire: «Le imposte, venite a prendervele con le vostre spade». Nei giorni che seguirono, il Maestro era come soffocato dalla bile; mentre si organizzavano l’ordine di marcia e la formazione dell’esercito, nessuno pensava a una collocazione per l’arma. Nessuno in combattimento voleva vedersi accanto quel lugubre ammasso di ferro; nessuno s’attendeva destre manovre da quella gigantesca pignatta; inoltre, la giudicavano di cattivo auspicio. Mentre il Maestro, alla vigilia della spedizione, traeva presagi, ci riferirono l’avvertimento dei nostri avversari: annunciavano chiaro che l’arma, cosí come poteva recare la vittoria, allo stesso modo poteva rivelarsi foriera di maledizione. Quando il Maestro mi spiegò che pensavano ci fossi io alle spalle di tale sciagura con responsabilità ben maggiori delle sue, caddi in preda a un minaccioso terrore. Il Padiscià aveva dichiarato di fidarsi del Maestro e dell’arma, e a scanso di dispute aveva pure affermato che, nel corso della guerra, la macchina sarebbe stata direttamente ai suoi ordini, distaccata nella sua guardia personale. All’inizio di settembre, in una giornata calda, partimmo da Edirne.
Ognuno in cuor suo considerava che era tarda stagione per intraprendere una spedizione, ma sull’argomento non si discuteva molto: stavo imparando che in una campagna di guerra il soldato teme la malasorte quanto il nemico, o anche di piú, e combatte con questa paura. La notte del primo giorno, quello della marcia verso settentrione attraverso villaggi fiorenti, curati, e ponti che gemevano sotto il nostro ordigno, ci chiamarono dal padiglione del Sultano, e noi ci stupimmo. Non meno dei suoi uomini, il Padiscià era rincitrullito, con la curiosità e l’eccitazione tipiche di un bambino che sta per cominciare un nuovo gioco, e, non diversamente dai soldati, chiese al Maestro in che senso lui interpretasse gli eventi del giorno: una nuvola rossa davanti al sole al tramonto, i falchi che volavano bassi, il comignolo decrepito della casa di un paesino, le cicogne che scendevano verso sud, che significato avevano? Naturalmente, il Maestro li spiegò tutti come segni fausti.
Ma la nostra incombenza non era finita qui: entrambi apprendevamo adesso che il Padiscià, nelle notti di campagna militare, amava molto ascoltare racconti strani, spaventosi. Il Maestro ispirandosi ai versi infervorati del nostro libro che io amavo di piú, e di cui avevamo fatto dono anni prima al Padiscià stesso, tracciò un macabro quadro, un’orribile scena dove ribollivano e si confondevano morti ammazzati, sanguinose sconfitte, disfatte, tradimenti e miseria, ma dove ardeva anche, in un cantuccio che gli sguardi del Padiscià potevano raggiungere, la fiamma della vittoria: per attizzarla dovevamo adoperare la nostra intelligenza, era necessario rendersi conto al piú presto di «loro» e di «noi», e poi del contenuto delle nostre menti, di tutte quelle cose che da anni il Maestro veniva spiegandomi e che ormai volevo dimenticare; riscuoterci, dovevamo! Sarà dipeso dal fatto che riteneva che anche il Padiscià ne avesse abbastanza, ma il Maestro ogni notte accentuava i toni lugubri, le brutture, l’orrore di quella stucchevole storia che a me procurava disgusto. Ciò nonostante, sentivo che, quando si sfiorava il contenuto delle nostre menti, il Padiscià fremeva di piacere.
Le battute di caccia ebbero inizio la settimana della nostra avanzata. Un gruppo, aggregato all’esercito esclusivamente con questa funzione, andava in avanscoperta, e dopo che quello aveva perlustrato la zona, scelta l’area adatta e importunati i contadini, il Padiscià, noi e i cacciatori ci staccavamo dalla colonna in marcia e ci inoltravamo in un boschetto famoso per le sue gazzelle, sulle pendici di un monte dove scorrazzavano i cinghiali, o in una foresta che pullulava di volpi e di lepri. Al termine di quei piccoli e piacevoli diversivi che duravano ore, rientravamo nella colonna in marcia con una pompa degna di un ritorno da una guerra vittoriosa: mentre l’armata salutava il Padiscià, noi gli stavamo immediatamente alle spalle. Mi garbava quel fasto che il Maestro giudicava con astio; la sera, piú che dell’avanzata, delle condizioni delle terre e delle cittadine attraversate, o delle ultime notizie sul nemico, mi piaceva conversare con il Padiscià di caccia. Poi il Maestro, col furore suscitato in lui da quelle chiacchiere che trovava idiote e stolte, dava la stura alle sue tiritere e alle sue divinazioni, di una veemenza crescente. Il fatto che il Padiscià credesse a quei racconti che volevano essere spaventosi e alle favole sul contenuto delle nostre teste, ormai angustiava anche me come gli altri.
Ma di spettacoli ben peggiori sarei stato testimone! Ancora in relazione alla caccia: era stata evacuata una decina di villaggi, e la popolazione sparpagliata nel bosco, affinché, facendo baccano con le taniche, sospingesse i cinghiali e i cervi verso il punto dove noi li aspettavamo, a cavallo e armi in pugno; fino a mezzogiorno però non avevamo incontrato un solo capo di selvaggina. Un po’ anche per effetto della meridiana calura, allo scopo di alleviare il fastidio che ci opprimeva, il Padiscià aveva chiesto al Maestro di narrargli quelle favole che la notte lo facevano rabbrividire. Avanzavamo lenti, prestando l’orecchio a quel remoto, vago risuonare di latta, quando c’imbattemmo in un insediamento cristiano, e ci fermammo. Mi accorsi allora che il Padiscià e il Maestro additavano una delle case di quel villaggio svuotato e che di laggiú stavano portando, sostenendolo per le ascelle, un vecchietto gracile che aveva fatto capolino alla porta. Poco prima avevano parlato, di nuovo, di «quelli», dei contenuti delle menti. Notai l’espressione di curiosità sui loro volti e osservai che il Maestro, attraverso l’interprete, domandava al vecchio qualcosa; mi feci dunque piú vicino, preso da un’idea paurosa. Il Maestro l’interrogava esigendo che quello rispondesse all’istante, senza pensarci sopra. Qual era la piú grossa colpa della sua vita, la cattiveria piú grave da lui commessa? Il vecchio mormorava, in una lingua slava sconnessa che l’interprete ci traduceva pian piano: era un povero anziano senza peccati né colpe. Ma il Maestro, con singolare indignazione, insisteva: voleva che quello parlasse di sé. Il vecchio arrivò ad ammettere le proprie macchie solo quando si rese conto che anche il Sultano era interessato quanto il Maestro: sí, era colpevole, anche lui avrebbe dovuto uscir di casa con l’intero villaggio e partecipare con i compaesani alla caccia e inseguire gli animali, ma era malato, quindi perdonabile, dato che non aveva la forza di trottare tutto il giorno nel bosco: con la mano accennava al cuore, chiedendo pietà. Il Maestro s’infuriò; sbraitò che non quello voleva sapere, ma i peccati veri. Il contadino non sembrava capire la questione che l’interprete gli sottoponeva ossessivamente: era rimasto immobile, premendosi addolorato la mano sul cuore. Lo portarono via. Anche un altro rispose al medesimo modo, e il Maestro si fece scarlatto. Mentre poi, per rendergli piú agevole l’ammissione, raccontava a quel secondo individuo, come esempi di perfidia riprovevole, le malefatte della mia infanzia, le bugie che spiattellavo per essere io il piú amato dei fratelli, i peccati carnali da me commessi quando studiavo all’università, quasi il Maestro gli elencasse i crimini di un anonimo ed estraneo peccatore, io, che scrivendo questo libro ho con nostalgia richiamato alla memoria i giorni della peste, ricordavo quegli stessi giorni con ripugnanza e vergogna. Un paesano zoppo, condottogli da ultimo, confessò in un sussurro di aver guardato di nascosto le donne che si lavavano al fiume, e il Maestro un po’ si placò. Sí, ecco, cosí erano «quelli» di fronte alle loro malvagità, arrivavano impudenti a riconoscerle; noialtri, però, dovevamo ormai sapere ciò che avveniva dentro le menti eccetera, eccetera. Io mi sforzavo di credere che il Padiscià non fosse troppo impressionato.
Al contrario, si era incuriosito; due giorni dopo, in occasione di una nuova battuta in cui inseguivamo i cervi, vuoi perché non sapeva opporsi all’irruenza del Maestro, vuoi perché traeva dall’interrogatorio piú piacere di quanto io non immaginassi, chiuse un occhio di fronte alla stessa scena. Stavolta eravamo oltre il Danubio, sempre in un villaggio cristiano, ma dove parlavano un idioma di origine latina. Quanto alle richieste del Maestro, non erano molto diverse. In un primo tempo, non volli nemmeno ascoltare le risposte dei contadini impauriti sia da quelle domande, che mi ricordavano l’impeto con il quale ero riuscito a fargli mettere per iscritto le sue turpitudini, sia da quel giudice d’ignota identità, sia dal Sultano che in silenzio lo approvava. Una strana ripulsa si era impadronita di me: piú che del Maestro, ero scandalizzato del Padiscià che gli credeva, o che non sapeva resistere all’attrazione di quel gioco di pessimo gusto. Ma non durò a lungo, quella mia ripugnanza: non si perde niente ad ascoltare, mi dissi accostandomi a loro; molte di quelle colpe, ammesse in una lingua che al mio orecchio suonava piú garbata e gradevole, somigliavano l’una all’altra: banali fandonie, piccoli sotterfugi, un paio d’astuti inganni, infedeltà; al massimo, qualche furtarello.
A sera, il Maestro affermò che i paesani non avevano raccontato tutto, che nascondevano la verità. Ben piú in là ero andato io, a suo tempo: quelli dovevano avere colpe assai piú riposte e concrete che li distinguevano da noi. Avrebbe convinto il Padiscià: se necessario sarebbe ricorso alla violenza, per procurarsi quelle verità, al fine di dimostrare com’erano «loro» e come invece eravamo noi.
I giorni seguenti trascorsero nel segno di quella violenza mostruosa che cresceva e diventava farneticante. All’inizio tutto era piú semplice; eravamo come bambini che nel bel mezzo dei loro giochi introducessero grevi burle che potevano anche sembrare simpatiche; quelle ore d’interrogatorio erano simili a commediole scherzose messe su durante le lunghe e divertenti battute di caccia, ma alla fine s’erano trasformate in riti ineludibili che esaurivano tutta la nostra volontà, la nostra fermezza, la nostra sopportazione. Vedevo i contadini scossi dall’orrore delle domande del Maestro e dalla sua furia immotivata; avessero almeno capito che cosa si voleva da loro, forse avrebbero anche raccontato; vedevo i vecchi sdentati ed esausti, concentrati sulla piazza del paese; prima di ammettere balbettando le loro colpe, o le finte colpe, con la disperazione negli occhi imploravano aiuto da chi li circondava, da noi. Vedevo i giovani maltrattati, vessati, presi a spintoni quando non si ritenevano soddisfacenti le confessioni dei loro peccati. Ricordai che dopo avermi letto a un capo del tavolo ciò che aveva scritto, mi minacciava e mi sferrava un pugno sulla schiena, mugugnava offeso e si rodeva perché non riusciva a comprendere come io fossi fatto in quel modo. Seppur non in maniera molto netta, sapeva comunque meglio che cosa stava cercando, a quale risultato puntava. Adottò anche altri metodi: interrompeva a ogni parola chi stava confessando, e lo accusava di mentire; allora, i nostri uomini malmenavano il disgraziato. Altre volte zittiva l’interlocutore, sostenendo che un suo compagno lo aveva colto in fallo. A un certo punto provò a convocarli a due a due: constatava allora che le verità restavano superficiali, che i contadini, nonostante il rigore dei nostri sgherri, si vergognavano l’uno dell’altro, e s’infuriava.
Al principiar di quelle piogge che non smettevano mai, mi ero come assuefatto a ciò che si verificava. Rammento che in un fangoso spiazzo di paese gli abitanti, non molto abili nell’esprimersi, né troppo intenzionati a farlo, erano inutilmente percossi e tenuti ad aspettare per ore, bagnati fradici. Anche le battute di caccia perdettero gradualmente in durata e splendore. Di tanto in tanto colpivamo una gazzella dagli occhi languidi che immalinconiva il Padiscià, o un grosso cinghiale, certo; però nel pensiero di tutti non c’erano piú le vicende della caccia, bensí quegli interrogatori, caratterizzati da preparativi che cominciavano, esattamente come quelli della caccia, molto in anticipo. La notte, quasi sentisse il rimorso delle azioni commesse di giorno, il Maestro si confidava con me. Anche lui si sentiva a disagio per la brutalità degli eventi, ma intendeva appurare una cognizione, una conoscenza che sarebbe stata utile a tutti noi. Voleva dimostrarla al Padiscià. E poi, perché quei contadini nascondevano la verità? Aggiunse che avremmo dovuto provare la stessa esperienza in un villaggio musulmano, ma non pervenne ad alcun risultato: benché li sottoponesse a un interrogatorio piú blando, pure loro, non diversi dai vicini cristiani, s’erano lasciati andare suppergiú alle medesime ammissioni, alle medesime esposizioni. Era uno di quei giorni sciagurati di pioggia ininterrotta; il Maestro bofonchiò qualcosa, del genere che loro non erano musulmani autentici o cose del genere. Ma io me n’accorgevo: quando a sera riesaminava l’accaduto, avvertiva che la verità non era sfuggita all’occhio del Sultano.
Questo non gli serví che a esacerbare la sua rabbia, a spingerlo a usare per una speranza estrema quella violenza alla quale il Sultano non si rallegrava troppo di essere testimone, ma nella quale, forse come me, era coinvolto per mera curiosità. Avanzando a settentrione, eravamo di nuovo giunti in una regione boscosa, dove gli abitanti parlavano una lingua slava; in un piccolo, ridente borgo, lo vedemmo percuotere con le sue mani un bel giovanotto che ricordava soltanto un’infantile bugia. Promise che non l’avrebbe piú fatto, e a sera fu colto da un particolare senso di colpa, secondo me persino eccessivo. In un’altra occasione mi parve d’aver intravisto, in una pioggia giallognola, le donne gemere da lungi per quanto capitava ai loro uomini. Persino ai nostri soldati, che avevano acquisito maestria in tale esercizio, quella prassi era venuta a noia; a volte, sceglievano e ci recavano loro stessi un individuo da inquisire, che avevano notato precedendoci; prima del Maestro, che appariva sfibrato dal proprio furore, era l’interprete in persona a procedere alle domande preliminari. Non che mancassimo d’imbatterci in vittime interessanti, le quali si dilungavano a esporre le loro confessioni, quasi che intimamente, da anni, aspettassero quel giorno del giudizio, con lo spavento e lo stupore di una sublime giustizia, informati della nostra furia, della quale, ci dissero, volava la fama di terra in terra, mutando in leggenda. Ma il Maestro non era piú attratto da storie di mariti e di mogli adulteri, di poveracci che invidiavano il confinante agiato. Andava ripetendo che esisteva un’arcana verità; anch’egli, penso, come noi, nutriva di tanto in tanto dubbi sulla possibilità di raggiungerla e lo pervadeva lo sdegno, ma sia noi, sia il Padiscià intuivamo che lui non aveva alcuna intenzione di lasciar perdere. Forse anche per questa ragione assistemmo al passaggio completo delle redini nelle sue mani. Una volta, ritrovammo le speranze vedendo che, bagnato fino al midollo sotto una tettoia dove ci eravamo rifugiati a causa di un acquazzone, costringeva a subire un interrogatorio di ore un giovane che odiava il padre adottivo e i fratellastri per il loro malvagio comportamento nei confronti di sua madre; piú tardi però, a sera, liquidò l’argomento affermando che si trattava di un qualunque trascurabile ragazzetto.
Eravamo saliti a nord, sempre piú a nord. La colonna in marcia avanzava molto lenta sulle strade fangose, nei boschi intricati e bui, snodandosi fra le alte montagne. Amavo l’aria fresca e tenebrosa che spirava dalle foreste di pini e di faggi, i foschi silenzi che adombravano il timore, la vaghezza. Nessuno adoperava questo nome, ma suppongo che ci trovassimo alle falde di quei monti Carpazi adornati con disegni di cervi e castelli gotici sulla carta d’Europa tracciata da un mediocre pittore, che da bambino avevo visto in mano a mio padre. Il Maestro, intirizzito dalle piogge, era malato: eppure ancora, ogni mattina, ci staccavamo dalla strada che pareva attorcigliarsi per arrivare piú tardi alla meta, e ci addentravamo nei boschi. Le battute di caccia sembravano ormai dimenticate; ciondolavamo sulla riva di un corso d’acqua, sull’orlo di un precipizio, non tanto per ...