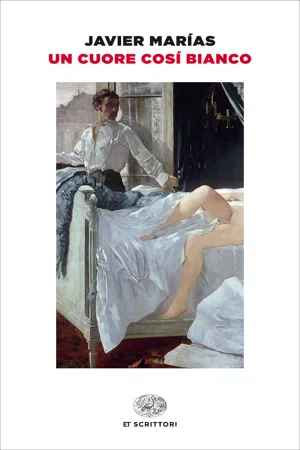![]()
Javier Marías
Un cuore cosí bianco
Traduzione e cura di Paola Tomasinelli
![]()
A Julia Altares
malgrado Julia Altares
e a Lola Manera, dell’Avana,
in memoriam
![]()
![]()
Non ho voluto sapere, ma ho saputo che una delle bambine, quando non era piú bambina ed era appena tornata dal viaggio di nozze, andò in bagno, si mise davanti allo specchio, si sbottonò la camicetta, si sfilò il reggiseno e si cercò il cuore con la canna della pistola di suo padre, il quale si trovava in sala da pranzo in compagnia di parte della famiglia e di tre ospiti. Quando echeggiò lo sparo, piú o meno cinque minuti dopo che la bambina si era allontanata, il padre non si alzò subito da tavola, ma restò per qualche secondo incapace di muoversi e con la bocca piena, senza riuscire a masticare né ingoiare e tantomeno sputare il boccone nel piatto; e quando, alla fine, reagí e corse in bagno, chi lo aveva seguito notò che mentre scopriva il corpo insanguinato della figlia e si metteva le mani nei capelli continuava a passare il boccone di carne da una guancia all’altra, senza sapere che farne. Stringeva in mano il tovagliolo, e lo lasciò andare solo nel momento in cui, accortosi del reggiseno abbandonato sul bidè, cercò di nasconderlo con il tovagliolo che teneva a portata di mano o stretto in mano e che le sue labbra avevano macchiato, come se provasse piú vergogna alla vista di quell’indumento intimo che davanti al corpo riverso e seminudo con cui l’indumento era stato a contatto fino a poco prima: il corpo che si era seduto a tavola, e poi aveva attraversato il corridoio e si era diretto in bagno. Un attimo prima, con un gesto automatico, il padre aveva chiuso il rubinetto del lavabo, quello dell’acqua fredda, che era rimasto quasi del tutto aperto. Mentre si fermava davanti allo specchio, e si apriva la camicetta per sfilarsi il reggiseno e cercarsi il cuore, la figlia doveva aver pianto, poiché, distesa sul pavimento freddo di quel bagno enorme, aveva gli occhi traboccanti di lacrime che a pranzo nessuno aveva notato né potevano essere spuntate dopo che era caduta a terra senza vita. Contrariamente alle sue abitudini e a quelle della famiglia, non aveva chiuso a chiave la porta, per questo il padre dovette immaginare (ma solo per un istante e quasi senza rendersene conto, mentre ingoiava ciò che gli era rimasto in bocca) che forse sua figlia, in lacrime, aveva atteso o desiderato che qualcuno intervenisse, aprendo la porta e impedendole di fare quel che aveva fatto, non con la forza, ma con la sua presenza, osservandone la nudità mentre era ancora viva o posandole una mano sulla spalla. Ma nessuno (eccetto lei, e proprio perché non era piú una bambina) si era alzato da tavola durante il pranzo. Il seno che non era stato colpito era bene in vista, materno, bianco e ancora sodo, e lí si erano diretti, istintivamente, i primi sguardi, forse per evitare di fissarsi sull’altro, che non c’era piú, e non era che sangue. Il padre non aveva piú visto quel seno da tempo, non l’aveva piú visto da quando si era trasformato per assumere un aspetto femminile, e perciò, oltre a spaventarsi, ne rimase turbato. L’altra bambina, la sorella, che invece lo aveva visto crescere durante la pubertà e forse anche oltre, fu la prima a toccarla, e con un asciugamano (il suo, quello azzurro, quello che usava di solito) iniziò a tamponare le lacrime, mescolate al sudore e all’acqua, perché prima che chiudessero il rubinetto il getto era schizzato sulla maiolica e alcune gocce avevano raggiunto le guance, il seno bianco e la gonna sgualcita della sorella. Cercò pure, confusamente, di asciugare il sangue come per curarla, ma l’asciugamano in un attimo se n’era completamente intriso, aveva cambiato colore e non poteva servire piú a niente. Vedendolo cosí rosso (era il suo asciugamano), la sorella lo tolse subito e, piuttosto che lasciarlo inzuppare ulteriormente per coprirle il seno, lo appoggiò sul bordo della vasca, lasciandolo sgocciolare. Parlava, ma non faceva che pronunciare il nome di sua sorella, e continuava a ripeterlo. Uno degli ospiti non riuscí a evitare di guardarsi allo specchio da lontano e aggiustarsi velocemente i capelli, giusto in tempo per accorgersi che il sangue e l’acqua (ma non il sudore) erano schizzati sulla superficie imbrattando di conseguenza ogni suo riflesso, compreso quello di lui che si specchiava. Stava immobile sulla porta del bagno, senza entrare, esattamente come gli altri due ospiti, come se, pur non pensando in quella circostanza all’etichetta, reputassero che solo i componenti della famiglia avessero il diritto di varcarla. I tre si limitavano ad affacciarsi sulla soglia, piegati in avanti come i grandi quando ascoltano i bambini, senza muovere un passo, come catturati da una sensazione di nausea o di rispetto, forse di nausea, benché uno di loro fosse medico (quello che si era guardato allo specchio) e sarebbe stato assolutamente normale che con fare risoluto si fosse avvicinato per esaminare il corpo della figlia, o che almeno, inginocchiandosi, le avesse tastato il collo. Ma non fu cosí, nemmeno quando il padre, sempre piú pallido e malfermo sulle gambe, si rivolse a lui e indicando il corpo della figlia disse «Dottore», con tono implorante benché privo di enfasi, e subito gli diede la schiena, senza aspettare una risposta. Non diede la schiena solo a lui e agli altri ospiti, ma anche alle figlie, a quella viva e a quella che non riusciva ancora a credere morta, e, reggendosi la fronte con i gomiti appoggiati sul lavandino, cominciò a vomitare quello che aveva mangiato, compreso il pezzo di carne che aveva ingoiato senza masticare. Suo figlio, il fratello, un po’ piú giovane delle due bambine, gli si avvicinò per soccorrerlo, ma non riuscí a far altro che afferrarlo per la giacca, come per sostenerlo ed evitare che i conati lo facessero barcollare, ma per chi vide la scena dovette sembrare piuttosto una disperata richiesta di protezione proprio nel momento in cui il padre non poteva offrirgliela. Per un attimo si udí fischiare. Il commesso del negozio, che spesso non consegnava la spesa fino all’ora di pranzo e che quando echeggiò lo sparo stava svuotando le cassette, si affacciò sulla porta del bagno fischiettando, come fanno i ragazzi quando vanno a spasso, ma s’interruppe di colpo (aveva la stessa età del figlio minore), alla vista di un paio di scarpe col tacco mezze sfilate dai piedi o semplicemente sfuggite dai talloni, e di una gonna un po’ scomposta e macchiata – le cosce macchiate – che era ciò che dalla sua posizione riusciva a scorgere della ragazza riversa a terra. Siccome non riusciva a passare né osava fare domande, e dato che nessuno si era accorto di lui, mentre lui avrebbe voluto sapere se c’erano dei vuoti da ritirare, riprese a fischiettare e tornò in cucina (questa volta, però, fischiava per allontanare la paura o alleviare la tensione), sapendo che presto o tardi sarebbe ricomparsa la cameriera da cui era solito prendere le ordinazioni e che adesso non si trovava nel suo territorio e nemmeno in mezzo a quella gente nel corridoio – al contrario della cuoca che, ormai diventata parte della famiglia, stava con un piede dentro il bagno e l’altro fuori e si puliva le mani sul grembiule, o forse si stava facendo il segno della croce. Quando si udí lo sparo, la cameriera stava appoggiando sul tavolo di marmo i piatti sporchi che aveva appena tolto da tavola, coprendo la detonazione con il rumore da lei stessa prodotto simultaneamente. Ignara dell’accaduto, aveva iniziato a disporre su un vassoio, con grande cautela e scarsa abilità, una torta gelato che aveva avuto ordine di comprare quella mattina in previsione dell’arrivo degli ospiti – il tutto mentre il ragazzo svuotava le cassette con altrettanto rumore –; quindi, dopo aver sistemato la torta, e immaginando che in sala da pranzo dovevano aver terminato il secondo, l’aveva portata di là e l’aveva appoggiata sul tavolo: con stupore si accorse che c’erano ancora avanzi di carne nei piatti, posate e tovaglioli buttati alla rinfusa sulla tovaglia e nessuno seduto a mangiare (solo un piatto era perfettamente pulito, come se qualcuno, la figlia maggiore, avesse finito prima degli altri e lo avesse persino ripulito con il pane, o al contrario non si fosse neanche servita). In quel momento si rese conto che, ancora una volta, aveva commesso l’errore di servire il dolce senza ritirare i piatti sporchi e averne distribuiti altri puliti, ma non osò raccoglierli e impilarli, nel caso che i commensali non avessero ancora finito di mangiare e intendessero proseguire (forse avrebbe dovuto portare anche la frutta). Aveva l’ordine di non girare per casa durante il pranzo e di limitare i suoi spostamenti tra la cucina e la sala per non disturbare e non distrarsi, di conseguenza non ebbe il coraggio di unirsi al vociare del gruppo che si era radunato sulla porta del bagno, chissà perché, e restò ad aspettare, le mani dietro la schiena e la schiena appoggiata alla credenza, osservando con apprensione la torta che aveva appoggiato al centro della tavola deserta e considerando che forse sarebbe stato meglio riporla subito in frigo, visto il caldo che faceva. Si mise a canticchiare, raddrizzò la saliera caduta, versò del vino in un bicchiere vuoto, quello della moglie del medico, che beveva volentieri. Trascorso qualche minuto a controllare la torta che iniziava a perdere consistenza e incapace di decidere sul da farsi, sentí il campanello dell’ingresso e, siccome aprire la porta faceva parte delle sue mansioni, si aggiustò la crestina, si lisciò il grembiule, si sistemò le calze e attraversò il corridoio. Gettò un’occhiata fugace alla sua sinistra, verso il gruppo di cui aveva udito incuriosita il vociare e le esclamazioni, ma non si fermò né si avvicinò e proseguí verso destra, come era suo dovere. Aprendo la porta si imbatté in risate che si spegnevano e in un intenso profumo di colonia (il pianerottolo era al buio) che proveniva dal primogenito della famiglia o dal cognato novello, appena rientrato dal viaggio di nozze, poiché i due erano arrivati insieme, probabilmente si erano incontrati per la strada o davanti al portone (erano venuti per il caffè, ma nessuno lo aveva ancora preparato). La cameriera rise, come contagiata, si fece da parte e li lasciò entrare, ed ebbe il tempo di cogliere l’improvviso cambiamento d’espressione sui loro volti e il modo in cui si diressero in corridoio, verso il bagno e il gruppo di persone. Il marito, il cognato, correva dietro al fratello, molto pallido e con una mano sulla sua spalla, quasi volesse fermarlo affinché non vedesse ciò che avrebbe potuto vedere, o forse per appoggiarsi a lui. La cameriera, invece di tornare in sala da pranzo, li seguí, affrettando anche lei istintivamente il passo, e arrivata sulla porta del bagno avvertí di nuovo, ancora piú forte, il profumo di colonia di uno dei due, o di entrambi, come se ne fosse stata versata un’intera boccetta o un improvviso sudore lo avesse reso ancora piú intenso. Restò lí, insieme alla cuoca e agli ospiti e, con la coda dell’occhio, notò il commesso del negozio che in quel momento passava fischiettando dalla cucina alla sala da pranzo, e che sicuramente la stava cercando; ma era troppo spaventata per chiamarlo, rimproverarlo o dargli retta. Il ragazzo, che aveva già visto abbastanza e se n’era andato senza salutare e senza ritirare i vuoti, doveva essere rimasto in sala da pranzo per un bel pezzo, poiché qualche ora piú tardi, quando la torta, ormai completamente liquefatta, venne portata via e gettata nell’immondizia avvolta in un pezzo di carta, mancava di una considerevole porzione che nessuno dei commensali aveva mangiato, e il bicchiere della moglie del medico era di nuovo vuoto. Tutti dissero che Ranz, il cognato, il marito, mio padre, era molto sfortunato, in quanto restava vedovo per la seconda volta.
![]()
Tutto questo accadde molto tempo fa, quando io non ero ancora nato né era possibile che lo fossi, anzi, proprio a partire da allora mi è stato permesso nascere. Ora sono sposato e non è ancora trascorso un anno dal viaggio di nozze con Luisa, mia moglie, la conosco da soli ventidue mesi, un matrimonio rapido, piuttosto rapido rispetto a quanto si dice sull’importanza di pensarci bene, anche in questi tempi affannati che non hanno niente in comune con quelli – non molto lontani (li separa, per esempio, una sola vita incompleta o forse mezza vita, la mia, o quella di Luisa) – in cui tutto era misurato, ponderato, e aveva peso, anche le stupidaggini, figuriamoci la morte, e la morte per propria mano, come quella morte di chi doveva essere mia zia Teresa ma non è mai potuta esserlo e fu solo Teresa Aguilera, di cui ho saputo a poco a poco, e non da sua sorella minore, mia madre, che non parlava quasi mai durante la mia infanzia e la mia adolescenza e poi morí e tacque per sempre, ma da persone piú distanti o casuali, e infine da Ranz, il marito di entrambe e pure di un’altra donna straniera che non è mia parente.
È vero che se solo negli ultimi tempi ho voluto sapere cos’era successo, è stato proprio a causa del mio matrimonio (diciamo che non volevo, ma l’ho saputo). Da quando lo contrassi (è un verbo obsoleto, ma rende l’idea) ho iniziato ad avere mille presentimenti funesti, come quando si contrae una malattia da cui non si avrà mai la certezza di guarire. La formula convenzionale cambiamento di stato civile, che di solito si usa alla leggera e per questo significa molto poco, nel mio caso mi sembra particolarmente adeguata ed esatta, e io la considero importante, cosa che normalmente non succede. Come una malattia ci può sconvolgere la vita al punto da obbligarci a mollare tutto e passare a letto giorni incalcolabili e guardare il mondo dal cuscino, il matrimonio era riuscito a sconvolgere le mie abitudini e le mie convinzioni, e, ciò che è piú importante, la mia considerazione del mondo. Forse perché l’ho contratto a una certa età, avevo trentaquattro anni.
Il problema principale e piú comune all’inizio dei matrimoni ragionevolmente convenzionali è che, nonostante la loro inconsistenza e la facilità con cui i contraenti possono sciogliere il vincolo, per tradizione è inevitabile sperimentare una sgradevole sensazione di punto d’arrivo, e dunque di arrivo a una fine, o meglio (dato che i giorni passano, uno dietro l’altro, impassibili, e non c’è fine) l’impressione che sia arrivato il momento di pensare ad altro. So bene che si tratta di un’impressione perniciosa e ingiusta, e che soccombere a essa o darla per scontata è la causa per cui tanti matrimoni promettenti falliscono prima ancora di iniziare a esistere come tali. So bene che è necessario cancellare immediatamente questa sensazione e, lungi dal pensare ad altro, pensare proprio a quello, al matrimonio, come se fosse la costruzione e l’obiettivo fondamentale da perseguire, anche quando crediamo di aver raggiunto il nostro obiettivo e di aver completato la costruzione. Questo lo so bene, tuttavia, quando mi sono sposato, proprio durante il viaggio di nozze (siamo stati a Miami, a New Orleans, a Città del Messico, e poi all’Avana), ho avuto due sensazioni sgradevoli, e mi domando ancora se la seconda non sia stata e non sia solo una fantasia, inventata o architettata per mascherare la prima, o per combatterla. Del primo malessere ho già accennato, è quello che, per ciò che si sente in giro o per il tipo di scherzi che si fanno a quelli che stanno per sposarsi, e per i molti proverbi pessimisti che esistono nella mia lingua, dev’essere comune a tutti gli sposi (soprattutto agli uomini) in quest’inizio di qualcosa che incomprensibilmente si percepisce e si vive come la fine di questo qualcosa. Un malessere che si riassume in una frase davvero sconcertante, e ignoro cosa dicano gli altri per replicare: «E adesso?»
Questo cambiamento di stato civile, come la malattia, è imprevedibile e interrompe qualsiasi cosa, o perlomeno non permette che le cose vadano avanti come prima: non permette, per esempio, che dopo essere andati a cena fuori o al cinema ci si separi e ognuno se ne torni a casa propria, e io accompagni Luisa al portone con la macchina o con un taxi e poi, dopo esserci salutati, faccia un giro da solo per le strade semideserte e sempre bagnate, pensando sicuramente a lei, e al futuro, da solo verso casa mia. Una volta sposati, all’uscita del cinema i passi si dirigono insieme verso lo stesso posto (andando fuori tempo perché ormai sono quattro i piedi che camminano), non perché io abbia deciso di accompagnarla e nemmeno perché abbia l’abitudine di farlo e credo sia giusto e corretto farlo, ma perché ora i piedi non esitano sulla strada bagnata, né decidono, né cambiano idea, né possono scegliere, o pentirsi: ora non c’è dubbio che si va dalla stessa parte, che questa sera lo si voglia o no, o forse era ieri sera che non lo volevo.
Già durante il viaggio di nozze, quando questo cambiamento di stato cominciò a realizzarsi (ma non è molto esatto dire che cominciò, poiché si tratta di un cambiamento brusco, che ti toglie il respiro), mi sono reso conto della difficoltà di pensare a lei, e dell’assoluta impossibilità di pensare al futuro, che è uno dei maggiori piaceri per chiunque, la quotidiana salvezza per tutti: pensare in modo vago, errare con il pensiero su quel che accadrà o può accadere, domandarsi senza troppa convinzione né interesse cosa sarà di noi domani stesso o tra cinque anni, e tutto ciò che non riusciamo a prevedere. Già durante il viaggio di nozze era come se si fosse smarrito o non esistesse piú un futuro astratto, che è ciò che importa, perché il presente non può smorzarlo né assimilarlo. Questo cambiamento, dunque, fa in modo che niente sia come prima, tanto piú se, come succede di solito, il cambiamento è stato preceduto e annunciato da uno sforzo comune, la cui principale manifestazione evidente è l’artificiosa preparazione di una casa per entrambi, una casa che non esisteva né per l’uno né per l’altro, ma che deve essere inaugurata da entrambi, artificiosamente. Proprio in questa abitudine, o usanza, molto estesa per quanto io ne sappia, c’è la dimostrazione che in realtà, con il matrimonio, i due contraenti stanno esigendo, l’uno dall’altra, un reciproco annullamento o annichilimento, l’annullamento di ciò che ciascuno era e di ciò che ha fatto innamorare l’altro o forse vederne qualche convenienza, in quanto non sempre c’è un innamoramento previo, a volte è posteriore e a volte non avviene, né prima né dopo. Non capita. L’annullamento di ciascuno, della sua parte conosciuta, vissuta e amata, porta con sé la scomparsa delle rispettive case, rendendola emblematica. Di modo che due persone abituate a stare ognuna per proprio conto, ognuna a casa sua, a svegliarsi da sole e spesso anche a coricarsi da sole, si trovano di colpo unite artificiosamente nel sonno e nel risveglio, e nei loro passi per le strade semideserte a senso unico, o insieme in ascensore, non piú uno come invitato e l’altro come ospite, non piú uno venuto a prendere l’altro o questi che scende per andare all’appuntamento con quello, che l’aspetta in macchina o su un taxi, ma entrambi senza possibilità di scelta, con le stanze e un ascensore e un portone che non appartenevano a nessuno e ora sono di tutti e due, con un cuscino in comune per il quale si troveranno a litigare nel sonno e dal quale, proprio come il malato, finiranno per avere una visione del mondo.
Come dicevo, questo primo malessere mi colse proprio all’inizio del viaggio di nozze, a Miami, città orrenda ma con delle splendide spiagge per due sposi novelli, e si accentuò a New Orleans, e a Città del Messico, e piú ancora all’Avana, e da quasi un anno, da quando siamo tornati dal viaggio e abbiamo inaugurato questa casa cosí artificiosamente, ha continuato ad aumentare o si è insediato dentro di me, o forse dentro di noi. Ma il secondo malessere si è manifestato con violenza verso la fine del viaggio, proprio cosí, solo all’Avana, luogo di cui in un certo senso sono originario, precisamente per una quarta parte, in quanto lí nacque e da lí si trasferí a Madrid mia nonna materna quando era piccola, la madre di Teresa e Juana Aguilera. Accadde nell’albergo in cui trascorremmo tre notti (non avevamo molti soldi, e le soste in ogni città furono brevi), una sera in cui Luisa si era sentita male mentre stavamo passeggiando, un male improvviso che ci obbligò a interrompere la passeggiata e a tornare subito in albergo, perché potesse coricarsi. Aveva i brividi e un po’ di nausea. Non riusciva letteralmente a stare in piedi. Doveva essere qualcosa che aveva mangiato, ma non potevamo saperlo con certezza, e io pensai subito che avesse contratto in Messico una di quelle malattie che contagiano gli europei con grande facilità, qualcosa di grave, come l’ameba. I neri presentimenti mi hanno accompagnato in silenzio fin dalla cerimonia nuziale assumendo forme differenti, e una fu questa (la meno silenziosa, quella che non taceva), la minaccia di una malattia o la morte improvvisa di colei che doveva condividere la vita con me e il futuro concreto e il futuro astratto, sebbene avessi l’impressione che il futuro astratto non esistesse piú e la mia vita fosse già a metà; o forse la vita di tutt’e due, insieme. Decidemmo di non chiamare subito un medico, sperando che le passasse, la misi a letto (il nostro letto d’albergo e di nozze), e lasciai che si addormentasse, come se questo potesse farla guarire. Sembrò assopirsi, e io restai in silenzio per farla riposare, e il modo migliore per stare in silenzio senza annoiarmi o essere tentato di fare rumore o di parlarle fu di affacciarmi al balcone e guardare fuori, guardare la gente cubana per strada, osservarne il passo e i vestiti e ascoltarne le voci a distanza, il mormorio. Ma guardavo fuori con il pensiero rivolto all’interno, alle mie spalle, al letto sul quale Luisa giaceva distesa di tra...