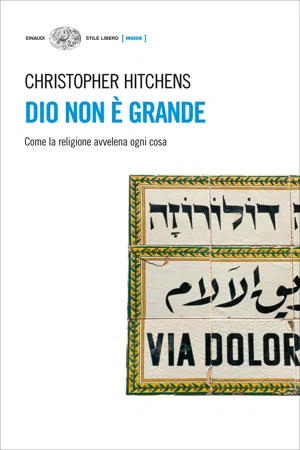![]()
Se il futuro lettore di questo libro volesse andare oltre il disaccordo con l’autore e intendesse individuare i peccati e le deformità che l’hanno spinto a scrivere (e ho sistematicamente notato come coloro che fanno pubbliche dichiarazioni di carità, compassione e perdono siano spesso inclini a seguire tale corso di pensiero), beh, costui o costei non se la prenda con l’inconoscibile e ineffabile creatore che – presumibilmente – mi ha fatto cosí. Essi denigreranno il ricordo di una donna dabbene, semplice e sincera, di solida e rispettabile fede: il suo nome è Mrs Jean Watts.
È stata Mrs Watts, quando ero un bambino di circa nove anni e frequentavo una scuola nel Dartmoor, nell’Inghilterra del Sudovest, a impartirmi lezioni sulla natura e anche sulle Sacre Scritture. Ci portava a passeggio in una zona particolarmente piacevole della mia bella contrada natale e ci insegnava a distinguere tra i diversi uccelli, le diverse piante e le diverse erbe. La stupefacente varietà che si poteva trovare in una siepe di arbusti; il miracolo di un mucchietto di uova scoperto in un nido intricato; il modo in cui se le ortiche ti pizzicavano le gambe (dovevamo portare i pantaloncini corti) c’era a portata di mano una foglia di balsamica acetosa: tutto questo mi si era fissato in mente, esattamente come il «museo del guardiacaccia», dove i contadini del posto esponevano cadaveri di topi, donnole e di altri predatori e animali nocivi, probabilmente forniti da qualche divinità meno benevola. Se provaste a leggere le imperiture poesie rurali di John Clare, potreste cogliere la musica di quel che desidero esprimere.
In altre lezioni ci veniva distribuita una striscia di carta stampata dal titoletto «Esplora le Scritture», inviata alla scuola da non ricordo quale autorità nazionale sovrintendesse all’insegnamento della religione. (Insegnamento, insieme al rito quotidiano delle preghiere, obbligatorio e fatto rispettare dallo stato). La striscia conteneva un versetto dell’Antico o del Nuovo Testamento e la consegna era di analizzarlo e poi dire alla classe o all’insegnante, oralmente o per scritto, quali ne fossero la storia e la morale. Era un esercizio che mi piaceva e vi primeggiavo (come Bertie Wooster), e spesso prendevo ottimo in Scrittura. È stata la mia iniziazione alla critica pratica e testuale. Leggevo tutto quanto precedeva il versetto e tutto quanto lo seguiva per essere sicuro di aver colto il «punto» della formulazione originale. Lo posso ancora fare, con grande fastidio di alcuni miei nemici, e ho sempre rispetto per coloro il cui stile è talora liquidato come «puramente» talmudico o coranico o «fondamentalista». È un addestramento mentale eccellente e necessario.
Tuttavia, venne il giorno in cui la povera, cara Mrs Watts fece il passo piú lungo della gamba. Nell’ambizioso tentativo di fondere i suoi due ruoli di istruttrice di scienze naturali e di insegnante della Bibbia, disse: «Vedete dunque, bambini, quanto Dio sia generoso e potente. Ha fatto gli alberi e l’erba verdi, e il verde è il colore piú riposante per i nostri occhi. Immaginate come sarebbe terribile se, invece, la vegetazione fosse tutta rossa o arancione».
Attenti a cosa aveva combinato quella devota e sciocca vecchietta. Amavo Mrs Watts: era una vedova affettuosa e senza figli che aveva un decrepito e mite cane da pastore dal nome spavaldo di Rover, e ci invitava fuori orario scolastico per delle merende nella sua vecchia casa un po’ sgangherata vicina alla ferrovia. Se Satana la scelse per farmi cadere nell’errore, si rivelò molto piú inventivo dell’astuto serpente del paradiso terrestre. Non alzava mai la voce e mai faceva mostra di violenza – cosa che non si potrebbe dire di tutti gli altri insegnanti – e, in linea di massima, era una di quelle persone il cui ritratto troviamo in Middlemarch, delle quali si può dire che se «le cose non vanno cosí male per te e per voi come sarebbe stato possibile [è] per metà merito di coloro che condussero tenacemente una vita nascosta e riposano in tombe neglette»1.
Tuttavia, restai sinceramente sgomento per ciò che disse. I miei piccoli sandali col cinghietto alla caviglia si torsero d’imbarazzo per lei. All’età di nove anni non avevo di certo la nozione di disegno intelligente né della rivale concezione dell’evoluzione darwiniana, e neppure del rapporto tra fotosintesi e clorofilla. I segreti del genoma mi erano ignoti come lo erano peraltro a chiunque in quell’epoca. Non avevo visitato luoghi della natura dove quasi tutto è disgustosamente indifferente o ostile alla vita umana, se non alla vita stessa. Semplicemente sapevo, quasi avessi accesso privilegiato a un’autorità piú alta, che la mia insegnante era riuscita a fare ben due affermazioni sbagliate. Gli occhi si erano adattati alla natura, e non all’inverso.
Non pretendo di ricordare ogni cosa perfettamente, o in sequenza, dopo questa epifania, ma non ci avevo messo molto a notare altre stranezze. Perché, visto che dio era il creatore di tutte le cose, eravamo tenuti a «lodarlo» se faceva ciò che per lui era tanto naturale? Mi sembrava una cosa servile, a parte ogni altra considerazione. Se Gesú poteva guarire i ciechi che per caso incontrava, perché non guariva la cecità? Cosa c’era di tanto meraviglioso nel cacciare i diavoli, se poi questi entravano in un branco di porci? Mi sembrava qualcosa di sinistro: una sorta di magia nera. Con tutte le preghiere che si dicevano, perché non c’erano risultati? Perché dovevo continuare a dire pubblicamente che ero un miserabile peccatore? Perché l’argomento del sesso era considerato cosí nocivo? Simili obiezioni claudicanti e infantili scoprii poi che erano diffusi luoghi comuni, anche perché nessuna religione è in grado di rispondervi in modo soddisfacente. Ma se ne presentava un’altra e piú ampia. (Dico «se ne presentava» invece di «mi veniva alla mente», perché tali obiezioni sono non solo insuperabili, ma anche ineludibili). Il direttore, che presiedeva alle funzioni religiose e alle preghiere quotidiane brandendo la Bibbia ed era un sadico omosessuale velato (che ho da tempo assolto perché accese in me l’interesse per la storia e mi fece conoscere Wodehouse), ogni pomeriggio impartiva ad alcuni di noi una lezioncina spicciativa. «Adesso magari non riuscite a capire il senso di tutte queste cose della fede, – diceva. – Ma lo capirete un giorno, quando comincerete a perdere i vostri cari».
A queste parole provavo, ancora una volta, una fitta di autentica indignazione e insieme un senso di incredulità. Perché era come dire che la religione poteva non essere vera, ma questo non importava, dal momento che si poteva ricorrere a essa per trovarvi conforto. Assolutamente spregevole. Avevo, all’epoca, quasi tredici anni e stavo diventando un insopportabile piccolo intellettuale. Non avevo mai sentito parlare di Sigmund Freud – sebbene mi sarebbe stato di grande aiuto per capire il direttore – ma stavo giusto dando una scorsa al suo saggio L’avvenire di un’illusione.
Vi sto infliggendo tutto ciò perché non sono di quelli la cui opportunità di attingere la vera fede sia andata distrutta per violenze subite nell’infanzia o per un grossolano indottrinamento. So che milioni di esseri umani hanno dovuto sopportare queste cose e non penso che le religioni possano o debbano essere assolte per averle imposte. (Assai di recente, abbiamo visto la Chiesa di Roma infamata per la sua complicità nell’imperdonabile peccato di pedofilia ovvero, per dirla alla latina, «nessun didietro di bambino deve essere lasciato»2). Ma altre organizzazioni non religiose hanno commesso crimini analoghi, se non peggiori.
Restano ancora quattro inaggirabili obiezioni nei confronti della fede religiosa: distorce completamente le origini dell’uomo e del cosmo; riesce – proprio a causa di tale errore – a combinare il massimo della servilità con il massimo del solipsismo; è sia l’esito che la causa della dannosa repressione sessuale; e, infine, si fonda sulla credenza in ciò che si desidera sia vero.
Non penso di essere presuntuoso se dico di avere scoperto (come di avere notato il fatto piú ovvio e comune, cioè che la religione è utilizzata da chi detiene il potere temporale per ammantarsi di autorità) queste quattro obiezioni prima di cambiare voce. Sono moralmente certo che milioni di persone siano giunte a conclusioni assai simili alle mie e nello stesso identico modo, e da allora ne ho incontrate ovunque nei paesi piú diversi. Molti non hanno mai creduto e molti hanno abbandonato la fede dopo una difficile lotta. Altri hanno avuto folgoranti insorgenze di incredulità, istantanee proprio come Saul di Tarso sulla via di Damasco, per quanto meno epilettiche e apocalittiche (in ogni caso, piú razionalmente e moralmente giustificate). È proprio questo il punto, per quanto riguarda me e chi la pensa come me. La nostra fede non è una fede. Non intendiamo basarci esclusivamente sulla scienza e sulla ragione, perché queste sono elementi necessari piuttosto che sufficienti, ma diffidiamo di qualsiasi cosa contraddica la scienza o offenda la ragione. Possiamo non essere d’accordo su molte cose, ma rispettiamo la libera ricerca, la spregiudicatezza e il perseguimento delle idee per il loro intrinseco valore. Non rimaniamo dogmaticamente attaccati alle nostre idee: il disaccordo tra il professor Jay Gould e il professor Richard Dawkins riguardo all’«evoluzione punteggiata» e ai punti lacunosi della teoria postdarwiniana è ampio e profondo, ma lo si potrà risolvere con prove e ragionamenti e non con reciproche scomuniche. (La mia irritazione nei confronti di Richard Dawkins e di Daniel Dennet, per la loro imbarazzante proposta secondo la quale gli atei dovrebbero presuntuosamente definirsi come «gli intelligenti», rientra in un contenzioso di lunga data). Non siamo immuni dalle lusinghe del meraviglioso, del mistero e del timore reverenziale: abbiamo la musica, l’arte e la letteratura, e troviamo che Shakespeare, Tolstoj, Schiller, Dostoevskij e George Eliot affrontano assai meglio i gravi dilemmi etici che non i miti morali dei libri sacri. La letteratura, e non la Sacra Scrittura, nutre la mente e – visto che non esiste un’altra metafora – l’anima. Non crediamo nel paradiso e nell’inferno, ma nessuna statistica riuscirà a dimostrare che, senza simili blandizie e minacce, commettiamo piú crimini di avidità e violenza dei credenti. (In realtà, se potesse mai essere fatta un’indagine corretta in proposito, sono convinto che sarebbe vero l’opposto). Siamo rassegnati a vivere una volta sola, salvo che tramite i nostri figli, ai quali siamo assolutamente felici di fare spazio. Incliniamo a considerare quanto meno probabile che, una volta accettato il fatto di una vita breve e travagliata, si finirebbe con il comportarsi meglio gli uni verso gli altri, e non peggio. Crediamo senza titubanze che una vita etica possa essere vissuta senza religione. E diamo per ovviamente vero il corollario: che la religione ha fatto sí che innumerevoli individui non solo non si siano comportati meglio degli altri, ma ha concesso loro il permesso di comportarsi in modi che farebbero sollevare il sopracciglio di una tenutaria di postriboli o di un appassionato di pulizia etnica.
E, cosa piú importante di tutte, noi infedeli non abbiamo bisogno di alcun meccanismo di rinforzo. Siamo quelli che Blaise Pascal prese in considerazione quando scrisse a quel personaggio che di sé diceva: «Io sono cosiffatto che non posso credere». Nel paese di Montaillou, durante una delle grandi persecuzioni medievali, gli inquisitori chiesero a una donna di rivelare chi le avesse trasmesso i suoi eretici dubbi sull’inferno e la resurrezione. Certamente sapeva che quei religiosi non le avrebbero risparmiato una lunga agonia, ma, nonostante il terribile pericolo, rispose di non averli appresi da nessuno e di averci pensato da sola. (Spesso, sentirete i credenti lodare la semplicità del gregge cui appartengono, ma non di fronte a una simile spontanea, lucida e cosciente sanità mentale – soffocata e distrutta nel caso di molti piú esseri umani di quanti ne potremo mai citare).
Per noi, non c’è bisogno di riunirsi ogni giorno, o ogni sette giorni, o in occasione di ogni festa o fausta ricorrenza, per proclamare la nostra rettitudine o per umiliarci e voltolarci nella nostra bassezza. Noi atei non abbiamo bisogno di preti, né di gerarchie superiori che vigilino sulla nostra dottrina. Aborriamo i sacrifici e le cerimonie, come le reliquie e la venerazione di qualsiasi immagine o di qualsiasi oggetto (ivi compresa una delle piú utili invenzioni dell’uomo: il libro). Per noi, nessun luogo della terra è piú sacro di un altro, o potrebbe esserlo: all’appariscente stravaganza del pellegrinaggio, o all’assoluto orrore di uccidere i civili in nome di qualche sacro muro o caverna o santuario o roccia, preferiamo contrapporre una tranquilla o anche rapida passeggiata da una sala all’altra di una biblioteca o di una galleria, o pranzare con un amico simpatico, perseguendo la verità o la bellezza. Tali attività, se serie, ci metteranno a contatto con fedi e credenti, dai grandi pittori e compositori religiosi alle opere di Agostino, dell’Aquinate, di Maimonide o di Newman. Questi eminenti studiosi possono aver scritto molte cose sciocche o dannose e avere risibilmente ignorato l’origine microbica delle malattie o la posizione del globo terrestre nel sistema solare, per non parlare dell’universo, e questa è la semplice ragione per cui non rimane piú molto di loro oggi, e ancora meno ne rimarrà in futuro. La religione ha detto le sue ultime parole intelligibili, nobili o ispirate molto tempo fa: sia le une che le altre si sono trasformate in un umanismo ammirevole, ma nebuloso, come nel caso, ad esempio, di Dietrich Bonhoeffer, un coraggioso pastore luterano impiccato dai nazisti perché aveva rifiutato ogni forma di collusione con loro. Questo antico mondo non può piú offrirci né saggi né profeti: oggi, infatti, le forme devozionali non sono che echi ripetitivi del passato, talvolta portati al parossismo per colmare un terribile vuoto.
Esistono apologie religiose a loro modo magnifiche, e in proposito non possiamo dimenticare Pascal (ma in lui c’è qualcosa di cupo e incongruo) e neppure C. S. Lewis, tuttavia lo stile di entrambi mostra una grana comune, e cioè il peso tremendo dello sforzo che debbono affrontare. Quanta fatica per affermare l’incredibile! Gli aztechi dovevano squarciare ogni giorno il petto di un uomo per garantirsi che il sole sarebbe sorto ancora una volta. I monoteisti tormentano la loro divinità molte piú volte, forse per timore che sia sorda. Quanta vanità celiamo in noi – non poi troppo efficacemente, per giunta – per illuderci di essere l’oggetto personale di un piano divino? Quanto amor proprio si deve sacrificare per sentirsi continuamente in colpa nella coscienza dei propri peccati? Quante inutili congetture occorre fare e quanta contorsione ci vuole per accogliere ogni nuova intuizione della scienza e manipolarla in modo che «si adatti» alle parole rivelate di antiche divinità create dall’uomo? Quanti santi, miracoli, concili e conclavi ci vogliono, prima, per stabilire un nuovo dogma e, poi – dopo tanto dolore e tante perdite, e assurdità e crudeltà a non finire –, per abrogarlo? Dio non ha creato l’uomo a propria immagine. Palesemente, è stato l’inverso: è questa la semplice chiave per spiegare sia la profusione di dèi e religioni sia la lotta fratricida tra le religioni e al loro stesso interno, fenomeni visibili ovunque attorno a noi e che tanto hanno ritardato lo sviluppo della civiltà.
Le atrocità religiose passate e presenti non sono state commesse perché siamo malvagi, ma perché è una caratteristica della natura che la specie umana, biologicamente, sia solo in parte razionale. L’evoluzione ha comportato che i nostri lobi prefrontali siano troppo piccoli, le nostre ghiandole surrenali troppo grandi e i nostri organi riproduttivi appaiano come il frutto di un gruppo di lavoro; una ricetta la quale, da sola o in combinazione, quasi sicuramente non può che condurre a una certa infelicità o a un certo disordine. Ma poi, che differenza quando si mettono da parte i contorti credenti e si prendono in mano le opere non meno ardue di un Darwin, ad esempio, o di un Hawking o di un Crick. Questi scienziati, anche quando sbagliano o fanno mostra dei loro inevitabili pregiudizi, risultano piú illuminanti di qualsiasi uomo di fede falsamente modesto il quale cerchi vanamente di far quadrare il cerchio e di spiegare come egli, mera creatura di dio, possa mai conoscerne la volontà. In fatto di estetica le opinioni possono essere le piú varie, comunque noi umanisti laici o atei o agnostici non desideriamo togliere stupori e consolazioni all’umanità. Niente affatto. Se siete disposti a dedicare un po’ del vostro tempo a osservare le mosse immagini ottenute col telescopio di Hubble, vi troverete di fronte cose assai piú strabilianti, misteriose e splendide – e piú caotiche, annichilenti e impervie – di qualsiasi storia creazionista o della «fine dei tempi». Se si legge Hawking sull’«orizzonte dell’evento», quell’ipotetico bordo del «buco nero» sul quale ci si potrebbe in teoria affacciare e vedere il passato e il futuro (a meno che, sfortunatamente o come dato di fatto, non avessimo «tempo» sufficiente), mi sorprenderebbe che qualcuno possa ancora rimanere attonito davanti a Mosè e al suo modesto «roveto ardente». Se si esaminasse la bellezza e la simmetria della doppia elica e si potesse disporre della propria completa sequenza genomica, si resterebbe colpiti dal fatto che un fenomeno quasi perfetto come questo si trovi al centro del nostro essere e, insieme, rassicurati (almeno, lo spero) di avere tanto in comune con le altre genie della specie umana – la n...