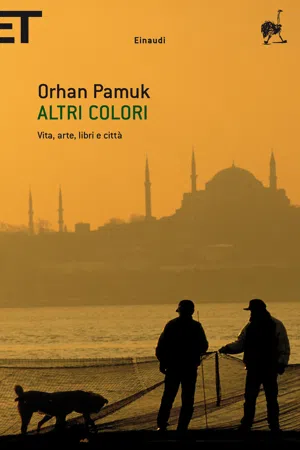![]()
![]()
Scrivo da trent’anni ed è da molto tempo che ripeto questa frase. E a furia di ripeterla ha smesso di essere vera perché siamo arrivati al trentunesimo anno. Ma dire che scrivo romanzi da trent’anni è bello comunque. Ecco, neanche questo è del tutto vero. Ogni tanto scrivo anche altre cose: saggi, recensioni, pensieri su Istanbul o sulla politica, oppure discorsi per incontri come questo… Ma il mio vero lavoro, ciò che mi lega alla vita, è scrivere romanzi… Ci sono scrittori molto brillanti che scrivono da piú tempo di me, da quasi mezzo secolo, senza mettersi in mostra… Scrittori da me amatissimi e che continuo a leggere con ammirazione come Tolstoj, Dostoevskij o Thomas Mann non hanno scritto attivamente per trent’anni bensí per piú di cinquanta… Allora perché parlo dei miei trent’anni? Perché vorrei parlare del mestiere di scrittore, di romanziere, come se parlassi di un’abitudine.
Perché io sia felice è necessario che ogni giorno mi occupi un po’ di letteratura. Proprio come quei malati che quotidianamente devono prendere un cucchiaio di una certa medicina. Quando da bambino ho imparato che per condurre una vita normale i diabetici hanno bisogno di un’iniezione al giorno, mi è dispiaciuto molto per loro. Ho pensato che fossero dei mezzi morti. Anche la mia dipendenza dalla letteratura mi ha trasformato in un «mezzo morto». In particolare, quando ero un giovane scrittore credevo che quanti mi dicevano che ero «distaccato dalla vita» indicassero questo modo di vivere «mezzo morto». Si potrebbe anche dire mezzo fantasma. Mi è capitato di pensare di essere davvero un morto, e di cercare di rianimare il cadavere che avevo dentro attraverso la letteratura. La letteratura mi è necessaria come un farmaco. Come capita a chi ha una dipendenza, la letteratura, che devo «assumere» ogni giorno come una medicina che si prende col cucchiaio o con un’iniezione, ha una dose consigliata e degli effetti collaterali.
Prima di tutto la «medicina» deve essere buona. E con buona intendo dire vera ed efficace. Un brano di romanzo forte, intenso e profondo, in cui credo, che mi rende felice piú di tante altre cose e mi lega alla vita. Preferisco gli scrittori già morti. In modo che l’ombra della gelosia non mi privi del gusto sincero dell’ammirazione nei loro confronti. Piú vado avanti con l’età, piú vedo che i libri migliori sono opera di scrittori ormai morti. Se invece non sono morti, la presenza di questi scrittori straordinari ha qualcosa di simile a quella dei fantasmi. Per questo, quando li incontriamo per strada, ci agitiamo come se avessimo visto uno spettro, non riusciamo a credere ai nostri occhi e li guardiamo da lontano stupefatti. Pochi coraggiosi corrono a chiedere allo spettro un autografo. A volte penso che anche quello scrittore tra un po’ morirà, e i suoi libri avranno un posto migliore nel nostro cuore. Ma naturalmente non sempre è cosí…
Se invece a scrivere sono io, la «dose» di «letteratura» che devo prendere ogni giorno è completamente diversa. Perché nel mio stato la cura migliore, la massima fonte di felicità, è scrivere ogni giorno una buona mezza pagina. Da trent’anni, piú o meno quotidianamente scrivo per dieci ore seduto alla scrivania, in una stanza. Ma quanto ho potuto produrre e pubblicare in questi trent’anni corrisponde mediamente a meno di mezza pagina al giorno. E perdipiú, probabilmente, una mezza pagina un po’ meno «buona» di come avrei voluto. Eccovi due validi motivi per essere infelice.
Ma non vorrei essere frainteso: chi come me è dipendente dalla letteratura non è cosí superficiale da essere felice con i bei libri che scrive, con il loro numero e successo. Chi ne è dipendente non desidera la letteratura per salvarsi la vita, ma soltanto per superare la difficile giornata che sta trascorrendo. I giorni sono sempre difficili. La vita è difficile perché non scrivi. Perché non riesci a scrivere. Ed è difficile anche quando scrivi, perché scrivere è molto difficile. Fra tutte queste difficoltà, l’importante è riuscire a trovare la speranza per far passare la giornata, anzi essere felice e gioire se il libro o la pagina che ti portano in un nuovo mondo sono buoni.
Vi racconto che cosa sento se un giorno non ho scritto bene o non mi sono perso nel conforto di un libro. In breve, per me il mondo si trasforma in un luogo insopportabile e tremendo, e chi mi conosce sa immediatamente che anch’io sono diventato come quel mondo. Per esempio, quando si fa sera mia figlia coglie dall’espressione desolata del mio volto che durante la giornata non ho potuto scrivere bene. Glielo vorrei nascondere ma non mi riesce mai. In questi brutti momenti penso che vivere o non vivere sia la stessa cosa. Non ho voglia di parlare con nessuno, e chi mi vede in quello stato non ha voglia di parlare con me. Questo umore in realtà comincia ad avvolgere lentamente il mio animo ogni giorno fra l’una e le tre di pomeriggio, ma dato che ho imparato a usare la scrittura e i libri come una medicina, mi salvo senza diventare completamente il cadavere di me stesso. Se capita che per lunghi periodi non posso prendere la mia medicina che sa di inchiostro e carta perché sono in viaggio o, come è accaduto in passato, a causa del servizio militare o perché devo andare a pagare la bolletta del gas o, come è successo di recente, per questioni politiche o chissà per quanti altri impedimenti, sento che l’infelicità mi trasforma in una specie di uomo di cemento. Non riesco a muovere nessuna parte del corpo, le mie articolazioni non funzionano, la testa si fa di pietra e sembra che il mio sudore abbia un odore diverso. Questa infelicità può durare a lungo: la vita infatti è piena di castighi che ci allontanano dalle consolazioni della letteratura. Partecipare a un’affollata riunione politica, chiacchierare con gli amici nel corridoio della facoltà, trovarsi a pranzo con i parenti in un giorno di festa, la conversazione forzata con una brava persona distratta e rintronata dalla televisione, un appuntamento di «lavoro» organizzato tempo prima, un incontro di famiglia durante le festività, una banale uscita per fare la spesa, andare dal notaio, fare una fototessera per ottenere un visto, sono tutte attività durante le quali gli occhi mi si appesantiscono e mi viene sonno, proprio nel cuore della giornata. Quando sono lontano da casa e mi è impossibile tornare nella mia stanza e rimanere solo, l’unica mia consolazione è addormentarmi in pieno giorno.
Sí, forse ciò di cui ho bisogno non è la letteratura ma rimanere solo in una stanza e fantasticare. Allora comincio a sognare cose bellissime su tutti quei luoghi affollati, sulle riunioni famigliari e scolastiche, sui pranzi con i parenti nei giorni di festa e sulle persone che vi partecipano. Durante quegli affollati pranzi fantastico sulle persone che siedono intorno a me e le rendo piú divertenti. Nella mia immaginazione tutto diventa interessante, attraente e vero. Parto da questo mondo noto e comincio a immaginarne uno nuovo. Cosí siamo arrivati al nocciolo della questione. Per scrivere in modo soddisfacente devo annoiarmi per bene, e per annoiarmi per bene devo immergermi nella vita. Quando sono proprio in mezzo a tutto quel frastuono, agli uffici, alle telefonate, all’amore, all’amicizia, su una spiaggia assolata o a un funerale in una giornata piovosa, quando cioè sto per entrare nel cuore degli eventi, sento improvvisamente di trovarmi al loro margine. Comincio a fantasticare. Se siete pessimisti potete pensare di annoiarvi. In entrambi i casi, una voce interiore vi suggerisce: «Torna nella tua stanza e siediti alla scrivania!» Non conosco i metodi degli altri, ma quelli come me diventano scrittori in questo modo. So che non è un metodo adatto alla poesia, ma solo alla prosa, al racconto e al romanzo. E questo ci fornisce ulteriori informazioni sulle caratteristiche della medicina che devo prendere ogni giorno. Dalla densità della medicina si capisce che deve essere abbondantemente alimentata sia dalla vita sia dalla forza dell’immaginazione.
Questo ragionamento, che faccio provando il piacere di confessarmi e la paura di dire la verità su me stesso, conduce a una conclusione importante e seria che voglio affrontare subito. Una breve teoria del romanzo in cui si affronta la scrittura come «medicina» e consolazione: come me, alcuni romanzieri scelgono l’argomento e lo stile delle loro opere secondo l’estro del giorno. Sappiamo tutti che i romanzi si scrivono con tanti pensieri, entusiasmi, rabbia e desiderio. A muoverci sono, apertamente o meno, diversi motivi: il desiderio di compiacere chi amiamo, il disprezzo per qualcuno che ci fa arrabbiare, la voglia di parlare di una cosa che ci piace, il gusto di far finta di conoscere qualcosa che non conosciamo affatto, la gioia di ricordare o non ricordare, il desiderio di essere amati e di essere letti, l’ambizione politica, la curiosità e le manie personali, e tanti altri impulsi incomprensibili o assurdi… ci sono sempre fantasie di cui vogliamo parlare grazie a questi spunti. Non sappiamo bene cosa siano queste fantasie e questi spunti che ci trascinano, ma quando scriviamo, vogliamo che ci scuotano, come un vento di cui ignoriamo l’origine. Ci lasciamo addirittura andare un poco a questi oscuri sproni, proprio come un navigante che non sa dove sta andando… Ma una parte della nostra mente sa sempre dove ci troviamo sulla mappa e dove vogliamo arrivare. Nei momenti in cui mi arrendo quasi completamente al vento, rispetto ad altri scrittori che conosco e ammiro riesco piú o meno a prevedere il punto verso il quale mi sto dirigendo. Subito progetto e suddivido in sezioni la storia che voglio raccontare, decido in quali porti debba entrare la mia nave e quali merci debba caricare o scaricare; prima che la mia nave salpi, calcolo la durata del viaggio tappa per tappa e segno tutto sulla mia mappa. Ma quando le vele si gonfiano per un vento imprevisto, non mi oppongo alle virate della mia storia. In realtà, ciò che la nave con le vele tese cerca è un senso di pienezza, di perfezione. Mi sembra di essere alla ricerca di quel particolare luogo e tempo in cui tutte le cose si toccano, sono in contatto, sanno l’una dell’altra. Poi pian piano il vento si placa e allora mi ritrovo in un luogo calmo e tranquillo. Sento che in queste acque nebbiose e quiete c’è qualcosa che guida lentamente la mia nave… Per quanto riguarda l’ispirazione poetica, vorrei sempre che mi capitasse quello di cui parlo nel mio romanzo Neve. Una forma di ispirazione che Coleridge dice di aver vissuto quando scrisse la poesia intitolata Kubla Khan… Vorrei anch’io che alcune scene e situazioni del romanzo mi arrivassero in forma di ispirazione drammatizzata (proprio come accadeva a Coleridge o a Ka, il protagonista del mio romanzo). Se si aspetta con pazienza e attenzione, può accadere. Scrivere romanzi significa essere aperti a questi stimoli, ai venti, agli attimi d’ispirazione, ai luoghi bui della mente e ai tempi di quiete nebbiosa.
E il romanzo è un racconto che accoglie questi venti, risponde alle diverse forme d’ispirazione e unisce in modo significativo tutti i sogni che vogliamo sognare. Ma, soprattutto, il romanzo è allo stesso tempo un cesto che raccoglie un mondo di sogni che vogliamo tenere sempre vivo e pronto. Sono i romanzi a unire i frammenti di fantasia che ci aiutano a dimenticare la noia del nostro mondo. «A forza di scrivere» sviluppiamo questi sogni e rendiamo questo secondo mondo piú ampio e completo. Conosciamo questo nuovo mondo man mano che scriviamo, e conoscendolo diventa facile tenerlo a mente. Se sono a metà di un romanzo e sto scrivendo bene, riesco a entrare molto facilmente tra i sogni di questo secondo mondo. I romanzi sono territori nuovi dove si entra facilmente leggendo, ma ancora piú facilmente scrivendo. Sono modellati per portare agevolmente i sogni che i romanzieri vogliono sognare. Cosí come regalano felicità al buon lettore, allo stesso tempo offrono al buon scrittore un nuovo mondo solido e sicuro dove può rifugiarsi ed essere felice a ogni ora della giornata. Quando riesco ad abbozzare un universo tanto meraviglioso, mi sento felice appena mi avvicino alla scrivania, ai fogli già scritti. In un attimo esco dal mondo normale e passo in quest’altro territorio vasto e libero, da cui a volte non desidero piú tornare. Non vorrei mai che questo secondo mondo in continua evoluzione finisse, e non vorrei arrivare alla fine del mio romanzo. La mia sensazione è paragonabile all’augurio del lettore che sa che sto scrivendo un nuovo romanzo: «Per favore, questo lo faccia lungo!» Mi vanto di aver sentito piú spesso questa frase che l’augurio tipico degli editori mediocri: «Mi raccomando: lo faccia corto!»
Com’è possibile che il prodotto di un’abitudine volta ai piaceri e alla felicità personali di un individuo possa attirare l’attenzione di cosí tanta gente? Coloro che hanno letto Il mio nome è rosso ricorderanno che alla fine del romanzo Şeküre dice che sarebbe stupido mettersi a spiegare tutto. Anch’io la penso come lei, e non come il mio omonimo, il piccolo Orhan, che la madre in qualche modo disprezza. Ma se permettete, faccio di nuovo una cosa stupida e mi comporto come Orhan, raccontandovi come mai i sogni, che sono medicine per lo scrittore, diventano farmaci anche per gli altri. Se sono completamente assorbito dal romanzo e scrivo bene, se cioè sono riuscito ad allontanarmi da fastidiose telefonate, domande, esigenze e noie della vita quotidiana, le regole del paradiso libero e privo di gravità dove arrivo attraverso il mio romanzo mi fanno venire in mente i giochi della mia infanzia. Sembra che tutto diventi piú semplice, e dentro questa semplicità le case hanno gli interni a vista perché sono di vetro, esattamente come le auto, le navi, i palazzi, e allora cominciano a sussurrarmi i loro segreti. Il mio lavoro consiste nel cogliere queste regole grazie all’intuizione, nell’ascoltarle, e poi osservare con piacere gli interni delle case, e girare Istanbul insieme ai miei eroi in autobus o in macchina. E quando mi annoio, cambiare d’istinto le cose che vedo, divertirmi spensieratamente, imparare qualcosa mentre mi diverto, proprio come fanno i bambini. L’aspetto piú bello del mestiere dello scrittore, se sei un autore creativo, è poterti dimenticare del mondo come fa un bambino, sentirti leggero mentre giochi felice, trastullarti con le regole del mondo come fossero giocattoli e nel frattempo sentire l’esistenza di una profonda responsabilità dietro questa infantile e libera gioia che piú tardi avvolgerà completamente i lettori. Si può giocare tutto il giorno, ma sentirsi molto piú seri di chiunque altro. Prendere sul serio l’essenza e l’immediatezza della vita con un’ingenuità propria dei bambini. Quando stabilisci con coraggio le regole del gioco che tu stesso organizzi, puoi sentire che i lettori saranno attratti dal fascino del tuo linguaggio, delle tue frasi e della tua storia e cosí ti seguiranno. Il mestiere di scrivere è la capacità di far dire al lettore: «L’avrei detto anch’io, ma non sono riuscito a essere cosí bambino».
A volte non riesco a tornare all’innocenza infantile di questo mondo che scopro fantasticando, spiegando le vele a venti imprevedibili e guardando la mappa che in un secondo tempo ho costruito e sviluppato. Questo può accadere a tutti gli scrittori. In altre parole, a volte mi blocco in un punto, o dopo una pausa non riesco piú ad andare avanti. In questi casi, forse, provo meno fastidio rispetto ad altri scrittori, perché posso tornare alla mia storia da un’altra strada rispetto al punto in cui ero rimasto, e dato che studio bene la mia mappa, posso continuare il romanzo per un’altra via. Ma non è cosí importante. Quest’anno, quando ho incontrato una difficoltà del genere mentre ero preso da alcuni guai politici, mi sono reso conto di avere scoperto qualcosa di nuovo sui romanzi. Tenterò di spiegarvelo.
Un processo contro di me, la situazione politica in cui mi trovavo, mi avevano reso una persona piú «politica», «seria» e «responsabile» di quanto desiderassi. Posso dire sorridendo che la situazione era triste e il mio stato d’animo ancor piú triste. E non riuscivo a trovare l’innocenza infantile necessaria a scrivere… Era una cosa comprensibile, e infatti non mi stupivo piú di tanto. Pensavo che col tempo le cose si sarebbero appianate e io sarei tornato alla «irresponsabilità», al gioco infantile e all’ironia che avevo temporaneamente perduto, e avrei finito il romanzo che stavo scrivendo da tre anni. Eppure, ogni giorno, prima che i dieci milioni di abitanti della città dove vivo, Istanbul, si svegliassero, mi sedevo alla mia scrivania e nel silenzio della notte cercavo di entrare il piú presto possibile nel romanzo rimasto in sospeso. Mi obbligavo a scrivere e cercavo di entrare in quel secondo amato mondo. Dopo questi sforzi titanici, vedevo passare per la mente le parti di un romanzo che avrei voluto scrivere… Ma non erano i capitoli del romanzo che stavo scrivendo: appartenevano a un romanzo completamente diverso. In quei giorni di angoscia e malinconia, scene, frasi, protagonisti, strani dettagli di un romanzo completamente diverso da quello che stavo scrivendo da tre anni si moltiplicavano e mi venivano incontro… Dopo un po’, ho cominciato ad appuntare su un quaderno brani e dettagli mai concepiti prima di questo romanzo. Sarebbe stata la storia di un pittore contemporaneo non vivente… Mi venivano in testa pensieri sul pittore e le sue opere. In quei giorni di angoscia, dopo un po’ mi resi conto di non riuscire a tornare a una leggerezza infantile. Non riuscivo a tornare all’infantilismo, ma soltanto ai giorni della mia infanzia, quando sognavo di diventare pittore e disegnavo di continuo (come racconto in Istanbul).
Poi il processo contro di me non ebbe luogo e io tornai al mio vero romanzo intitolato Il Museo dell’innocenza. Oggi fra i miei progetti c’è anche quello di scrivere il romanzo che mi veniva in mente scena per scena nei giorni in cui non riuscivo a tornare allo stato d’animo della mia infanzia, ma solo ai suoi stimoli. Comunque questa esperienza mi ha dato la possibilità di imparare una cosa sulla dimensione spirituale dello scrivere romanzi.
Posso illustrarla usando il concetto di «lettore implicito» del critico e teorico letterario Wolfgang Is...