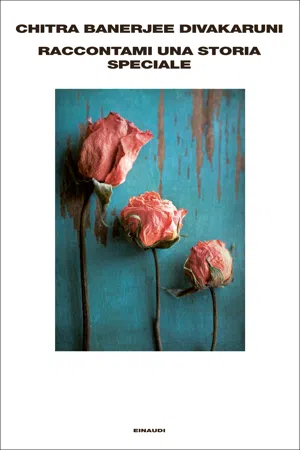![]()
Fu come se il gigante nascosto nelle viscere della terra si fosse sentito chiamare da Cameron. Prima che il veterano riuscisse a concludere la frase, prima che i suoi ascoltatori avessero il tempo di confrontare le proprie storie con la sua, prima che avessero modo di provare ammirazione, dolore o gratitudine, l’edificio tremò e gemette. Qualcosa si schiantò al piano superiore e il soffitto sopra le loro teste ondeggiò come se fosse fatto di carta.
– Scossa di assestamento! – gridò una voce. Ci fu chi si mise a urlare. Altri piangevano. Qualcuno cominciò un’enigmatica preghiera: – Dio, fa’ che finisca, fa’ che finisca in fretta! – Saltando nell’acqua per raggiungere il vano di una porta, Uma si domandò cosa intendesse implorare esattamente quella supplica: la fine del terremoto, quella della loro prigionia o delle loro vite? «Aspetta un minuto, – avrebbe voluto protestare. – Io non ho ancora raccontato la mia storia».
Nel vano in cui si rifugiò c’era soltanto una persona oltre a lei: il signor Pritchett, che aveva abbandonato lo scialle prestatogli da Tariq e, rimasto in biancheria intima, tremava di freddo. Cosí spogliato, le apparve assai piú gracile di quanto l’avesse giudicato all’inizio. Si reggeva a entrambi gli stipiti tenendo le braccia aperte, esili e nodose come quelle dei vecchi martiri cristiani raffigurati nei dipinti medievali. Uma fu costretta a chinarsi sotto l’ascella dell’uomo per mettersi al riparo. L’acqua le arrivava a metà delle cosce e, appena i muri cessarono di oscillare, si rese conto di avere le gambe intorpidite dal freddo, nonostante le fitte roventi che continuavano a pulsarle su per il braccio. Pensò per un attimo di immergerlo nell’acqua ma poi notò che ci sarebbe dovuto essere un terzo componente del gruppo lí con loro. Scrutando nell’oscurità, comprese chi mancava all’appello e lo chiamò per nome: – Cameron! Cameron!
L’ex militare giaceva rannicchiato sulla scrivania in posizione fetale. Somigliava al bambino non ancora nato apparso nei suoi sogni, pensò Uma. Quando Cameron la udí, aprí gli occhi e la fissò con un identico sguardo infantile privo di rimprovero. Durante la scossa aveva tenuta ben stretta la torcia, che conteneva le ultime pile di cui disponevano, e ora sollevò adagio il pugno, quasi per esprimere l’intenzione di conservarla al sicuro finché non avesse potuto consegnarla a lei. Sebbene ci fossero frammenti di intonaco a coprire il tavolo e punteggiargli il volto e le braccia, Cameron sembrava illeso.
Uma si diresse verso la scrivania riattraversando l’acqua nera, la loro Mnemosine, il lago della memoria capace di carpire persino i segreti piú gelosamente custoditi. Il soffitto aveva l’aria di reggere ma anche in caso contrario Uma non sopportava l’idea di lasciare solo Cameron. Sarebbero morti tutti comunque, a meno che non fosse accaduto presto qualche miracolo. Quando circondò l’uomo con un braccio, gli sentí il corpo piú freddo del normale: ma cosa c’era ormai di normale? Il cuore gli batteva in petto come il frullo d’ali di un uccellino preso al laccio. Uma avvertiva il sibilo che emetteva a ogni respiro. Cameron le rivolse un debole, pallido sorriso. Di fronte al suo silenzio, le frasi sulla speranza e sul perdono che progettava di dirgli le parvero insulse. E poi, che diritto aveva lei di parlare? Non aveva forse fatto torto alle persone che le stavano piú a cuore? A Ramon, amandolo meno di quanto lui la amasse; alla madre, rifiutandosi di ascoltare i suoi inviti alla cautela; al padre, respingendolo quando piú aveva bisogno di confidarsi con qualcuno. «Perdonatemi», li implorò dentro di sé. Ma questo non le diede lo stesso conforto di un abbraccio alle morbide membra materne, o di una carezza su una guancia resa sexy dalla barba cresciuta durante la notte, o dell’abbandonarsi su un petto non piú muscoloso, aspirando il caratteristico aroma, familiare sin dall’infanzia, della colonia Old Spice.
La scossa di assestamento sembrava finita. Altri si avventurarono a uscire dai vani delle porte per verificare i danni, sbirciando il soffitto con aria preoccupata. Jiang, che aveva il viso arrossato e febbrile, consigliò a Uma di mettere Cameron in posizione eretta per agevolargli il respiro. Lily la aiutò a raddrizzarlo. L’odore di gas era senza dubbio piú forte, ma nessuno fece commenti in proposito. Tornarono tutti a inerpicarsi sulle scrivanie, sollevando anche le gambe e cercando di asciugarsele con gli stracci che un tempo erano stati un sari colorato di speranza. Mangalam controllò il livello dell’acqua e disse che a quel ritmo nel giro di un’ora avrebbe raggiunto l’altezza dei tavoli; per rimanere all’asciutto, sarebbe stato necessario recuperare le sedie dall’altro lato della stanza e sistemarle sulle scrivanie. Su ciascuna c’era posto per due sole sedie. Perciò tre di loro avrebbero dovuto trasferirsi nel suo ufficio, dove il tavolo aveva un ripiano piú grande. Ma prima che il gruppo si dividesse, restava abbastanza tempo per l’ultima storia.
– Quando me ne andai da casa per frequentare l’università, – cominciò Uma, – non sentii affatto la mancanza dei miei. Suppongo mi si potesse definire egocentrica e insensibile, come molti giovani. Mia madre ne soffriva, ma mio padre…
Prima che avesse modo di continuare la cronaca delle sue perfidie filiali, echeggiarono dei rumori dall’alto. Tutti si rannicchiarono impauriti, ma quelli che si udivano non erano i boati di una scossa sismica. Ci furono colpi e picchiettii, e un fracasso come di mobili rovesciati. Ai nove compagni parve di percepire il rombo di un motore mandato su di giri, lo sbattere di una porta.
– Sono persone! – esclamò Tariq. – Soccorritori! – Ognuno sollevò lo sguardo, con espressioni combattute tra l’esultanza e l’incredulità. Si strinsero le braccia a vicenda. Lily e la signora Pritchett portarono alla bocca le mani a coppa e gridarono per invocare aiuto; gli altri le imitarono. Nessuna risposta. Il fragore si affievolí, come se si stesse allontanando. Un grosso pezzo di intonaco cadde nell’acqua, spaventando il gruppo e riducendolo al silenzio.
Tariq si alzò in piedi sul tavolo, allungando il collo per vedere qualcosa attraverso la fessura nel soffitto. Ma si trovava nel punto sbagliato. – Vado dall’altra parte del divisorio, – annunciò. – Voglio salire su una sedia o su qualche altro sostegno per capire cosa sta succedendo –. Saltò giú, spruzzando acqua in tutte le direzioni.
– Vengo con lei, – disse Mangalam, impugnando la torcia. – Potremmo legare un pezzo di stoffa a un bastone e sventolarlo attraverso il foro.
Pritchett, infilatosi a fatica i pantaloni, si affrettò ad accodarsi ai due. Anche Uma desiderava unirsi a loro, ma Cameron era appoggiato al suo braccio sano e lei non voleva disturbarlo.
– Bisogna avvertirli, – sussurrò il veterano. – C’è un cadavere nell’acqua, caduto dal piano di sopra quando è crollato il soffitto –. Uma lo scrutò in preda allo shock. Fino a quel momento, accettando la possibilità della propria scomparsa, credeva di aver compreso il significato della morte: invece si era limitata a raffigurarsela in astratto. L’inesorabile presenza di quel corpo ad appena quindici metri da lei, gonfio, rigido e già in via di decomposizione, rendeva la fine un tangibile orrore.
Cameron le diede un colpetto per riscuoterla. – Non gridi… rischierebbe di scatenare il panico. Li segua. Io me la caverò.
– Vada, ci penso io a lui, – disse Malathi, seduta dal lato opposto dell’ex militare. Uma sentí il braccio saldo e adorno di braccialetti della giovane donna cingere la schiena di Cameron. Provò un senso di umiltà per la calma con cui Malathi affrontava quella macabra notizia.
Il pensiero di entrare nell’acqua in cui giaceva il cadavere riempí Uma di repulsione, ma Cameron stava aspettando. Scese con cautela, senza riuscire a reprimere i brividi. Aggirò la parete divisoria e si fermò ai margini della stanza. Pritchett era là, chino a sgomberare dai detriti la zona situata esattamente sotto lo squarcio del soffitto crollato. Il morto, ipotizzò Uma, doveva essere atterrato proprio in quel punto. Immaginò la greve caduta. Sperò che fosse spirato prima di precipitare, che non gli fosse toccato in sorte di affogare in quella liquida tenebra. Tariq e Mangalam stavano trascinando un divano attraverso l’acqua. Intendevano posizionarlo in verticale. Poi uno di loro ci sarebbe montato sopra mentre gli altri lo sorreggevano.
– Dopo che avrò liberato un po’ di spazio qui, ci occorrerà un bastone a cui legare la stoffa, – disse Pritchett. – Potete darmi una mano? – Infilò il braccio sott’acqua.
– Fermo! – proruppe Uma. – Si allontani da lí! – Troppo tardi. Nel fascio luminoso della torcia che Mangalam le aveva passato, vide lo shock dipingersi sul volto di Pritchett. L’acqua scura schizzò verso l’alto mentre l’uomo lasciava cadere qualcosa di pesante e indietreggiava. Uma lo sentí tossire in preda ai conati di vomito e incespicare nel buio. Udí un secondo tonfo. Strinse i denti e si affrettò a oltrepassare il cadavere per raggiungere il compagno.
– L’ho toccato, – le disse Pritchett tra un ansito e l’altro, mentre lei cercava di rimetterlo in piedi.
– Sssh. Va tutto bene, – gli disse. Gli massaggiò la schiena.
– Cos’è successo? – domandò Tariq dal lato opposto della stanza. Quando Uma glielo ebbe spiegato, il giovane mollò l’estremità del divano e imprecò.
Mangalam sembrava il meno turbato di tutti. Anzi, dava addirittura l’impressione di essere piú calmo di prima. Il declino di Cameron l’aveva costretto ad assumersi le responsabilità che gli spettavano fin dall’inizio. – Possiamo evitare quella zona, – affermò. – Sistemiamo il divano qui. Non ci permetterà di vedere altrettanto bene, ma basterà allo scopo. Dobbiamo sbrigarci. Se c’è qualcuno lassú, finirà per andarsene se non gli facciamo sapere che siamo intrappolati qui sotto. Signor Pritchett, abbiamo bisogno di lei per sorreggere il divano. Uma, prenda quell’asta accanto alla parete.
Cosí riorganizzati, i membri del gruppo seguirono le sue indicazioni. Uma era in grado di agire, si rese conto, se si concentrava sul compito da svolgere e non pensava all’acqua che fluiva dal cadavere fino a lei, contaminandola con la corruzione della morte. Nel giro di pochi minuti sollevarono il divano in verticale. Tariq vi si inerpicò, spinse l’asta piú su che poteva attraverso il foro e agitò con energia la rudimentale bandiera. Uma illuminò la stoffa blu con la luce della torcia. I quattro gridarono per invocare aiuto e dalla stanza attigua i compagni unirono le proprie voci alle loro, come in un coro stigio. Caddero nuovi frammenti d’intonaco, ma i nove superstiti continuarono. Cos’avevano da perdere? Echeggiò dall’alto un forte boato, una specie di esplosione. Poi piú nulla. Quando, con la gola in fiamme, furono sicuri di non percepire piú alcun rumore, rinunciarono, uno alla volta. Ci fu chi singhiozzò per un poco. Altri rimasero seduti senza parole, affranti. Quei minuti di speranza, concessi solo per essere revocati subito dopo, erano lo scherzo piú crudele del destino, l’oltraggio finale.
Le pile si stavano esaurendo. Nel bagliore sempre piú fioco della torcia, Uma vide i compagni accasciati e chiusi in se stessi, restii a incrociare gli sguardi altrui, con le mani strette a pugno al proprio fianco o sollevate a coprirsi la faccia. Mangalam tirò fuori la bottiglia di scotch, che conteneva ancora un po’ di liquore, e la offrí agli altri. Un paio di persone ne bevvero un sorso di malavoglia, ma neppure la magia dell’alcol riuscí a rianimarle piú di tanto. Respirare era sempre piú difficile. A Uma tornò in mente una vecchia lezione di scienze imparata alle medie. Il gas uccide sostituendosi all’ossigeno, piú leggero. Appena il seminterrato si fosse riempito con una sufficiente concentrazione di gas, sarebbero morti soffocati.
Troppi problemi, tutti al di là della sua portata. Non c’era altro da fare che riprendere la storia.
Quando venne il momento di iscriversi all’università, ne scelsi una lontana da casa, pur sapendo che i miei avrebbero preferito una soluzione diversa. Non perché avessimo un cattivo rapporto, né perché papà e mamma fossero dei tiranni, come a volte capita con i genitori immigrati dall’India. Ero semplicemente ansiosa di cavarmela da sola, libera dalla loro presenza protettiva. Non avevo mai pensato che la mia presenza potesse essere altrettanto protettiva per loro. Il college al quale mi iscrissi si trovava in Texas: un costoso istituto privato, con una fama di cui un padre e una madre potevano andare fieri. Ma la maggiore attrattiva per me era la sua distanza dalla nostra città.
La mamma soffriva per la mia assenza. Malgrado fosse una manager di successo, con una posizione piuttosto elevata nell’azienda, si considerava soprattutto una madre e una casalinga, e si inorgogliva di piú per una cena indiana cucinata da cima a fondo che per l’acquisizione di un nuovo cliente. Nel primo mese di università, si scioglieva in lacrime a ogni telefonata, e insisteva per conoscere i minimi particolari della mia vita quotidiana. Papà la esortava a controllarsi. Si limitava a domande brevi ed essenziali, lui (come stavo di salute, se ce la facevo a tenere il passo, se avevo bisogno di soldi), e si accontentava di risposte monosillabiche. Concludeva invariabilmente la conversazione con una battuta sui miei futuri fidanzati (quasi sempre la stessa battuta), mentre la mamma protestava dall’altro apparecchio. Io provavo un senso di gratitudine per la disinvoltura dimostrata da mio padre nell’affrontare la nostra lontananza. Ammiravo i suoi modi garbati. Fino ad allora mi ero sentita piú vicina a mia madre, ma cominciavo a percepire un sottile mutamento nelle mie preferenze.
La popolazione studentesca dell’università era diversa da quella della scuola superiore, ma non in modo drastico. Mi piaceva il campus, con il suo rigoglio di vegetazione tropicale e l’eleganza tipica del Sud; amavo la stanza singola che occupavo nel dormitorio e che potevo decorare secondo le mie inclinazioni; mi piaceva partecipare ai piccoli convegni di letteratura, durante i quali famosi professori mi trattavano da adulta, malgrado nel profondo di me stessa non fossi sicura di esserlo; mi divertivo nei caffè aperti fino alle due di notte, dove gli studenti si misuravano in accalorati dibattiti, e alle feste, disponibili in versione piccante, media e blanda. La cautela di mia madre doveva avermi contagiata, perché tendevo a scegliere i piaceri piú innocui.
Una sera, a semestre iniziato da un paio di mesi, mi telefonò mio padre, un caso raro da molti punti di vista, anche se ne rilevai la stranezza solo in retrospettiva. Le chiamate di famiglia erano riservate ai fine settimana, quando si poteva parlare gratis al cellulare. In genere era la mamma a prendere l’iniziativa. Per di piú, essendo appena le cinque in California, papà, abituato a fermarsi al lavoro fino a tardi, mi stava chiamando dall’ufficio.
Non era mai stato il tipo da perdere tempo con i preamboli. – Adesso che ti sei ambientata al college e hai superato cosí bene le prove di metà semestre, – cominciò, – posso confidarti una cosa. Intendo chiedere il divorzio. Tua madre e io non abbiamo piú niente in comune a parte te, e tu hai già imboccato con successo la tua strada –. Si interruppe per un attimo, e io mi chiesi (quasi stessi parlando con un estraneo) come si sentisse. Se fosse nervoso.
– Per tutta la vita ho fatto ciò che gli altri si aspettavano da me, – continuò. – Il tempo che mi rimane, poco o tanto che sia, vorrei viverlo a modo mio. Hai qualche domanda?
Capii che non si era reso conto di quanto suonasse comica la sua ultima frase. Avevo voglia di ridere, ma temevo che se avessi cominciato non sarei piú riuscita a smettere. Evidentemente lui dedusse dalla mia pausa che non avevo nulla da chiedere, perché proseguí con il proprio discorso.
– Non ho ancora detto niente a tua madre. Ti chiederei di non telefonarle finché non avrò avuto l’occasione di annunciarle la notizia. Lo farò la prossima settimana –. Divenne consapevole del mio silenzio e soggiunse: – Sono sicuro di averti turbata ma cerca di vedere la situazione dal mio punto di vista. È giusto pretendere che rimanga prigioniero di un rapporto che mi sta uccidendo? – Mentre io riflettevo sulla scelta di quest’ultimo gerundio, lui mi salutò con la promessa di richiamarmi per un aggiornamento sugli sviluppi.
Dopo aver riagganciato, mi coricai, sforzandomi di capire cosa fosse appena accaduto. Per qualche istante mi domandai se non avessi sognato la conversazione con mio padre. Per tutti quegli anni mi ero sentita sicura, con la noncuranza con cui sorvoliamo sulle certezze assolute delle nostre vite, che il matrimonio tra i miei genitori fosse solido e felice. Avevano affrontato con entusiasmo le attività comuni: farmi crescere, invitare ospiti, viaggiare, andare al cinema, curare il giardino. Entro i limiti imposti dalle loro culture d’origine, si scambiavano segni d’affetto, baciandosi al mattino prima di recarsi al lavoro, tenendosi stretti nelle fotografie, ammirandosi a vicenda se indossavano un abito nuovo, sedendosi vicini sul divano ad ascoltare i cd del Rabindra Sangeet. Leggevano spesso insieme su quel divano: mio padre posava il capo in grembo a mia madre mentre sfogliava le pagine di «Time», e mia madre gli carezzava distrattamente il capo, assorta nella trama di un romanzo bengalese.
Non era amore, questo? Se lo era (e ci avrei scommesso la testa), come aveva fatto a disintegrarsi cosí da un giorno all’altro? Qualsiasi cosa al mondo poteva finire distrutta con uguale subitaneità? A che scopo, allora, mettere tanto impegno e passione in un’iniziativa qualunque?
In mezzo a quelle questioni metafisiche, affioravano ogni tanto uno o due interrogativi di stampo ...