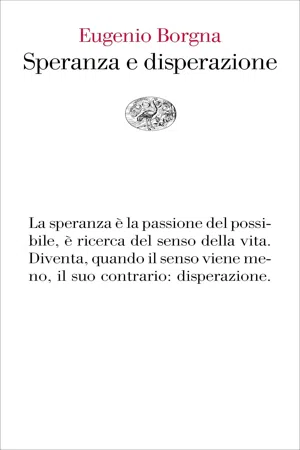
- 120 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Speranza e disperazione
Informazioni su questo libro
La speranza ci consente di vedere la realtà con occhi non annebbiati e non oscurati dalle esteriorità e dalle consuetudini, dalle convenzioni e dalle ripetizioni, e ci consente di aprirci al futuro, liberandoci dalla ostinata prigionia del passato e del presente. Eugenio Borgna traccia un lucido percorso attraverso le tappe della letteratura, da una parte, e del suo lavoro di psichiatra, dall'altra, sul concetto di speranza. Essa è fragile ma è l'unica via per liberare l'essere umano dalla solitudine e dagli abissi dell'anima. In perenne ascolto dei suoi pazienti e in dialogo serrato con Cesare Pavese, ricostruisce l'esile figura di una delle forze piú rivoluzionarie della vita.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
PARTE PRIMA
La speranza come infinita ricerca di senso
Le premesse
Gli orizzonti di senso della speranza sono infiniti, e non è facile descriverla e coglierla nei suoi diversi modi di essere, ma vorrei dire subito che se la speranza non ha una dimensione dialogica, aperta agli altri e al mondo della vita, non è speranza. Siamo tutti affascinati da quello che avviene nell’istante, e nella illusione di non perdere tempo la nostra vita quotidiana naufraga sugli scogli di un presente svuotato di passato e di futuro, di memoria e di speranza. Non si può vivere senza speranza. Le parole sfolgoranti di Giacomo Leopardi rinascono senza fine in noi, e ci aiutano a non smarrire, o a ritrovare, il cammino della salvezza, anche quando l’angoscia scende sulla nostra vita.
La speranza è declinazione esistenziale, immaginazione e destino, che dischiude dinanzi a noi un futuro non mai prevedibile, e non mai programmabile. La psichiatria è passione delle differenze, e non può non indurci a distinguere la speranza dall’ottimismo, che si illude di orientare il futuro lungo il sentiero dei nostri desideri e delle nostre aspirazioni, non riconoscendone mai il mistero. Noi siamo relazione, e abbiamo il compito, che è un dovere, di dire parole che non feriscano le speranze delle persone con cui ci incontriamo, o con cui abbiamo relazioni di cura. Le parole sono creature viventi, il loro contenuto ha ovvia radicale importanza, e nondimeno la tensione emozionale, l’apertura alla speranza, ne cambia i significati; e la speranza è come un ponte che ci fa uscire dalla solitudine, e ci mette in una relazione senza fine con gli altri, con gli altri che hanno bisogno di un aiuto, e talora solo di un sorriso, o di una lacrima, di un saluto che nasca dal cuore. La speranza è anche dovere, ricerca infinita di senso, e di essa dovremmo saper cogliere il valore reale, autentico, del tutto individuale, diverso in ciascuno di noi.
Affascinato dalla speranza.
Da molti anni, dagli anni in cui lavoravo nel manicomio di Novara, sulla scia delle esperienze vissute dalle mie pazienti, ascoltate senza fine nella loro tristezza e nella loro angoscia, nei loro smarrimenti e nella loro disperazione, sono affascinato dal tema della speranza, delle sue eclissi e delle sue rinascite, e nondimeno non finisco mai di riflettere su questo tema che oggi ritrova aree sempre piú vaste di interesse non solo in psichiatria, ma anche in altre discipline mediche e nell’area delle neuroscienze. Nel ripensare a questi nuovi svolgimenti del tema della speranza vorrei ricordare che escono libri che la definiscono una medicina, e sostengono che le parole possono vincere la malattia; e allora i sentieri, che ho percorso in questi lunghi anni di riflessione su aree tematiche, come sono state quelle della solitudine e del silenzio, della colpa e della nostalgia, della fragilità e della responsabilità, della gioia e della tristezza, della disperazione e della speranza, mi sembrano rinascere anche in aree estranee alla psichiatria. Ma, nel confrontarsi con la speranza, il linguaggio della psichiatria deve radicalmente rinnovarsi: alleandosi in particolare con quello della letteratura, e della filosofia. Ho scritto di speranza fin da lavori lontanissimi nel tempo, ma solo in testi di psichiatria tedesca mi era stato possibile confrontarmi su questo tema: considerato da noi radicalmente estraneo al discorso scientifico della psichiatria; e questo non diversamente da altri temi di matrice fenomenologica come quelli della solitudine, della gentilezza, della tenerezza, o della nostalgia.
La speranza creatrice.
Queste sono alcune tracce tematiche del libro che ho voluto scrivere cercando di ritrovare le parole che consentano di fare rinascere e ricrescere la speranza in ciascuno di noi, non dimenticando in particolare la splendida intuizione di Søren Kierkegaard che la definisce passione del possibile: apertura a un futuro che non conosciamo, e che nasce e muore indipendentemente dalle nostre previsioni e dalle nostre programmazioni, seguendo non i sentieri razionali della conoscenza, ma quelli emozionali e intuitivi, cosí difficili da prevedere. Le speranze si inaridiscono in particolare in quella forma di vita che in psichiatria siamo soliti chiamare depressione, che è nutrita di tristezza dell’anima e di inquietudine, nella quale non è piú possibile vivere nel futuro, nell’avvenire, ma solo in un presente fragile e friabile, che è continuamente divorato dal passato, e non ha piú trascendenza. Non c’è una sola depressione, e in ciascuna di esse la speranza ha sue diverse incrinature che giungono talora alla sua scomparsa.
Queste pagine intendono solo indicare alcune linee tematiche del mio discorso sulla speranza, e sulle sue metamorfosi, riprendendo alcune considerazioni svolte nei miei libri L’attesa e la speranza e Responsabilità e speranza. Si vive in una epoca nella quale ci si rifiuta di guardare alla speranza che, nella sua infinita apertura al futuro, all’avvenire, al cambiamento, all’inatteso, all’imprevisto, rimette in crisi – e la cosa costa fatica e fa paura – quelle che sono le realtà apparentemente pietrificate del momento, alle quali ci abituiamo, risparmiandoci la fatica di pensare a come modificarle e a come riscattarle in un orizzonte di nuove riflessioni. La speranza, il pensare alla speranza, a quello che potrà avvenire domani, non lascia tranquilli, ci tiene lontani dal fascino stregato e dalle certezze del presente che non ha almeno apparentemente nulla a che fare non solo con il futuro ma nemmeno con il passato. La speranza nasce e muore quando vuole, e a suo modo è rivoluzionaria perché c’è una dimensione sociale della speranza: non si spera solo per sé, ma anche per gli altri, liberandoci dalla solitudine, dall’arida presenza della solitudine, cosí dolorosa e cosí frequente, oggi.
La speranza ci consente di vedere la realtà con occhi non annebbiati e non oscurati dalle esteriorità e dalle consuetudini, dalle convenzioni e dalle ripetizioni, e ci consente di aprirci al futuro, liberandoci dalla ostinata prigionia del passato e del presente.
Il tempo.
Non è possibile parlare di speranza senza riflettere sul tempo, sulle considerazioni che sant’Agostino ha svolto sul tempo nelle Confessioni, e che non hanno perduto nulla della loro significazione psicologica, e umana. Ne vorrei citare alcuni brani che mi sono cari e che consentono di cogliere la genialità del suo pensiero.
«Cos’è il tempo? Chi saprebbe spiegarlo in forma piana e breve? Chi saprebbe formarsene anche solo il concetto nella mente, per poi esprimerlo a parole? Eppure, quale parola piú familiare e nota del tempo ritorna nelle nostre conversazioni? Quando siamo noi a parlarne, certo intendiamo, e intendiamo anche quando ne udiamo altri parlare. Cos’è dunque il tempo? Se nessuno m’interroga, lo so; se volessi spiegarlo a chi m’interroga, non lo so. Questo però posso dire con fiducia di sapere: senza nulla che passi, non esisterebbe un tempo passato; senza nulla che venga, non esisterebbe un tempo futuro; senza nulla che esista, non esisterebbe un tempo presente. Due, dunque, di questi tempi, il passato e il futuro, come esistono, dal momento che il primo non è piú, il secondo non è ancora? E quanto al presente, se fosse sempre presente, senza tradursi in passato, non sarebbe piú tempo, ma eternità. Se dunque il presente, per essere tempo, deve tradursi in passato, come possiamo dire anche di lui che esiste, se la ragione per cui esiste è che non esisterà? Quindi non possiamo parlare con verità di esistenza del tempo, se non in quanto tende a non esistere».
A queste sue domande, seguendo sentieri che la lettura delle Confessioni consente di conoscere, sant’Agostino giunge a consegnare le sue celebri risposte. «Un fatto è ora limpido e chiaro: né futuro né passato esistono. È inesatto dire che i tempi sono tre: passato, presente e futuro. Forse sarebbe esatto dire che i tempi sono tre: presente del passato, presente del presente e presente del futuro. Queste tre specie di tempi esistono in qualche modo nell’animo e non vedo altrove: il presente del passato è la memoria, il presente del presente la visione, il presente del futuro l’attesa. Mi si permettano queste espressioni, e allora vedo ed ammetto tre tempi, e tre tempi ci sono. Si dica ancora che i tempi sono tre: passato, presente e futuro, secondo l’espressione abusiva entrata nell’uso; si dica pure cosí: vedete, non vi bado, non contrasto né biasimo nessuno, purché si comprenda ciò che si dice: che il futuro ora non è, né il passato. Di rado noi ci esprimiamo esattamente; per lo piú ci esprimiamo inesattamente, ma si riconosce cosa vogliamo dire».
Solo muovendo da questo, che è il tempo interiore, il tempo soggettivo, il tempo dell’io, e che nulla ha a che fare con il tempo dell’orologio, il tempo della clessidra, il tempo obiettivo, si giunge a cogliere il nocciolo essenziale delle emozioni, della gioia e della tristezza, della malinconia e della inquietudine dell’anima, della speranza e della letizia. Il tempo interiore è il tempo dell’anima, nel quale passato, presente e futuro si intrecciano senza fine l’uno all’altro, e in modo diverso in ciascuno di noi, mentre il tempo dell’orologio, il tempo cronologico, scandisce il passare di un tempo comune a ciascuno di noi.
La speranza nelle sue fonti esistenziali.
La speranza come categoria esistenziale non può essere intesa nella sua emblematica radicalità se non nel contesto di riflessioni filosofiche che ci consentano di avvicinarci al suo nucleo eidetico: ai suoi infiniti orizzonti di senso. Non mi è possibile non citare i bracieri ardenti dei pensieri di Blaise Pascal sulla speranza, e sul tempo interiore che ne è l’anima. «Noi non pensiamo quasi mai al presente, o se ci pensiamo è solo per prendere la luce con cui predisporre l’avvenire. Il presente non è mai il nostro fine. Il passato e il presente sono i nostri mezzi, solo l’avvenire è il nostro fine. Cosí non mai viviamo ma speriamo di vivere, e, preparandoci sempre ad essere felici, inevitabilmente non lo siamo mai». La dialettica e il mistero della speranza, gli abissi di significato che sono in essa, riemergono da queste parole che sfidano il tempo; e a noi, a chiunque di noi intenda fare una psichiatria fenomenologica, non rimane se non di riversare nelle esperienze cliniche il senso di quello che le considerazioni di Pascal racchiudono in sé. Noi non viviamo mai ma solo speriamo di vivere, e allora, quando le alte maree della disperazione ci lambiscono, o ci sommergono, è ancora possibile vivere?
La speranza è una passione.
Il tema della speranza scorre senza fine come suo Leitmotiv nello Zibaldone di Giacomo Leopardi, e da queste pagine rinascono immagini sfolgoranti della speranza che sono di una sconvolgente modernità. Ne vorrei indicare alcune che sono premessa al mio discorso fenomenologico e clinico. L’età, nella quale la speranza e le speranze riempiono gli orizzonti di senso della vita, è quella adolescenziale. «Prima di provare la felicità, o vogliamo dire un’apparenza di felicità viva e presente, noi possiamo alimentarci delle speranze, e se queste son forti e costanti, il tempo loro è veramente il tempo felice dell’uomo, come nella età fra la fanciullezza e la giovinezza. Ma provata quella felicità che ho detto, e perduta, le speranze non bastano piú a contentarci, e la infelicità dell’uomo è stabilita. Oltre che le speranze dopo la trista esperienza fatta sono assai piú difficili, ma in ogni modo la vivezza della felicità provata, non può esser compensata dalle lusinghe e dai diletti limitati della speranza, e l’uomo in comparazione di questa piange sempre quello che ha perduto e che ben difficilmente può tornare, perché il tempo delle grandi illusion...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Speranza e disperazione
- PARTE PRIMA. La speranza come infinita ricerca di senso
- PARTE SECONDA. La speranza come memoria del futuro
- Bibliografia
- Il libro
- L’autore
- Dello stesso autore
- Copyright
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Speranza e disperazione di Eugenio Borgna in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Psychology e History & Theory in Psychology. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.