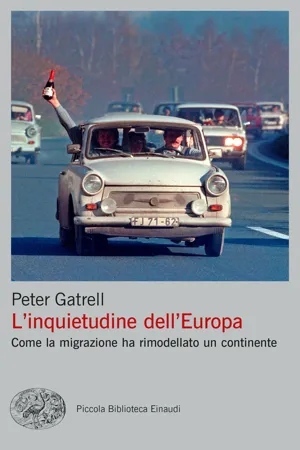L’età dell’oro dello sviluppo economico, tra gli anni Cinquanta e i primi Settanta, fu anche l’epoca in cui le potenze coloniali europee persero i loro possedimenti all’estero, e in particolare in Africa e in Asia. La decolonizzazione presentava aspetti politici, sociali ed economici, ma soprattutto ebbe un’importanza culturale straordinaria. Per usare le efficaci parole della storica Jordanna Bailkin, i migranti «portavano con sé non solo il passato coloniale, ma anche la decolonizzazione presente». La presenza dei lavoratori migranti in Gran Bretagna, Francia, Olanda e Portogallo rifletteva decenni, o addirittura secoli, di un dominio coloniale che alimentava la circolazione di beni e persone in entrambe le direzioni. Restava da stabilire se l’ingresso incontrollato nella «metropoli» potesse o dovesse proseguire anche dopo l’indipendenza dei paesi di origine1.
La decolonizzazione invertí quasi del tutto la direzione dei movimenti di persone, associati fino a quel momento alla crescita e al consolidamento degli imperi europei. Quando su quegli imperi calò il sipario, andò infatti subito in scena l’esodo di massa delle classi dirigenti che avevano collaborato all’amministrazione dei possedimenti coloniali d’oltremare. Funzionari, militari e semplici coloni si trasferirono da quei territori nel «cuore» dell’Europa metropolitana, un processo che all’epoca fu definito in termini di «rimpatrio» o «ritorno». Tali categorie erano però fuorvianti, perché molti di quelli che «ritornavano» erano i discendenti di proprietari terrieri e imprenditori, e mai prima avevano messe piede sul suolo europeo. Nella loro qualità di funzionari coloniali, tuttavia, erano convinti di essere legati da un vincolo indissolubile alle nazioni di cui avevano rappresentato gli interessi all’estero. «Rimpatrio» suggeriva inoltre un atto relativamente semplice e positivo. Nulla di piú lontano dal vero. Molti rimpatriati dovettero affrontare un’accoglienza inospitale.
La decolonizzazione portò in Europa anche altri gruppi, in particolare coloro che avevano collaborato con le potenze coloniali o erano stati alle loro dipendenze. È facile capire quanto precaria fosse la loro posizione: gli spostamenti improvvisi e ingenti di questi «complici» e ausiliari coloniali assomigliavano molto piú a un esodo forzato che a una migrazione economica, pur presentando elementi di entrambi. Anche queste persone non avevano nessun legame o quasi con la «madrepatria», e per di piú spiccavano decisamente, per via del colore della pelle. Questi gruppi di persone non bianche si erano aspettati qualche forma di riconoscimento o di indennizzo per il sostegno dato al regime coloniale, quando si era trattato di tenere a bada le forze per l’indipendenza: mentre ora, nel loro esilio di fatto, dovevano affrontare il razzismo e la discriminazione della società europea.
Allo stesso tempo, il processo di ritorno e di rimpatrio rappresentò l’incarnazione stessa del fallimento del progetto coloniale, le cui implicazioni furono espresse, nella loro forma piú teatrale, dalla lobby coloniale olandese che cosí commentò, nel 1949, l’indipendenza dell’Indonesia: «Indie verloren, rampspoed geboren» (Indie perdute, catastrofe assicurata). Nel 1974, quando il Portogallo rinunciò al proprio impero d’oltreoceano, i difensori della tradizione coloniale si chiesero che cosa ne sarebbe stato del corpo indiviso della nazione, senza le sue «membra». Nel momento in cui questi irriducibili del colonialismo cedettero infine alle forze indipendentiste, ci si pose un secondo interrogativo: quale destino attendeva la popolazione di quelle membra, amputate dal corpo politico2?
Di certo le conseguenze non furono enormemente significative, se rapportate alla cittadinanza dei paesi in cui giunsero queste persone. In Francia, Gran Bretagna e Olanda i migranti della colonizzazione rappresentavano appena il 4 per cento circa della popolazione; in Portogallo la percentuale era maggiore solo per via delle dimensioni piú contenute del paese. Tuttavia, preso in assoluto, il totale – compreso tra i 6 e gli 8 milioni di rimpatriati – era ragguardevole. Inoltre queste migrazioni colsero i governi europei quasi sempre di sorpresa. Le conseguenze furono enormi, sia per le società riceventi sia per gli stessi «rientrati», soprattutto in Francia (di cui si parlerà in modo piú approfondito nel capitolo VII)3.
L’importanza dei legami coloniali va ben oltre la ritirata imperialista e la migrazione stessa. Il crollo degli imperi impose di ripensare che cosa significasse essere europei ed essere uno stato nazionale post-coloniale: impose di guardarsi dentro, per cosí dire, anziché di fissare lo sguardo verso quelle regioni del pianeta che erano state dominate con l’esercizio della forza.
La prima a porsi questi interrogativi fu l’Italia, alla fine della Seconda guerra mondiale. Le potenze alleate vincitrici imposero all’Italia sconfitta la rinuncia all’impero in Etiopia, Eritrea, Somalia (i territori che andavano sotto il nome collettivo di «Africa orientale italiana») e in Libia, nonché in Albania e nelle isole del Dodecaneso: il trattato di pace del 1947 sancí in modo definitivo la decolonizzazione. In conseguenza di ciò, un numero di cittadini italiani compreso tra i 480 000 e i 580 000 rientrò nella penisola: funzionari statali, militari, ingegneri, coloni, operai e insegnanti. Nelle sue ambizioni imperialiste, Mussolini aveva inviato in Albania quasi 60 000 italiani, soprattutto, ma non solo, contadini e insegnanti. Nel 1945 l’Unrra – United Nations Relief and Rehabilitation Administration – iniziò a organizzare il loro rimpatrio, anche se il nuovo regime comunista in Albania insisté perché restassero gli specialisti dei settori tecnici, che dovevano contribuire alla ricostruzione del paese. Alcuni italiani inoltre, che si erano sposati e avevano ormai una famiglia albanese, decisero di rimanere e costituire, per cosí dire, un avamposto della nazione4.
In Libia, che dopo la sconfitta dell’Italia ricadde sotto la supervisione britannica, il processo fu piú tortuoso. Il governo italiano tardava ad approvare le richieste di rimpatrio presentate dai coloni, sostenendo che non sarebbero riusciti a trovare lavoro. Nel frattempo, alla fine degli anni Quaranta, altri italiani si imbarcavano per la Libia dalla Sicilia, senza autorizzazione: alcuni volevano riunirsi ai nuclei familiari rimasti laggiú, altri speravano di ottenere quei vantaggi economici che, pensavano, la patria cosí impoverita avrebbe senz’altro negato loro. Come scrisse la storica Pamela Ballinger – pensando anche agli sviluppi nel Mediterraneo, soprattutto dal 2015 in poi: «È un paradosso che non molti italiani sanno cogliere, il fatto che fino a non troppo tempo fa erano questi stessi italiani a essere considerati “clandestini”». Costoro riuscirono a resistere in Libia il tempo di una generazione, ma nel 1970 il colonnello Muammar Gheddafi, salito al potere l’anno precedente, ne espropriò le terre e li fece espellere. La sua repentina decisione riguardò circa 20 000 persone5.
Gli italiani rimpatriati furono etichettati come profughi nazionali, condizione che prevedeva il conferimento della cittadinanza e il diritto a percepire sussidi governativi – ma non aiuti internazionali, sotto alcuna forma. Alcune di queste persone potevano permettersi un alloggio privato o si fecero ospitare dai parenti, ma per molte di loro l’unica opzione erano i campi per i rifugiati. Nel 1960, in occasione dell’Anno mondiale del rifugiato, l’Italia stabilí che i fondi versati dai cittadini italiani in favore della campagna dovevano essere spesi per sgombrare quei campi e per contribuire al sostentamento delle persone appena arrivate dalla Somalia: quello stesso anno si concludeva infatti il decennio di amministrazione fiduciaria che l’Onu aveva assegnato all’Italia. Alla fine le amministrazioni pubbliche destinarono a queste persone case costruite appositamente, ma i rapporti tra i profughi nazionali e gli altri italiani rimasero molto freddi. Non era insolito che i locali apostrofassero i nuovi arrivati dalla Libia o dall’Etiopia come «africani», segno che la condizione formale di cittadini italiani non bastava a garantire la piena inclusione nella nazione italiana6.
Nei Paesi Bassi, con il loro enorme impero d’oltreoceano, la situazione fu ancora piú drammatica. L’indipendenza proclamata dall’Indonesia nel 1949 convinse i coloni bianchi e i funzionari, e anche le persone di etnia mista olandese e indonesiana (spesso raccolte in un’unica categoria, i cosiddetti Indisch Dutch), della necessità di trasferirsi in Olanda. Queste persone, che prima della Seconda guerra mondiale avevano goduto di parecchi privilegi ma che, con l’occupazione giapponese durante la guerra, avevano sopportato grandi sofferenze, erano nel linguaggio ufficiale «rimpatriati», non immigrati. Tra il 1949 e il 1960, anno in cui l’Indonesia nazionalizzò tutte le imprese di proprietà olandese, il numero totale dei rimpatriati raggiunse una cifra compresa tra le 250 000 e le 300 000 persone7.
Che questi rimpatriati riuscissero a integrarsi non era affatto scontato. Un articolo dell’epoca sugli Indisch Dutch suggeriva che «la società olandese in generale dimostra scarsa consapevolezza della presenza di questo gruppo di persone rimpatriate e dei loro specifici problemi di integrazione». I loro appelli per essere risarciti dei beni perduti (e perché si riconoscessero i tormenti inflitti dai giapponesi nell’Indonesia occupata) rimasero inascoltati. Un ministro disse che forse avrebbero potuto difendere meglio i loro interessi «restando in Indonesia». I progressisti olandesi li consideravano una presenza reazionaria, e i conservatori vedevano in loro un simbolo della vergogna nazionale, etichettandoli in modo denigratorio come «pentiti» (spijtoptanten)8.
Avendo pochissimi contatti in Olanda, i «ritornati» per sopravvivere dovettero affidarsi al buon cuore dei vicini. Di fronte alle scarse prospettive di occupazione, molti di loro affidarono all’emigrazione tutte le loro speranze. Le difficoltà emersero nelle petizioni presentate dai cittadini olandesi al Consiglio ecumenico delle chiese e all’American Friends Service Committee (Afsc, l’agenzia umanitaria dei quaccheri), nella speranza di ottenere il visto per migrare dall’Olanda negli Stati Uniti. Jacques L., nato a Bandung nel 1938, spiegò che in Indonesia faceva il saldatore alle dipendenze di una compagnia petrolifera; dopo il suo arrivo in Olanda, nell’aprile del 1958, aveva trovato un posto come meccanico in un’officina. Chiedeva la possibilità di trasferirsi negli Stati Uniti «in cerca di uno stile di vita che offra piú possibilità e sia meno limitato che qui nei Paesi Bassi». Veniva descritto come un «ragazzo per bene, dalle intenzioni serie, coscienzioso». Alla fine comunque decise di non emigrare perché la sorella, ricoverata in ospedale, aveva bisogno di lui. Un altro richiedente, Franciscus L., insieme alla moglie Johanna e ai loro sette figli, chiedeva il permesso di partire per gli Stati Uniti, dove avevano qualche lontano parente. Franciscus era stato catturato dai giapponesi; dopo la guerra era stato in aviazione e aveva fatto il meccanico, poi era venuto in Olanda dove erano nati sei dei suoi figli. Anche lui aveva lavorato in officina, dopo il trasferimento. Il funzionario che li intervistò li descrisse come «un bel nucleo familiare», aggiungendo che i genitori «desideravano immigrare per offrire ai figli opportunità per il futuro migliori di quelle che potrebbero avere nella piccola Olanda sovraffollata». Poi però litigarono con i parenti in America e decisero di restare in Olanda9.
Insomma, non tutti quelli che desideravano emigrare furono in condizioni di farlo. Altre famiglie invece trovarono la prospettiva di un ingresso negli Stati Uniti, o in altri paesi come l’Australia, non solo attraente ma fattibile. Una famiglia di tre persone: Willem (nato in Indonesia, a Tandjungkarang, nel 1924), sua moglie e il figlio appena nato furono costretti a lasciare il loro paese nel 1958, quando il nuovo governo nazionalizzò la fabbrica per la lavorazione della canna da zucchero in cui lavorava. Trovarono alloggio in un ostello olandese per rimpatriati e Willem fu assunto come macchinista qualificato. Come spiegava il funzionario americano addetto all’immigrazione, la famiglia abitava ancora in un centro di raccolta, e non «c’erano possibilità di trovare un’abitazione privata per via della carenza di alloggi». I quaccheri americani dell’Afsc accettarono di fare da sponsor per la famiglia, che lasciò cosí i Paesi Bassi. Col tempo molti rimpatriati sembrarono integrarsi con successo in Olanda, dove le autorità locali misero a loro disposizione alloggi con l’affitto calmierato – anche se questo non impedí al governo di cercare di sbolognarli da qualche altra parte, per allentare la pressione sulla crisi abitativa10.
Oltre a questi «rimpatri» si ebbe un flusso ingente di migranti molucchesi (o ambonesi) che, dopo aver combattuto per i Paesi Bassi contro l’occupazione giapponese e poi, nel 1945-49, contro le forze nazionaliste indonesiane guidate da Sukarno, guardavano all’Olanda come rifugio temporaneo in cui sfuggire alla vendetta nel ...