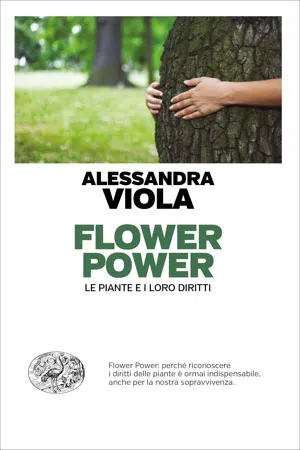Povero Pando: nessuno sa dire quale sia stato il giorno, il mese o l’anno e neppure il secolo o il millennio del suo primo compleanno. Eppure varrebbe davvero la pena festeggiarlo, dato che si tratta dell’essere vivente piú vecchio del mondo. Secondo gli studiosi ha piú di tredicimila anni ed è vivo da molte migliaia, ma non sappiamo ancora fare una stima precisa della sua età. Quando ha iniziato a mettere radici l’uomo probabilmente viveva nell’età della pietra, iniziava a costruire i primi utensili in osso e decorava le pareti delle grotte in cui dormiva disegnando animali colorati. Forse era ancora nomade, o magari in alcune parti del pianeta aveva già cominciato a sperimentare una vita stanziale, inventando l’agricoltura. Di sicuro Pando era già adulto quando gli antichi egizi costruivano le piramidi, i Maya adoravano il sole e quando Colombo sbarcò in America. Chissà quanto era grande allora il suo corpo, sdraiato tra le montagne di Fishlake, nello Utah, che oggi è composto da quarantasettemila alberi di pioppo tremulo che ne fanno, oltre che il piú longevo, l’essere vivente piú pesante e il piú grande del mondo. Ci vuole uno sforzo dell’immaginazione per concepire la sua straordinaria natura: Pando è un bosco, ma è anche un unico organismo vegetale. Un sistema radicale esteso per circa 43 ettari e dal peso stimato di 6600 tonnellate, che si rigenera da migliaia di anni attraverso la nascita di sempre nuovi alberi di Populus tremuloides tutti geneticamente identici. Un esempio di resilienza unico al mondo, che oggi però denuncia evidenti sintomi di malessere: Pando sta male e fatica a rimpiazzare gli alberi che cadono o si ammalano a causa dei cambiamenti climatici e della cattiva gestione umana. Non c’è molto da stupirsi, purtroppo. Anche se Pando ha superato indenne siccità e incendi, massicce inondazioni, terremoti e colonizzazioni umane, oggi i cambiamenti climatici procedono a ritmi troppo rapidi per lui e l’azione umana ha una potenza e una pervasività mai raggiunte prima. Aiutarlo sarà difficile, anche perché in generale gli studi condotti finora sono insufficienti per affrontare in modo sistematico ed efficace i problemi che la nostra civiltà sta creando alla vita sul pianeta. Pando dovrà cavarsela da solo, come ha sempre fatto, e quanto a noi l’impreparazione ad aiutarlo dovrebbe farci riflettere.
Prendiamo le interazioni tra il mondo biologico e il clima: sono incredibilmente complesse e siamo distanti dall’averle comprese a fondo. Tra convinti assertori (sempre di piú) e negazionisti (sempre di meno) del ruolo umano nel riscaldamento globale, esiste un’ampia forbice di posizioni piú o meno supportate dalla scienza, che tirano in ballo anche il mondo vegetale. Le piante infatti, e in particolare gli alberi, agiscono come regolatrici del clima e la loro presenza o assenza è in grado di modificare sensibilmente il regime delle piogge, l’umidità, la qualità e temperatura dell’aria, il livello di nutrienti nel suolo e moltissimi altri fattori. Per questo, quando si parla di cambiamenti climatici, si dovrebbe anche sempre parlare di piante, sebbene il modo in cui farlo non sia affatto chiaro.
Persino tra coloro che già riconoscono alla biosfera la capacità di condizionare il clima non c’è accordo. Secondo alcuni, per esempio, bisognerebbe piantare piú alberi perché ogni albero assorbe CO2 durante la crescita e la “ingabbia” nel suo organismo fino alla morte. Tanti piú alberi, quindi, tanta piú anidride carbonica assorbita. Vanno in questa direzione la «Trillion Tree Campaign» (Campagna per un triliardo di alberi) lanciata dalle Nazioni Unite, l’iniziativa indiana che ha portato a piantare 220 milioni di alberi in un solo giorno nello Stato dell’Uttar Pradesh (che ha 220 milioni di abitanti) e la «Green Legacy Campaign» dell’Etiopia, che secondo fonti governative ne avrebbe piantati in un giorno ben 350 milioni e che in questo modo punta a riforestare massicciamente il Paese, la cui copertura forestale, secondo le Nazioni Unite, è scesa dal 35 per cento dei primi anni del XX secolo a poco piú del 4 per cento dei primi anni Duemila. Eppure neanche su questo meccanismo di base sono tutti d’accordo! Una ricercatrice di Yale ha recentemente sostenuto che piantare piú alberi non offre affatto garanzie per diminuire le emissioni di CO2, perché il carbonio intrappolato viene nuovamente rilasciato in caso di incendio o di morte della pianta, la quale inoltre “respira” bruciando ossigeno e rilasciando a sua volta anidride carbonica. Quindi niente da fare. Queste controversie hanno raggiunto livelli di parossismo, come quando il governo canadese ha provato a far passare un progetto per disboscare le grandi e antiche foreste del Paese con la promessa di ripiantarle, sostenendo la validità del proposito con dati che sancivano il maggiore assorbimento di CO2 degli alberi durante la crescita rispetto a quelli di età matura e senza tenere in considerazione l’anidride carbonica liberata dagli alberi che sarebbero stati tagliati.
Senza addentrarci nei dettagli di un dibattito che tra persone ragionevoli e informate non avrebbe neppure ragione di esistere, quello che vale la pena sottolineare è quanto poco sappiamo del mondo vegetale e dei meccanismi di base che regolano la vita sul pianeta, due temi che per di piú sono strettamente connessi e compongono insieme il quadro della pericolosa ignoranza umana in merito alle condizioni fondamentali per la nostra sopravvivenza. Solo dal 2015, per esempio, disponiamo di una stima piú precisa del numero di alberi presenti sulla Terra. Sono 3 040 000 000 000 000 ooo, cioè 3,04 trilioni e questo numero impressiona per almeno un motivo: è otto volte maggiore di quanto pensassimo. Se poi si considera – come vedremo in seguito – il ruolo fondamentale degli alberi nella formazione delle nuvole, nel ciclo dell’acqua e in molti altri importanti processi biologici, è chiaro che ci continuano a mancare molti importanti tasselli per capire come funziona la vita sul pianeta.
Un altro dato che ci manca quasi completamente è quello che riguarda la composizione della biosfera. Si tratta di una questione fondamentale per la biologia, la disciplina che cerca di descrivere la composizione del mondo vivente, eppure malgrado secoli di studi siamo ancora distanti dall’aver chiarito il ruolo nell’ecosistema delle numerosissime specie che abitano con noi il pianeta. Sappiamo che tutta la vita è strettamente legata, ma cosa succede se si estingue una certa specie? Quale apporto viene a mancare alle altre? Un censimento quantitativo della biomassa sarebbe un buon punto d’inizio per capire la struttura e le dinamiche della biosfera, ma anche in questo caso dobbiamo ancora accontentarci di stime piuttosto grossolane.
Sappiamo per esempio che, se valutiamo in circa 550 gigatonnellate ovvero 550 miliardi di tonnellate di carbonio (nella letteratura scientifica si usa questa misura perché è indipendente dalla quantità di acqua contenuta nei diversi organismi) la biomassa totale sulla Terra, quella vegetale ammonta a 450 gigatonnellate. Un numero di cui è praticamente impossibile farsi un’idea, se non in rapporto a un altro: la biomassa totale degli animali, che a livello globale “pesa” appena 2 gigatonnellate, all’interno delle quali tutti gli umani sul pianeta figurano per sole 0,06 gigatonnellate.
Per quanto importanti possiamo continuare a sentirci, le vere dominatrici della Terra sono le piante, per la precisione quelle terrestri. Il che è un bene, intendiamoci.
Disporre di dati certi in ogni caso sarebbe piú che mai utile per avere un’idea della quantità di carbonio biosequestrato, per costruire modelli sui cicli biogeochimici del pianeta e per studiare l’impatto dell’azione umana sulla Terra, anche se c’è da credere che persino disporre di queste informazioni (che in parte abbiamo, sia pur in maniera imprecisa) non farebbe una gran differenza. Almeno su una cosa infatti c’è grande chiarezza: il regno dominante sul pianeta è quello delle piante, che sono fondamentali per la vita di tutti gli altri esseri viventi. Cosa abbiamo fatto di questa informazione? L’abbiamo forse usata per proteggerle? Niente affatto: continuiamo a ignorarle e a sentirci i dominatori del pianeta.
Eppure il valore delle piante è immenso, anche se in gran parte sconosciuto. Secondo una stima conosciamo solo il 5-10 per cento delle specie esistenti e in virtú della nostra sostanziale ignoranza il mondo vegetale ci riserva continue sorprese: solo nel 2016 (ultimo dato disponibile al momento della stampa di questo libro), per fare un esempio, sono state scoperte 1730 nuove piante vascolari, cioè dotate di un sistema di vasi per condurre l’acqua: in questa categoria rientrano quasi tutte le piante tranne alghe, epatiche e muschi (dato aggiornato in https://stateoftheworldsplants.org/2017/new-plant-discoveries.html). La tentazione, leggendo questo dato, è di pensare che queste “nuove piante” siano muschi o altre minuscole piantine germogliate in qualche invisibile anfratto del pianeta. Ma non è cosí. L’Englerophylum paludosum, che fa parte dell’elenco di quelle appena scoperte, cresce nelle foreste del Camerun, ha un tronco di un metro di diametro e un’altezza che raggiunge mediamente i quaranta metri. Secondo i Royal Botanic Gardens, che periodicamente redigono uno «State of the World» del regno vegetale, ogni anno scopriamo circa duemila nuove specie vegetali. Un numero impressionante che non ha solo un valore scientifico ma anche economico, se si pensa che delle circa quattrocentomila specie vegetali con cui dividiamo il pianeta 31 000 hanno un uso riconosciuto e che – secondo una stima al ribasso – nel 2018 il solo mercato delle oltre 28 000 piante registrate per uso medicinale valeva circa 90 miliardi di dollari. Senza contare che la medicina tradizionale, che si basa sul diretto uso di piante medicinali, è utilizzata da oltre 3 miliardi di persone nel mondo, quasi la metà dei suoi abitanti.
Dalle piante ricaviamo il 95 per cento dei nostri principî curativi: l’estinzione di migliaia di specie ogni anno procura all’umanità un danno incalcolabile. Il termine non è scelto a caso: il danno è proprio incalcolabile perché non è possibile calcolarlo. Quali e quante preziose sostanze medicinali perdiamo ogni volta che una specie si estingue? Quali cure per quali malattie vanno irrimediabilmente perdute? Sono talmente tante le cose che non sappiamo sulle piante, sulle loro proprietà e il loro ruolo nell’ecosistema che anche volendo non riusciremmo in alcun modo a quantificare queste perdite.
Sembrerebbe importante conoscere e salvaguardare in ogni modo le piante. Invece le studiamo a fondo solo da pochi decenni, le tuteliamo poco e male e sono moltissime le cose che ancora non sappiamo di loro. Certo tutti possiamo facilmente riconoscerne una ventina: gerani e abeti, cactus e papaveri, margherite, basilico e rosmarino sono patrimonio comune della nostra cultura. Ma anche senza arrivare a barocche sottigliezze botaniche, quanti saprebbero identificare un pioppo o un tiglio o semplicemente dare un nome agli alberi e alle piante che incontrano ogni giorno uscendo di casa? Il nome, poi, è solo il primo passo. Il mondo vegetale ci è noto sin da bambini e a scuola studiamo la fotosintesi clorofilliana, ma siamo certi di sapere come funziona una pianta e cosa sia esattamente? Le piante comunicano tra loro e con gli animali, imparano, ricordano, stringono alleanze e competono, sono intelligenti. Riconoscono i parenti e costruiscono reti sociali evolute. Si adattano all’ambiente in modi imprevedibili e a volte geniali.
In commercio esistono molti libri divulgativi sulle piante e io stessa ho già scritto delle loro affascinanti peculiarità. Questo capitolo quindi non si occupa della loro intera fisiologia ma vuole offrire un breve compendio di quelle caratteristiche che interessano una discussione sui diritti, con lo scopo di mettere in dubbio la “naturalezza” con la quale abbiamo fino a oggi tracciato il confine tra chi può averne e chi no.
Le piante fanno le nuvole.
Le piante hanno un valore in sé e devono essere rispettate e protette per questo. È importante ribadirlo sempre e se ne discuterà ampiamente nel prossimo capitolo, ma è anche importante riconoscere che allo stesso tempo (cioè mentre vivono in modo naturale la loro vita) esse hanno anche un valore per noi. Tutte le culture e le economie, su scala locale e globale, girano intorno alle piante e ai loro ritmi metabolici. Fioriture e raccolti (o la loro scarsità o completa mancanza) valgono il Pil di intere nazioni. Ci sono prodotti come il caffè, le banane, le spezie, il tè e il cacao per i quali si sono combattute persino delle guerre, ma queste considerazioni ancora non restituiscono che una microscopica parte del loro valore. Non ne abbiamo davvero un’idea chiara, ma se le piante d’improvviso sparissero saremmo spacciati in un batter di ciglia. Pochi anni, ovvero il tempo di consumare tutte le scorte alimentari disponibili.
Sappiamo sin dai tempi della scuola che il mondo vegetale è alla base della catena alimentare: niente piante vuol dire niente cibo né per noi né per nessun altro animale. Non mi dilungherò su questo. Sappiamo anche che le piante forniscono principî attivi per la nostra farmacopea (ne ho già parlato), importanti materie prime, energia. Anche se non abbiamo una reale percezione di quanto cruciali siano questi apporti per la nostra vita e di quanto dipendiamo dalle piante per sostenere la nostra intera civiltà, almeno in teoria tali fattori sono noti. Non mi soffermerò neanche su questi. Quel che si sa di meno, e su cui solo da pochissimi anni iniziamo ad avere qualche dato, è che le piante... fanno il mondo. Lo fanno producendo materia organica a partire da elementi inorganici, facendo da tramite energetico tra il Sole e il nostro pianeta e regolando le principali funzioni climatiche e atmosferiche. Esse erogano una moltitudine – in parte sconosciuta – di «servizi ecosistemici»: solo per fare qualche esempio depurano l’aria dalle particelle di smog e l’acqua dalle sostanze inquinanti, ripuliscono il suolo da vari tipi di sostanze nocive tra cui i pericolosi metalli pesanti e assorbono persino le radiazioni nucleari. Si dice proprio cosí, “servizi ecosistemici” come se queste prestazioni fossero erogate da una qualche anonima società di servizi, mentre sarebbe utile avere ben chiaro che al mondo vegetale dobbiamo la cosa piú importante che c’è: le condizioni per vivere sulla Terra.
Le piante, per esempio, fanno le nuvole. Un esperimento del Cern di Ginevra, che non a caso si chiama Cloud (nuvola in inglese, ma anche acronimo di Cosmics Leaving Outdoor Droplets) ha fatto luce sul principio che regola la formazione delle nubi studiando l’interazione tra gli aerosol (piccolissime particelle in sospensione nell’aria che funzionano come “semi di nuvole” o meglio come nuclei di condensazione per le goccioline di acqua) e i raggi cosmici e dimostrando che esse si formano (anche) per effetto degli alberi. Fino a pochi anni fa eravamo convinti che l’azione umana, avendo aumentato la quantità di acido solforico presente nell’atmosfera a partire dalla Rivoluzione industriale, avesse “annuvolato” il cielo. Invece ancora una volta abbiamo sovrastimato la nostra importanza: l’esperimento Cloud ha dimostrato che circa l’ottanta per cento delle nuvole è di origine biologica e deriva da aerosol organici (terpeni) prodotti principalmente dagli alberi.
Molte delle relazioni tra la biosfera e l’atmosfera rimangono da chiarire e per quanto riguarda le nuvole allo studio per esempio c’è adesso il complesso ruolo che nella loro formazione riveste il fitoplancton oceanico (anch’esso vegetale, è bene ricordarlo).
Anche se può non sembrare, si tratta di studi di cruciale importanza. Basti pensare che le previsioni dell’Ipcc, il Panel intergovernativo per i cambiamenti climatici, per il prossimo secolo oscillano tra 1,5 e 4,5 gradi di aumento della temperatura globale. Un’oscillazione che va da un possibile anche se non semplice adattamento dell’uomo e delle altre specie al nuovo clima fino all’estinzione di massa di decine di migliaia di specie. Ma a cosa si deve un grado di incertezza cosí elevato? Dipende dalla scarsa disponibilità di informazioni relative ad alcuni parametri chiave per la formulazione dei modelli climatici, tra cui... gli elementi che concorrono alla formazione delle nuvole. Se alcune possono infatti avere un effetto riscaldante (i cirri, nubi fini di alta quota), altre ne hanno uno di raffreddamento (gli strati, che a bassa quota riflettono la radiazione solare) e la loro maggiore o minore presenza nei cieli può causare aumenti o diminuzioni di temperatura di vari gradi.
Facendo le nuvole, dunque, le piante regolano il clima. Sembrerebbe un tema fondamentale, in tempi in cui si discute tanto di cambiamenti climatici e di come mitigarne gli effetti. Un argomento al quale destinare fondi e ricerche a non finire. Invece niente (o pochissimo) accade in quel campo come in molti altri legati a temi cruciali per la comprensione e la limitazione dei cambiamenti climatici. Come mai? Si direbbe che in molti ancora oscillino tra un certo senso di onnipotenza (l’uomo è il padrone della natura ed è l’essere vivente piú intelligente che c’è, quindi qualunque cosa accada troveremo una soluzione) e l’incredulità: come può l’uomo, che è cosí potente ma al tempo stesso anche cosí piccolo in rapporto al pianeta, modificarne il clima emettendo un gas invisibile e inodore come l’anidride carbonica? Ai primi risponderà probabilmente il futuro, ai secondi invece ha già risposto il passato.
Anche se sembra incredibile, è già successo tutto. Altri esseri prima di noi sono stati i padroni del mondo e sono stati (quasi) spazzati via dalla Terra a causa delle loro emissioni gassose: la storia dell’ascesa e caduta dei cianobatteri è una potente e attuale metafora.
Tutto è iniziato circa 2 miliardi e mezzo di anni fa. La vita sulla Terra allora era piuttosto diversa da come la conosciamo. Nell’atmosfera non c’era ossigeno libero e non esistevano animali, piante e neppure insetti. La vita tuttavia pullulava, almeno sotto forma di organismi unicellulari. I padroni del mondo, nonché in pratica i suoi unici abitanti, erano microscopici batteri anaerobici che erano in grado di metabolizzare il proprio cibo senza ossigeno e vivevano per lo piú nei grandi mari primitivi e in parte minore sulla terraferma. Tutto procedeva tranquillamente da milioni di anni, fino al giorno in cui fecero la loro comparsa i cianobatteri. Un nuovo tipo di batteri, simili a microscopiche alghette verdi-azzurre, capaci di fare la fotosintesi e dunque con una marcia in piú rispetto agli altri, grazie al fatto di avere a disposizione quasi ovunque un cibo altamente nutriente e in grande quantità come la luce solare. Per convertire la luce in energia, i cianobatteri iniziarono a “respirare”, emettendo ossigeno come prodotto di scarto. L’atmosfera, come abbiamo detto, era pr...