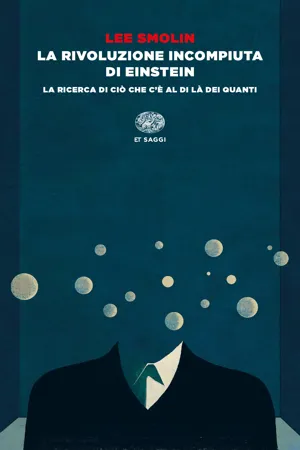La meccanica quantistica è alla base della nostra comprensione della natura da novant’anni. È dappertutto, ma è anche profondamente misteriosa. Ben poco della scienza moderna avrebbe senso senza di essa. Tuttavia gli esperti hanno difficoltà a concordare su ciò che afferma della natura.
La meccanica quantistica spiega perché esistono gli atomi e perché sono stabili e hanno proprietà chimiche diverse. Spiega anche come si combinano formando molecole diverse. Di conseguenza, è la base della nostra comprensione delle forme e delle interazioni delle molecole. La vita sarebbe incomprensibile senza i quanti. Dal comportamento dell’acqua alle forme delle proteine e alla fedele trasmissione dell’informazione da parte del DNA e dell’RNA, tutto nella biologia dipende dai quanti.
La meccanica quantistica spiega le proprietà dei materiali, per esempio che cosa rende un metallo un buon conduttore dell’elettricità, mentre un altro è un isolante. Spiega la luce e la radioattività ed è la base della fisica nucleare. Senza di essa non capiremmo perché le stelle brillano. E non potremmo aver inventato i chip o i laser su cui si basa gran parte della tecnologia. La meccanica quantistica è il linguaggio che usiamo per scrivere il modello standard della fisica delle particelle, che contiene tutto ciò che sappiamo delle particelle elementari e delle forze fondamentali tramite le quali esse interagiscono.
Secondo la nostra migliore teoria dell’universo primordiale, tutta la materia, insieme alle configurazioni che finirono per unirsi formando le galassie, fu strattonata dalla casualità quantistica del vuoto dello spazio vuoto e portata a esistere dalla rapida espansione dell’universo. Non mi aspetto che i lettori capiscano in modo preciso che cosa significano queste parole, che però forse evocano un’immagine. In ogni caso, se ciò è corretto, senza la fisica quantistica non esisterebbe letteralmente null’altro che spaziotempo vuoto.
Nonostante il suo grande successo, però, al cuore della meccanica quantistica vi è un enigma ostinato. Il mondo quantistico si comporta in modi che sfidano la nostra intuizione. Si dice spesso che nella fisica quantistica un atomo può essere in due posizioni allo stesso tempo, ma questo è solo l’inizio; la storia completa è molto piú strana. Se un atomo può essere qui o lí, dobbiamo parlare di stati in cui è, in qualche modo, simultaneamente sia qui sia lí. Questa è detta sovrapposizione.
Se non sapete nulla del mondo quantistico, vi starete senza dubbio chiedendo che cosa significhi che un atomo è in qualche modo sia qui sia lí. Non scoraggiatevi se la questione vi confonde. Avete assolutamente ragione a domandarvi che cosa significhi. Questo è uno dei misteri fondamentali della meccanica quantistica. Per il momento, è sufficiente che lo accettiate come un mistero, al quale associamo il termine «sovrapposizione». Piú avanti riusciremo a chiarirlo.
Ecco un primo passo. L’affermazione che una particella quantistica è in una «sovrapposizione dello stato in cui si trova qui e dello stato in cui si trova lí» ha a che fare con la natura ondulatoria della materia, infatti un’onda è una perturbazione che si diffonde e quindi può essere sia qui sia lí.
Parliamo di particelle elementari, ma ogni entità quantistica, compresi gli atomi e le molecole, è sia una particella sia un’onda. Per cominciare a capire che cosa significa, considerate che, se realizziamo un esperimento per stabilire dove si trova un atomo, il risultato sarà una posizione precisa, ma tra una misurazione e l’altra, quando non lo stiamo cercando, risulta impossibile stimare dove potrebbe essere. È come se la tendenza o propensione a trovare la particella si diffondesse come un’onda quando non guardiamo. Appena guardiamo di nuovo, però, la particella è sempre da qualche parte.
Immaginiamo di giocare a nascondino con un atomo. Se apriamo gli occhi, o accendiamo un rivelatore, lo vediamo da qualche parte. Quando abbassiamo le palpebre, però, si dissolve in un’onda di potenzialità. Se riapriamo gli occhi, l’atomo è sempre da qualche parte.
Un’altra caratteristica unica del mondo quantistico è l’entanglement. Se due particelle interagiscono e poi si allontanano l’una dall’altra, restano collegate nel senso che sembrano condividere proprietà che non si possono scomporre in proprietà di cui ciascuna gode individualmente.
Con uno sforzo di immaginazione possiamo applicare questi nuovi concetti ad atomi e molecole che sono troppo piccoli per essere visti direttamente. Dobbiamo studiarli in modi indiretti e a tale scopo utilizziamo dispositivi di misurazione grandi e complessi.
Questi dispositivi fanno parte del mondo dei grandi oggetti di uso quotidiano. Una cosa di cui possiamo essere certi è che questi grandi oggetti non mostrano nessuno dei comportamenti bizzarri descritti dalla meccanica quantistica. Una sedia è qui oppure è lí, non è mai in una combinazione dei due stati. Quando ci svegliamo nel mezzo della notte in una strana stanza d’albergo, possiamo non sapere con certezza dove si trova la sedia, ma possiamo essere certi che è da qualche parte. E se, camminando al buio, andiamo a sbattere contro la sedia, il nostro futuro non resta intrecciato al suo.
Nel mondo della nostra esperienza, i gatti sono vivi oppure morti, anche se sono chiusi in una scatola. Quando la apriamo, il gatto non passa all’improvviso da una combinazione di vita e morte alla morte. Se lo troviamo morto, è probabile che lo sia da qualche tempo, come indicherebbe immediatamente l’odore.
Gli oggetti ordinari non sembrano condividere le stranezze quantistiche degli atomi di cui sono fatti. Anche se sembra ovvio, ne nasce un mistero. La meccanica quantistica è la teoria centrale della natura. Come tale deve essere universale. Se si applica a un atomo, si deve applicare anche a due atomi, o dieci o novanta. E abbiamo prove sperimentali eccellenti che lo confermano. Esperimenti delicati, in cui grandi molecole sono poste in una sovrapposizione quantistica, mostrano che hanno la stessa stranezza quantistica degli elettroni. Per dirne una, si diffrangono e interferiscono come onde.
Ma allora la meccanica quantistica si deve applicare ai grandi insiemi di atomi che costituiscono voi, me, il mio gatto o la sedia su cui è raggomitolato. Non sembra proprio, però. Non sembra nemmeno che la meccanica quantistica si applichi a qualcuno degli strumenti e delle macchine che usiamo per ottenere immagini degli atomi e rivelarne le stranezze quantistiche.
Com’è possibile?
In particolare, quando misuriamo una proprietà di un atomo, usiamo dispositivi di grandi dimensioni. Gli atomi possono essere in una sovrapposizione di stati e quindi in posizioni diverse allo stesso tempo, ma lo strumento di misurazione indica sempre soltanto una delle risposte possibili alla domanda che poniamo. Come mai? Perché la meccanica quantistica non si applica anche ai dispositivi che usiamo per misurare i sistemi quantistici?
Questo è il cosiddetto problema della misurazione, controverso e irrisolto dagli anni Venti del secolo scorso. Il fatto che dopo tutto questo tempo gli esperti non abbiano ancora raggiunto un accordo significa che esiste un aspetto fondamentale della natura che non abbiamo ancora capito.
Da qualche parte si ha quindi una transizione dal mondo quantistico, in cui un atomo può essere in posti diversi allo stesso tempo, al mondo ordinario, in cui tutto è sempre da qualche parte. Se una molecola composta da dieci o novanta atomi può essere descritta dalla meccanica quantistica, ma un gatto no, da qualche parte tra i due vi è una linea che indica dove si ferma il mondo quantistico. Una soluzione del problema della misurazione rivelerebbe dove sta quella linea e spiegherebbe la transizione.
Vi sono persone che sono certe di conoscere la soluzione del problema della misurazione. Piú avanti, incontreremo alcune di queste persone e le loro idee. Vogliamo cercare di capire quale prezzo dobbiamo pagare per eliminare questa follia quantistica dalla nostra comprensione del mondo.
In linea generale, le persone che mirano ad affrontare i misteri della meccanica quantistica appartengono a due categorie.
Il primo gruppo presume che la teoria cosí come fu formulata negli anni Venti sia essenzialmente corretta. Sono convinti che il problema non sia legato alla meccanica quantistica, ma invece al modo in cui la interpretiamo o ne parliamo. Questa strategia per mitigare la bizzarria della meccanica quantistica risale ad alcuni dei fondatori, a partire da Niels Bohr.
Il fisico danese Niels Bohr fu il primo, quando non aveva ancora trent’anni, ad applicare la teoria quantistica agli atomi. Piú in là negli anni divenne il leader de facto della rivoluzione quantistica, in parte per il fascino delle sue idee e in parte perché istruí e fu il mentore di molti giovani rivoluzionari.
Il secondo gruppo ha concluso che la teoria è incompleta. Non se ne può capire il significato perché è solo una parte della storia. Cercano un completamento della teoria che racconti il resto e risolva cosí i misteri della meccanica quantistica. Questa strategia risale ad Albert Einstein.
Einstein fu piú di chiunque altro il responsabile dell’inizio della rivoluzione quantistica. Fu il primo a esprimere con chiarezza la natura duale della luce come particella e come onda. Ormai è piú noto per la teoria della relatività, ma vinse il premio Nobel per il suo lavoro sulla teoria quantistica, e per sua stessa ammissione dedicò piú tempo alla teoria quantistica che alla relatività. Tuttavia, pur avendo dato inizio alla rivoluzione quantistica, Einstein non divenne uno dei suoi leader, perché il suo realismo lo obbligava a respingere la teoria nella forma sviluppata alla fine degli anni Venti.
Nel linguaggio presentato nella Prefazione, i componenti del primo gruppo sono per lo piú sostenitori dell’antirealismo o del realismo magico. I realisti appartengono al secondo gruppo.
Coloro che sostengono l’incompletezza della meccanica quantistica sottolineano il fatto che nella maggior parte dei casi può solo formulare previsioni statistiche dei risultati degli esperimenti. Anziché indicare che cosa accadrà, fornisce le probabilità dei possibili eventi. In una lettera del 1926 all’amico Max Born, Einstein scrisse:
La meccanica quantistica è degna di ogni rispetto, ma una voce interiore mi dice che non è ancora la soluzione giusta. È una teoria che ci dice molte cose, ma non ci fa penetrare piú a fondo il segreto del gran Vecchio. In ogni caso, sono convinto che questi non gioca a dadi col mondo2.
Einstein era amico anche di Niels Bohr e le loro reazioni divergenti alla meccanica quantistica alimentarono un dibattito appassionato tra i due che proseguí per piú di quarant’anni, fino alla morte di Einstein. Questo dibattito è tuttora in corso tra i loro discendenti intellettuali. Einstein fu la prima persona a esprimere chiaramente la necessità di una teoria rivoluzionaria degli atomi e della radiazione, ma non poteva accettare che la meccanica quantistica fosse quella teoria. La sua prima reazione alla meccanica quantistica fu quella di sostenere che era incoerente. Quando non riuscí a dimostrarlo, sostenne invece che la meccanica quantistica dà una descrizione incompleta della natura, che tralascia una parte essenziale del quadro complessivo.
Credo che Einstein non potesse accettare la meccanica quantistica come una teoria definitiva perché si poneva obiettivi scientifici troppo elevati. Era guidato dalla speranza di trascendere l’opinione soggettiva e scoprire un autentico specchio della natura che mostrasse l’essenza della realtà in poche leggi matematiche atemporali. Secondo Einstein, la scienza aspira a cogliere la vera essenza del mondo e quell’essenza è indipendente da noi e può non avere a che fare con ciò che crediamo o che ne sappiamo.
Einstein doveva pensare piú di chiunque altro di avere il diritto di esigerlo perché aveva raggiunto questo obiettivo nelle sue scoperte della relatività generale e della relatività ristretta. Dopo aver gettato le basi della fisica quantistica, cercò di cogliere l’essenza del mondo atomico con una descrizione completa degli atomi, degli elettroni e della luce.
Bohr replicò che la fisica atomica richiedeva una revisione rivoluzionaria della nostra idea di che cos’è la scienza, come del nostro modo di concepire il rapporto tra la realtà e la conoscenza che ne abbiamo. Ciò era dovuto al fatto che noi facciamo parte del mondo, quindi dobbiamo interagire con gli atomi che cerchiamo di descrivere.
Bohr asseriva che, una volta assimilato questo cambiamento rivoluzionario nel nostro pensiero, la completezza della meccanica quantistica sarebbe stata inevitabile, poiché era parte integrante del nostro essere partecipi del mondo che cerchiamo di descrivere. Dalla prospettiva di Bohr, la teoria quantistica è completa nel senso che non possiamo avere una descrizione del mondo piú completa.
Se rifiutiamo queste rivoluzioni filosofiche e ci ostiniamo ad avere un’antiquata concezione di buon senso della realtà e del suo rapporto con le nostre osservazioni e conoscenze, dobbiamo pagare un prezzo di un altro genere. Dobbiamo considerare che ci sbagliamo riguardo a qualche proprietà della natura. Dobbiamo scoprire quale assunto comune è sbagliato e sostituirlo con un’ipotesi fisica radicalmente nuova che apra la strada a una nuova teoria che completerà la meccanica quantistica.
Grazie a una combinazione di teoria ed esperimento, a partire da un articolo pubblicato nel 1935 da Einstein insieme a due collaboratori, conosciamo un aspetto di questo completamento. La nuova teoria deve violare l’assunto comune che le cose interagiscano soltanto con altre cose vicine nello spazio.
Questo è l’assunto della località. In una grossa parte della storia narrata nei capitoli seguenti spiegherò come questa idea sensata debba essere trascesa nella teoria che sostituirà la meccanica quantistica.
Con questo libro mi pongo tre obiettivi. Innanzitutto, voglio spiegare ai non addetti ai lavori quali sono gli enigmi al cuore della meccanica quantistica. Dopo quasi un secolo di studio della fisica quantistica, è notevole che continui a mancare un accordo sulla soluzione di questi enigmi.
Dopo aver spiegato le ragioni del dibattito in modo corre...