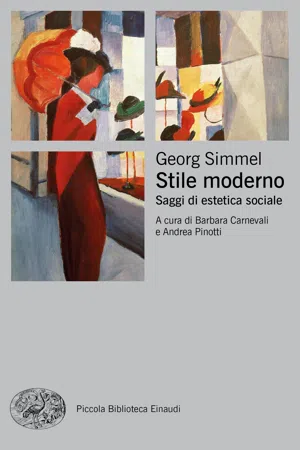Per la maniera in cui ci è dato intendere i fenomeni della vita avvertiamo in ogni punto della nostra esistenza una pluralità di forze tra loro antagoniste; sentiamo anzi che ciascuna di quelle forze aspira a oltrepassare la propria manifestazione effettiva per esplicarsi ad infinitum, salvo trovare un limite in una controforza e quindi trasformare quella tendenza all’assoluto in mera tensione statica, in un anelito. Perché l’uomo è per natura un essere dualistico, il che nulla toglie al carattere unitario del suo agire, anzi: la potenza di quell’unità risulta proprio dal concorso di una pluralità di elementi1. Solo nella misura in cui ciascuna energia interiore preme oltre il limite della propria estrinsecazione visibile la vita acquista quella ricchezza di possibilità non ancora espresse che integra il carattere frammentario della sua realtà fattuale; solo cosí le sue manifestazioni lasciano presagire dietro ogni fenomeno sensibile la presenza latente di forze piú profonde, tensioni piú irrisolte, dissonanze e consonanze di portata piú ampia, irriducibili a ogni datità immediata.
Quel dualismo originario non si può descrivere come tale, senza mediazioni: tutt’al piú si avverte di volta in volta come principio ultimo e forma strutturante alle spalle dei singoli giochi di controforze che caratterizzano la nostra esistenza. La prima indicazione ci viene dalla fisiologia della natura umana, che ha bisogno di moto ma anche di quiete, di produrre ma anche di assimilare. La stessa dinamica agisce nella vita dello spirito: anche a quel livello, per un verso, siamo guidati dall’aspirazione all’universale, mentre al contempo avvertiamo la necessità di cogliere il particolare. Il primo aspetto, la generalità, regala al nostro spirito la quiete, mentre la differenza specifica lo dinamizza, costringendolo a muoversi caso per caso. Qualcosa di molto simile accade nella nostra vita emotiva: ricerchiamo la quieta devozione a persone e cose non meno dell’energica autoaffermazione nei confronti di entrambe. Anzi, la storia della società umana si potrebbe riassumere nella sua interezza dal punto di vista delle lotte, dei compromessi, delle conciliazioni duramente conquistate e subito smarrite che hanno fatto coesistere gli estremi opposti della fusione con il gruppo sociale di appartenenza e il bisogno di risalto individuale. In termini filosofici l’oscillazione della nostra mente tra questi due poli trova espressione nel contrasto fra la dottrina dell’unità del tutto e il principio degli indiscernibili, che ribadisce l’essere-per-sé di ciascuno degli elementi di cui è fatto il mondo, mentre nella sfera della vita pratica si incarna nella lotta fra partiti opposti come il socialismo e l’individualismo. Poco importa: è sempre la medesima forma prototipica di quella dualità che si esprime da ultimo nel fenotipo biologico inteso come sintesi fra ereditarietà e variabilità: l’una veicolo dell’universale, dell’unità, di una placida omogeneità delle forme e dei contenuti della vita; l’altra fonte di dinamismo, portatrice della molteplicità di elementi fra loro distinti, espressione dell’irrequieto divenire che trasforma un contenuto in un altro. Nella storia della nostra specie ciascuna forma essenziale della vita rappresenta (nel rispettivo ambito di esercizio) una modalità specifica della conciliazione tra l’interesse alla durata, all’unità, all’uniformità da un lato e l’interesse per il cambiamento, il caso singolo, la particolarità individuale dall’altro.
Quando il dualismo antagonistico riveste la forma sociale una delle due controforze si traduce di norma nella tendenza psicologica all’imitazione, che è un po’ il corrispettivo interiore dell’ereditarietà biologica: una trasposizione della vita del gruppo nella vita dell’individuo. L’imitazione ci attrae innanzitutto perché rende possibile un agire finalizzato e dotato di senso anche quando non interviene da parte nostra alcun elemento personale e creativo: la si potrebbe dire figlia del pensiero e dell’assenza di pensiero. Trasmette sicurezza all’individuo, facendogli sentire che non è solo nelle sue condotte pratiche; anzi, che le precedenti iterazioni della stessa attività formano sotto i suoi piedi come una solida piattaforma, esonerandolo dalla necessità di giustificarsi da sé in ciascun caso particolare2. Quando imitiamo, deleghiamo ad altri l’onere di manifestare energie produttive, ma soprattutto rimettiamo loro ogni responsabilità per quell’agire: l’imitazione guarisce l’individuo dall’imbarazzo della scelta, facendolo apparire senza mezzi termini come una creatura del gruppo, come un ricettacolo di contenuti sociali. L’impulso a imitare inteso come principio contraddistingue uno stadio intermedio dello sviluppo umano: il desiderio di agire a proprio nome in vista di fini personali si è già dichiarato, però manca ancora la capacità di appagare quel bisogno con mezzi propri, annettendolo a contenuti individuali3. Si oltrepassa quello stadio quando il pensare, l’agire e il sentire si orientano anche in vista del futuro, e non soltanto verso ciò che è dato, consacrato dal tempo, tramandato: l’uomo teleologico è l’opposto polare dell’uomo che imita. In tutti i fenomeni nei quali rientra come fattore costitutivo, di conseguenza, l’imitazione corrisponde soltanto a una delle tendenze primordiali della nostra natura: quella che rifonde il singolo caso nel generale e pone l’accento sull’elemento stabile in ciò che cambia. Quando invece ricerchiamo l’elemento variabile in ciò che permane, la differenziazione individuale, lo scarto dalla generalità, l’imitazione diventa una controforza che agisce da freno. E proprio perché il desiderio di permanere nel dato e fare quello che fanno tutti gli altri è il nemico irriducibile di quell’altro bisogno, che invece ambisce a procedere verso forme di vita nuove e specifiche4, la vita sociale ci appare come un campo di battaglia dove ogni palmo di terreno viene aspramente conteso tra due avversari, con le istituzioni sociali nel ruolo di accomodamenti sempre passeggeri sotto la cui egida l’antagonismo tra i due principî – mai del tutto sopito – assume la forma esteriore di una sinergia.
Ecco delineate le condizioni di possibilità della moda, intesa come un fenomeno che caratterizza senza eccezioni l’intero arco storico della nostra specie. La moda è imitazione di un modello dato, e quindi appaga il bisogno di trovare sollievo nella conformità, instrada il singolo sulla via che tutti percorrono, prescrive un modello generale che fa del comportamento di ciascun singolo un mero esempio tra i molti. Eppure la moda soddisfa al tempo stesso anche l’impulso a diversificarsi, la tendenza alla distinzione, al cambiamento, al risalto individuale. E ci riesce, per un verso, facendo avvicendare senza posa i contenuti che contraddistinguono in maniera specifica la moda del giorno rispetto a quella di ieri o di domani, ma ci riesce anche e soprattutto perché le mode sono sempre mode di classe: perché le mode invalse ai piani alti della società si distinguono da quelle che vigono ai piani bassi, tanto da venire prontamente abbandonate non appena le classi inferiori iniziano a farle proprie. La moda, insomma, non è che una delle tante forme della vita nelle quali si fondono in un’unica condotta la tendenza all’omogeneità sociale e la sete di differenza individuale e varietà. Finora la storia della moda è stata studiata soltanto in rapporto allo sviluppo dei suoi contenuti, ma se ci domandiamo invece quale significato abbia per la forma del processo sociale la moda ci appare come una successione di sforzi volti ad adeguare in maniera sempre piú compiuta l’appagamento di quelle due tendenze contrapposte al grado di sviluppo di volta in volta raggiunto dalla cultura, sul piano individuale e sociale. I singoli tratti psicologici che emergono dallo studio della moda acquistano un senso posizionale in funzione di questa proprietà generalissima.
La moda, come abbiamo già osservato, è un prodotto della divisione in classi, e presenta la struttura di altri dispositivi sociali dello stesso tipo, primo fra tutti il matrimonio, la cui duplice funzione consiste da un lato nel conchiudere un ambito come internamente specifico, dall’altro nel delimitarlo rispetto a tutti gli altri. E come la cornice di un quadro fa dell’opera d’arte un tutto unitario e internamente coeso, un mondo a parte, ma al tempo stesso, agendo verso l’esterno, introduce anche un discrimine che tronca ogni rapporto con lo spazio circostante; e come l’energia di per sé indivisa che inerisce a questi costrutti sociali si può esprimere soltanto scomponendola in un’azione duplice, verso l’interno e verso l’esterno, l’istituto del matrimonio ricava il proprio carattere specifico (e soprattutto la propria legittimità morale, sentita spesso e volentieri come ingiustizia da chi non appartiene a una determinata classe) dal fatto che il singolo individuo incarna e conferma con le proprie nozze anche il carattere specifico e la legittimità morale della cerchia e del ceto di appartenenza. Anche la moda denota da un lato l’attiva coesione centripeta con i propri pari, il carattere internamente unitario di un ambito sociale che in essa trova un contrassegno; eppure dall’altro, e per lo stesso motivo, la moda significa anche chiusura del gruppo nei confronti degli strati sociali inferiori, contrassegnati come estranei a quella cerchia. Congiungere e demarcare sono le due funzioni primordiali che si intrecciano in modo indissolubile in questo fenomeno: e ciascuna delle due operazioni, benché costituisca l’opposto logico dell’altra (anzi, proprio in quanto istanza antagonista), è condizione di possibilità del suo estrinsecarsi. La moda, insomma, è un puro prodotto di necessità sociali5: lo si vede innanzitutto dal fatto che le sue forme non sembrano quasi mai rispondere a finalità di tipo pratico, estetico o altro. Mentre in linea di principio l’abito si adegua sobriamente alle necessità della persona, nei dettami che la moda impone alla sua foggia – gonna larga o gonna stretta, acconciature sviluppate verso l’alto o verso i lati, cravatte nere o variopinte – non c’è la minima traccia di funzionalità. A volte “vanno” cose brutte e sgradevoli, come se la moda volesse dimostrare il suo potere facendoci indossare le invenzioni piú atroci; la sua totale noncuranza per i canoni pratici della vita – chiaro indizio di motivazioni di tutt’altra specie, cioè di natura sociale e formale, le sole che rimangano una volta sottratto l’utile – emerge proprio dal modo del tutto accidentale in cui una volta impone il taglio pratico, un’altra il dettaglio bislacco, una terza soluzioni né comode né belle6. Di quando in quando, è vero, la moda può inglobare contenuti dall’ispirazione pratica, che però agiscono in quanto moda solo a partire dal momento in cui la loro indipendenza da qualunque altro ordine di motivazioni diventa palpabile: un po’ come la scelta di fare il proprio dovere assume un carattere propriamente morale solo quando non è indotta da fattori estrinseci come il contenuto e lo scopo dell’azione, ma solo ed esclusivamente dal fatto che agire in questo o quel modo è nostro dovere. Perciò la tirannia della moda sembra tanto piú insopportabile nei campi in cui dovrebbero invece prevalere ragioni di merito: gli atteggiamenti religiosi, gli interessi scientifici, addirittura il socialismo e l’individualismo vanno ormai soggetti alla moda; e questo nonostante le ragioni per le quali nella vita conviene o non conviene avvicinarsi a quel genere di contenuti – le sole valide – confliggano in maniera flagrante con la totale mancanza di motivazioni oggettive che contraddistingue gli sviluppi della moda7.
Nella misura in cui le forme sociali, gli abiti, i giudizi estetici, l’insieme dello stile in cui l’uomo si esprime si trasformano senza posa per l’azione della moda, se ne ricava che la moda, intesa nel senso di “ultima moda”, compete per definizione alle classi sociali privilegiate. Non appena le classi inferiori cominciano ad appropriarsene, scavalcando i confini definiti dalle classi superiori e minacciando di annacquare l’unità di una reciproca coappartenenza che trovava un simbolo appunto nella moda, i privilegiati volgono le spalle alle tendenze in voga per adottarne subito delle altre, tornando cosí a differenziarsi dalle grandi masse – e il gioco può ricominciare. Come è naturale, infatti, le classi inferiori guardano in alto e aspirano a elevarsi nella gerarchia sociale. E questo riesce loro soprattutto negli ambiti soggetti alla moda, i piú accessibili a un’imitazione esteriore. La stessa dinamica si riproduce tra i diversi strati delle classi piú elevate della società, anche se non sempre con la stessa evidenza palese, quella che invece assume nel rapporto mimetico tra la cameriera e la signora. Anzi, l’esperienza mostra che la corsa all’imitazione da parte degli inferiori e la fuga dei privilegiati verso il nuovo si fa tanto piú frenetica quanto piú contigui risultano tra loro gli ambienti sociali. La progressiva affermazione dell’economia monetaria non può che accelerare in modo rilevante questo processo, oltre a renderlo maggiormente visibile, perché gli oggetti governati dalla moda, che sono un po’ gli accessori della vita, sono anche quelli che è piú facile procurarsi quando si posseggono i mezzi economici: per cui assimilarsi allo strato superiore per il tramite della moda risulta piú agevole che in altri ambiti, dove occorre invece dimostrare capacità individuali non soggette alla compravendita.
Fino a che punto l’essenza della moda dipenda da questo momento di demarcazione, come pure dall’istanza antagonista dell’imitazione, si può osservare studiando la maniera in cui opera nelle società prive di stratificazioni verticali: in questo caso la moda si esplica in orizzontale, tra gruppi dello stesso livello gerarchico. Presso alcune popolazioni indigene, a quanto si legge, certi gruppi sociali strettamente imparentati tra loro che vivono in condizioni identiche tendono talvolta a sviluppare delle mode completamente eterogenee, mediante le quali ciascun gruppo accentua la propria coesione interna e insieme si demarca verso l’esterno. Al tempo stesso amiamo tutti importare mode da fuori, e una cerchia sociale tende ad apprezzarle tanto piú quanto meno le sente come un proprio prodotto: già il profeta Sofonia tuonava contro i notabili che vestono abiti stranieri8. Anzi, le mode di ascendenza esotica sembrano favorire piú di altre la compattezza interna delle cerchie sociali; proprio perché vengono da paesi lontani fanno scattare quella forma peculiare e indicativa di socializzazione che nasce dal riferimento comune a un punto situato al di là di un confine. A volte gli elementi sociali, come gli assi visivi, trovano piú facile convergere a una certa distanza. Non di rado tra i popoli primitivi il denaro, cioè il valore economico per eccellenza, e quindi l’oggetto del piú vivo interesse di tutti, è costituito da simboli che vengono importati da fuori; tanto è vero che in alcune regioni (nelle isole Salomone e fra gli Igbo stanziati sul delta del Niger) fabbricare denaro con conchiglie e altri sostrati del genere – simboli che non hanno alcun corso nel luogo in cui vengono prodotti ma invece serviranno da moneta nei territori attigui in cui saranno esportati – è una specie di industria a parte: un po’ come spesso a Parigi si creano fogge a tavolino perché vengano di moda in altre città. Proprio a Parigi, in effetti, la moda conduce all’espressione piú estrema la tensione e la riconciliazione dei suoi elementi dualistici. In questo campo l’individualismo – cioè la tendenza a vestire in modo personale, a indossare ciò che “dona” – è molto piú radicato in Francia che non in Germania. Al tempo stesso, però, viene rispettato con ogni scrupolo un certo stile generale circoscritto da una cornice che offre margini di tolleranza piuttosto ampi: la moda del giorno; per cui la manifestazione individuale, pur distinguendosene, non cade mai al di fuori della generalità.
Quando viene a mancare anche una sola delle due tendenze sociali contrapposte che devono convergere affinché possa darsi la moda – cioè da un lato il bisogno di serrare i ranghi, dall’altro quello di differenziarsi – vengono meno anche la moda stessa e il suo regno decade. Per questo ai piani bassi della società esistono pochissime mode, rare e specializzate; per questo le mode delle popolazioni indigene sono molto, molto piú stabili delle nostre. Data la loro struttura sociale9, infatti, è assente anche quel pericolo di mescolarsi e confondersi che induce le classi sociali dei popoli piú sviluppati a differenziarsi per mezzo dell’abito, del comportamento, dei gusti ecc. I sottogruppi interessati a distinguersi dagli altri producono unità interna proprio grazie a queste differenziazioni: è evidente che l’abito contribuisce in misura essenziale a definire l’andatura, il “tempo”, il ritmo dei gesti, per cui chi veste in modo simile si comporta anche in modo relativamente omogeneo10. Per la vita moderna, con la sua disgregazione individualistica, questo momento di omogeneità interna è particolarmente importante. E per lo stesso motivo tra le popolazioni indigene la moda è un fenomeno meno presente, cioè le fogge risultano piú stabili, perché molto meno pronunciato è anche il bisogno di impressioni e di forme di vita nuove, del tutto a prescindere dalla loro efficacia sociale. Il ritmo con cui cambia la moda è un indice dell’assuefazione agli stimoli nervosi: quanto piú un’epoca è eccitabile, tanto piú rapidamente si succederanno le sue mode, perché il bisogno di stimoli differenziali, uno dei fattori costitutivi di ogni moda, va di pari passo con l’infiacchimento delle energie nervose. Già solo per questo le classi piú elevate sono il vero locus della moda. Per quanto concerne le ragioni meramente sociali del fenomeno, due popolazioni primitive che abitano territori confinanti offrono esempi quanto mai indicativi della sua duplice finalità di coesione ed esclusione. I Xhosa presentano una stratificazione sociale molto articolata, e tra loro si riscontra un cambiamento abbastanza rapido delle mode, sebbene l’uso di abiti e ornamenti sia governato da precise restrizioni suntuarie, mentre tra i vicini San (o Boscimani), dove non si sono mai formate delle classi sociali, la moda non ha mai preso piede: non si riscontra cioè alcun interesse per il rinnovamento di abiti e ornamenti. Di quando in quando le stesse ragioni di ordine negativo hanno inibito il formarsi di mode nelle fasi di massimo splendore di una cultura, ma questa volta in chiave pienamente consapevole e deliberata. Nella Firenze del 1390 circa non sembra essere esistita alcuna moda maschile dominante, perché ciascuno procurava di vestire a modo proprio. In questo caso manca uno dei due momenti, il bisogno di esprimere coesione, senza il quale non può darsi alcuna moda. Sappiamo d’altra parte che i nobili veneziani non hanno mai sviluppato una moda specifica, perché una legge imponeva loro di vestirsi tutti di nero per non rendere troppo visibile alle masse l’esiguità del loro numero. In questo caso la moda viene meno perché manca l’altro momento costitutivo, cioè perché si è voluta evitare di proposito la differenziazione dalle classi inferiori11.
La moda, secondo la sua essenza, è praticata per definizione da una parte ristretta del gruppo, mentre il resto della collettività è sempre e solo in cammino verso la moda. Quando una moda ha impregnato l’intero tessuto sociale, cioè quando tutti senza distinzione fanno quello che in origine facevano in pochi, come è stato per alcuni aspetti dell’abito e per alcune cosiddette buone maniere, nessu...