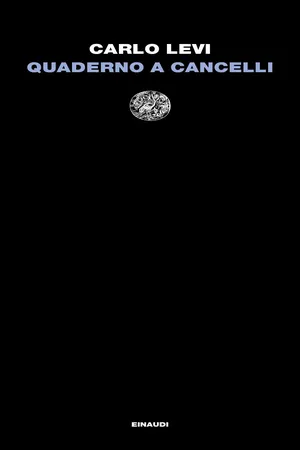Qui si può scrivere un libro, un libro intero, anche lunghissimo e sterminato: altrettanto lungo e sterminato, e anche piú, < > del tempo e dello spazio dell’impedimento. Girarsi attorno, anche con ozio o per puro divertimento, anche per parentesi e follie o assonanze o rime o somiglianze o ricordi o estri o capovolgimenti o capriole o ruzzoloni o salti mortali o giri di fianco o numeri di destrezza o veroniche o federiche o gertrudi o tori picassiani e altri piú flacos come dovrebbero essere i tori di un eroe cervantesco le cui corna non fossero in verità che temibili attaccapanni a cui appendere idee cosí vetuste da parere ed essere nuove, e i cui garretti düsseldorfiani cotti in pentole sigillate servissero da porzioni triple, per otto o dodici RR. fra ricordi napoleonici, eroici all’andata e antieroici al ritorno, o viceversa.
L’andata va sempre bene, naturalmente e sempre eroicamente, perché sempre spinta in avanti come a eros conviene. Ma anche il ritorno a eros è necessario. Je t’aime moi non plus: e perciò sulla Karl Strasse (o come altrimenti si chiamasse) le stesse persone alle stesse finestre e agli stessi angoli di strada con le stesse insegne di negozi e di scarpai e di piatti di fine porcellana e monete e stampe e carni e salsicce, applaudivano con le stesse facce e con pari e opposta direzione il ritorno delle prime armate francesi rivoluzionarie; e le stampe erano del tutto identiche salvo che nella differenza speculare delle destre e sinistre invertite. Speculare, o temporale, del prima e del poi, o del dentro e del fuori, del concavo e del convesso. Il pittore aveva voltato le bandiere, gli sguardi, le direzioni, né c’era molta differenza fra <i>francesi vittoriosi che andavano a est e gli stessi che tornavano vinti a occidente, e che poi del resto sarebbero tra poco passati per la terza volta oltre il Reno vincenti (e poi molti anni dopo) ripassati la quarta perdenti, fino a una quinta e sesta e settima e cosí via con alterna e identica vicenda. Queste passeggiate salutari, questo struscio della storia che pareva il solo modo di divertirsi e di conoscersi e combinare matrimoni, era tuttavia monotono come le sere delle feste nei villaggi. Legittimi, oh, legittimi, e feroci sempre esili, «i vili esili» del nostro coraggioso vate. Ma se l’esilio si comporta come ambivalenza intercambiabile, e non c’è servitú che non sia tirannica, né tirannia che non sia servile, se non c’è prima senza poi (se non c’è né prima né poi nel tempo vero che non scorre), e il valore o il significato dell’errore, o della inesistenza o della morte non sono che nel senso di un astratto movimento, la svastica rovesciata, l’albero di Yin e Yang, l’antiorario, il vortice agli antipodi, e se il concavo e il convesso non differiscono che sessualmente dal punto della visione, e possono essere riportati in piano, ricordo un grande cerchio rosso e nero, di antichissimo velluto vaticinante con strade o fiumi o vasi ramificati [?] e non abitate pianure e mari oscuri e monti microscopici e frastagliati e diversamente colorati, fino a farsi lucenti al riflesso di un sole: rosso se umano o di tenero vitello, rosa di pecora, giallo di leone, verde fosforescente splendido ipnotico di gatto: come doppie lune guardanti nella notte e giudicanti. Forse la Luna che abbiamo sporcato oh, con microscopiche sabbie sporcizie e polveri, non è che la retina del cielo che ci guarda, e meglio ci vede quanto meno abbagliata risplende. Ci guarda dai suoi monti e mari immaginari, dalle sue indifferenti gelide, non palpitanti solitudini.
Non palpitante, non amata, non narici, arida asciutta indifferenza, almeno all’aspetto. La retina luna non <è> percorsa da invasioni di false luci ma malata di false luci, di neve supposta e allegramente scioccamente sperata, campi lunari appaiono nel buio, che sembrano piuttosto periferia, luoghi di scarico pieni di calcinacci e di polvere, con sentieri vaghi tracciati dai passi dei ragazzi fruganti furtivi in cerca di qualche metallo oggetto o legno per la stufa, e soprattutto mattoni rotti colore del fango secco. In mezzo, quasi bassorilievi, in una sostanza arborescente e frondosa, dei visi di uomini barbuti, classici da basso Impero. Ma quello che prevale è il deposito, lo scarico, che non ha forma definita per l’arrivo di altri carri che versano con grida dei carrettieri (<non umani>) i loro sempre nuovi contenuti di cose demolite, decadute, degenerate, distrutte, desolate, disgregate, disunite, distorte, divelte, divertite e divertenti e divergenti. Residui che sembrano veri e vicini e che la mano tesa non incontra, che talvolta persistono a lungo come il disegno di una città immaginaria poetica vista dall’alto o da una prospettiva inedita, talvolta si sciolgono d’un tratto.
Quasi sempre terra rossastra e polverosa pestata e resa compatta da passi innumerevoli, talvolta appoggiata a muri di mattoni antichi, come ruderi anch’essi polverosi e compatti di tempo compresso. E su queste superfici e basi di muri e terra e detriti, posano [?] numerose, come viste con l’ingigantimento di una luce radente, pelli negre microfotografate. Mondo intriso di nebbia, della sua immobilità non tanto caotica quanto sclerosata in forme insensate, pieno di un interno supposto movimento, e soprattutto malgrado ciò serissimo Cristo barbuto e bello da vedere, portato a dileguarsi e a sparire per mancanza di permanenza, di presenza, di sostegno (il Cristo è diventato una specie di guerriero di profilo, classicamente allegro, ridente senza ragione come Stefano fenicio idiota sulla spiaggia). Ma il nero, la notte innuziale, feroce, tragica, edipica, o calderoniana di Sigismondo-Giobbe, fiera e fieno sopra il suo strame nella torre della Ingiustizia, questa notte è invece ambigua e gogoliana, da anime morte, o notturne di Mirabella Imbaccari. È un sogno (e quindi non piú notte, vittoria sulla oscurità) in luogo incerto tra Italia e vecchia Russia (Tula, o meglio Orël [Oryol]). Io abito in una famosa pasticceria della piccola città che ha stanze superiori non importanti, ma tutte con parquet di legno lucidissimo, e soprattutto (luogo centrale dell’azione) una lunga scala di legno lucido e perfettamente incerato, che porta, curvandosi in alto e in basso, a un enorme salone di pasticceria che ha l’ingresso a vetri sulla strada all’estremo angolo opposto alla scala che porta alle sale superiori. In questa pasticceria salone, tenuta da brava gente non so se russa o italiana di provincia, convinta [?] di dover fare qualcosa di artistico e moderno (forse sono di Cuneo), vive un inglese o scozzese uomo di mare con odore di salsedine e di ostriche e alghe, e vuol portarmi con sé, ma sempre la cosa viene rimandata per trascurabili inconvenienti, che si svolgono sempre sui predellini del treno sbuffante e fischiante e lanciante vapore allegro alla stazione di Orël. L’inglese fuma sempre. C’è anche una fotomodella sovietica (un tipo alla moglie di Sportelli Zdenka) che racconta una storia senza senso di due francobolli su un <piccolo paese nella nebbia dei mari> del Nord, dove erano successi <… …>. Uno dei due francobolli, dove lei aveva applicato la sua graziosa lingua coprendosi [?] la bocca come nei dettami classici, non era stato approvato dalla burocrazia: l’altro, stampato, aveva una storia: che lei, uscita dalla sala di trucco e sartoria per posare per il disegno del francobollo, si era accorta che non le avevano detto che cosa dovesse fare davanti ai disegnatori o fotografi del francobollo: con un pretesto aveva preso un taxi per andare a consultarsi a casa con la sorella e i familiari. Sul taxi aveva chiesto di salire una signora elegante: le aveva consigliato di cambiarsi le scarpe con suole altissime che portava con altri stivali piú normali. Ma aveva dimenticato di spiegarle che avrebbe dovuto aprire la bocca come a gridare evviva perché si trattava del varo di una nave. E cosí aveva posato con la bocca chiusa e il francobollo era stato stampato con questo inconveniente <…> imprevisto. Intanto si preparava un film italo franco sovietico, per il cui inizio e lancio ci sarebbe stata una conferenza stampa importantissima nella pasticceria di cui ero ospite. La conferenza avrebbe dovuto essere presieduta da un Amidei-Volonté, con grossa cena, molto importante anche come protesta politico-culturale. C’era stata una prova generale in pasticceria, ottima, con paste buonissime, folla elegantissima, allegria. Il pavimento era però coperto per i lavori di rinnovo non finiti. Si trattava di lavori di incastri figurati in legni diversi, che dovevano sostituire altri piú antichi e in cattivo stato fatti da ebanisti e artisti esperti e abilissimi, si voleva con essi ritrovare un filo popolare italo inglese sovietico, come formelle e intarsi moderni. Viene il giorno dell’inaugurazione atteso. Scendo per lo scalone incerato, ma sotto c’è poca gente in disordine. In fondo, verso la porta di ingresso alcuni che protestano e si meravigliano. Dalla mia parte dove si dovrebbero distribuire i pasticcini, c’è solo un signore venuto da qualche ora per dare del pane nero speciale al suo cane, e la zana, con lui e il <cane dentro>, è chiusa da catenelle. In mezzo c’è Amidei-Volonté con due o tre compagni seduti con ciambelline, uno grasso di schiena (Orson Welles), che sospettano capiscono che non potranno fare la conferenza stampa che tutto è compromesso, che tutto è perduto, ma forse… Il boicottaggio, la protesta, lo scherno, le risate sono nati dai lavori di intarsio e di alta ebanisteria, nel gusto dei cacciatori di Cuneo, che eseguiti superbamente sono considerati da competenti e membri di Italia Nostra come uno scandalo intollerabile che deve essere punito e beffeggiato. A me dispiace [?] per i padroni della pasticceria, delusi, che non capiscono affatto la tragedia (del resto i nuovi intarsi ben lucidati non mi sembrano peggiori dei vecchi). Mi chiedono il mio parere (con la solita aria di saperlo già). Mentre sto per smentirli mi mostrano fuori del locale, sui paramenti, sulla porta della chiesa antica, su tutti i dintorni, a perdita d’occhio in città dappertutto, intarsi della stessa mano e natura: capponi nei piatti, galli che fanno chicchirichí, cacciatori seduti a tavola con contadinelle e fucili appoggiati al comò. La cosa si fa seria, senza rimedio né possibile difesa dei poveri pasticceri cosí zelanti. Intanto i cineasti restano soli aspettando nella sala <da> pranzo intarsiata chissà quale impossibile aiuto dall’alto. Sono le tre e mezza. Per la prima volta ho dormito, sono fresco. Teresina mi parla della Callas e di Pasolini.
Cosí parlo in piemontesese (in piemontesese) con Lucia. L’ordine della Clinica, come quello della Prigione o della Caserma e di tutti gli Ordini, è straordinariamente <duro>. Ma quello che resta è quel grande ricciolo di legno intarsiato ben lucidato a specchio con cui termina in alto la scala a chiocciola di legno lucido, il ricciolo opposto in...