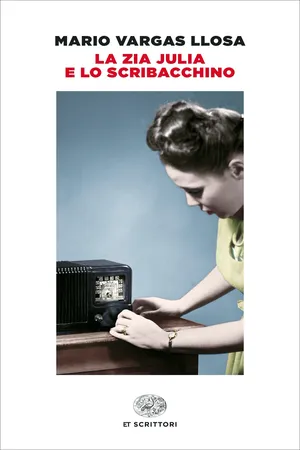Nella notte del Callao, umida e buia come la bocca di un lupo, il sergente Lituma si rialzò il bavero del cappotto, si sfregò le mani e si accinse a compiere il proprio dovere. Era un uomo nel fiore dell’età, la cinquantina, rispettato da tutta la Guardia Civil; aveva servito nei commissariati piú scomodi senza lamentarsi e il suo corpo conservava ancora qualche cicatrice delle sue battaglie contro il crimine. Le carceri del Perú ribollivano di malfattori cui aveva infilato le manette. Era stato citato come esempio in ordini del giorno, lodato in discorsi ufficiali, e, per due volte, decorato: ma quelle glorie non avevano alterato la sua modestia, grande come la sua prodezza e la sua probità. Da un anno prestava servizio nel Quarto Commissariato del Callao e già da tre mesi era incaricato della piú dura incombenza che il destino può serbare per un sergente del porto: la ronda notturna.
Le remote campane della chiesa di Nuestra Señora del Carmen de la Legua scoccarono la mezzanotte, e, sempre puntuale, il sergente Lituma – fronte spaziosa, naso aquilino, sguardo penetrante, rettitudine e bontà nello spirito – cominciò a camminare. Alle sue spalle, falò nelle tenebre, restava il vecchio edificio di legno del Quarto Commissariato. Immaginò: il tenente Jaime Concha stava leggendo Paperino, le guardie Mocos Camacho e Manzanita Arévalo stavano zuccherandosi un caffè appena fatto e l’unico arrestato della giornata – un borsaiolo sorpreso in flagrante sull’autobus Chucuito - La Parada e condotto al commissariato, con abbondanti contusioni, da mezza dozzina di furibondi passeggeri – dormiva tutto raggomitolato sul pavimento della cella.
Iniziò il suo percorso dal rione di Puerto Nuevo, dov’era di servizio il Chato Soldevilla, uno di Tumbes che cantava tondero1 con voce ispirata. Puerto Nuevo era il terrore delle guardie e degli investigatori del Callao perché nel suo labirinto di casupole di assi, latte, lamiere di zinco e mattoni crudi, solo un’infima percentuale dei suoi abitanti si guadagnava il pane come portuari o pescatori. La maggior parte erano vagabondi, ladri, ubriachi, drogati, ruffiani e froci (per non menzionare le innumerevoli prostitute) che con qualsiasi pretesto si aggredivano a coltellate e, talvolta, a spari. Quel rione senza acqua corrente né fognature, senza luce e senza asfalto, si era tinto non poche volte del sangue di rappresentanti della legge. Ma quella notte era eccezionalmente pacifico. Mentre, inciampando in pietre invisibili, con volto aggrondato per il tanfo di escrementi e materie in decomposizione che saliva alle narici, percorreva i meandri del quartiere in cerca del Chato, il sergente Lituma pensò: «Il freddo ha spedito a letto presto i nottambuli». Perché si era in agosto, nel cuore dell’inverno, e una nebbia densa che tutto cancellava e deformava, e una pioviggine tenace che infradiciava l’aria, avevano trasformato quella notte in un che di triste e di inospitale. Dove si era cacciato il Chato Soldevilla? Quel frocione di Túmbez, spaventato dal freddo o dai delinquenti, era capace di essersene andato a cercare il calduccio e da bere nelle osterie dell’avenida Huáscar. «No, non si azzarderebbe, – pensò il sergente Lituma. – Sa che io faccio la ronda e che se abbandona il suo posto, se la vedrebbe brutta».
Incontrò il Chato sotto un lampione, all’angolo di fronte al Deposito Frigorifero. Si sfregava le mani con furia, il suo volto era scomparso dietro una sciarpa spettrale che gli lasciava liberi solo gli occhi. Quando lo vide, spiccò un balzo e si portò la mano alla cartuccera. Poi, riconoscendolo, fece scattare i tacchi.
– Mi ha spaventato, signor sergente, – disse ridendo. – Cosí, in lontananza, che usciva dall’oscurità, l’ho presa per uno spirito.
– Macché spirito dei miei stivali, – gli diede la mano Lituma. – Hai creduto che fossi un malvivente.
– Con questo freddo non ci sono malviventi in giro, figurarsi, – si fregò di nuovo le mani il Chato. – Gli unici matti che stanotte se ne vanno in giro all’intemperie siamo lei e io. E quelli lí.
Indicò il tetto del Deposito e il sergente, sforzando la vista, riuscí a scorgere mezza dozzina di avvoltoi appollaiati e col becco fra le ali, che formavano una linea retta sull’orlo della lamiera. «Che fame devono avere! – pensò. – Anche se gelano, lí possono sentire odor di morto». Il Chato Soldevilla gli firmò il rapporto alla sciapa luce del lampione, con una matitina masticata che gli si perdeva fra le dita. Non c’erano novità: né incidenti, né delitti, né sbronze.
– Una notte tranquilla, signor sergente, – gli disse, mentre lo accompagnava per qualche isolato, verso l’avenida Manco Cápac. – Spero che continui cosí, finché non mi avranno dato il cambio. Poi, può anche cascare il mondo, porco diavolo.
Scoppiò a ridere, come se avesse detto qualcosa di molto spassoso, e il sergente Lituma pensò: «Certe guardie hanno proprio una bella mentalità». Come se avesse indovinato, il Chato Soldevilla aggiunse, serio:
– Perché io non sono come lei, signor sergente. A me questo trantran non piace. Indosso l’uniforme solo per mangiare.
– Se dipendesse da me, non la indosseresti, – mormorò il sergente. – Io lascerei nel corpo solo quelli che ci credono al trantran.
– La Guardia Civil rimarrebbe piuttosto vuota, – rispose il Chato.
– Meglio soli che male accompagnati, – si mise a ridere il sergente.
Anche il Chato si mise a ridere. Camminavano nel buio, per i terreni abbandonati che circondano lo stabilimento Guadalupe, dove i monelli fracassavano sempre a sassate i fanali dei lampioni. Si udiva il rumore del mare in lontananza, e, di tanto in tanto, il motore di qualche taxi che attraversava l’avenida Argentina.
– A lei piacerebbe che fossimo tutti eroi, – disse d’improvviso il Chato. – Che sacrificassimo l’anima per difendere queste immondizie –. Indicò il Callao, Lima, il mondo. – Ce ne sono forse riconoscenti? Non ha sentito cosa ci gridano dietro per strada? Forse che qualcuno ci rispetta? La gente ci disprezza, signor sergente.
– Qui ci salutiamo, – disse Lituma, al bordo dell’avenida Manco Cápac. – Non uscire dalla tua area. E non farti cattivo sangue. Non vedi l’ora di lasciare il corpo, ma il giorno in cui ti congederanno soffrirai come un cane. Cosí è successo a Pechito Antezana. Veniva al commissariato a trovarci e gli si riempivano gli occhi di lacrime. «Ho perso la mia famiglia», diceva.
Udí che, alle sue spalle, il Chato grugniva: – Una famiglia senza donne, che razza di famiglia è?
Forse il Chato aveva ragione, pensava il sergente Lituma, mentre avanzava per il viale deserto, in mezzo alla notte. Era vero, la gente non amava i poliziotti, si ricordava di loro solo quando aveva paura di qualcosa. E allora? Lui non si faceva in quattro affinché la gente lo rispettasse o lo amasse? «Della gente non me ne importa un’acca», pensò. E allora perché non prendeva la Guardia Civil come i suoi colleghi, senza ammazzarsi, cercando di passarsela il meglio possibile, approfittandone per riposare o per guadagnarsi qualche sporco sol se i superiori non erano vicini? Perché, Lituma? Pensò: «Perché a te piace. Perché, come ad altri piacciono il calcio o le corse, a te piace il tuo lavoro». Gli venne da pensare che la prossima volta che qualche patito del calcio gli avesse domandato: «Sei tifoso dello Sport Boys o del Chalaco, Lituma?», gli avrebbe risposto: «Sono tifoso della Guardia Civil». Rideva, nella nebbia, nella pioviggine, nella notte, contento della sua trovata, e in quel mentre udí il rumore. Diede un balzo, portò la mano alla cartuccera, si fermò. L’aveva preso cosí alla sprovvista che si era quasi spaventato. «Ma solo quasi, – pensò, – perché tu non hai avuto paura né ne avrai, tu non sai cosa voglia dire quella parola, Lituma». Aveva alla sua sinistra i terreni abbandonati e alla destra la mole del primo dei depositi della Stazione marittima. Di lí era venuto: molto forte, un frastuono di casse e latte che precipitano trascinando nella loro caduta altre casse e latte. Ma adesso tutto era di nuovo tranquillo e si udiva soltanto lo sciacquio lontano del mare e il sibilo del vento che si spezzava contro le lamiere e si impigliava nei reticolati del porto. «Un gatto che inseguiva un topo e che ha fatto cascare una cassa e questa un’altra ed è diventata una frana», pensò. Pensò al povero gatto, spiaccicato vicino al topo, sotto una montagna di colli e di barili. Era già nell’area del Choclo Román. Ma era chiaro che il Choclo non era lí intorno; Lituma sapeva benissimo che era all’altra estremità della sua area, al Happy Land, o al Blue Star, o in qualsiasi altro dei baretti e postriboli da marinai che si avvicendavano in fondo al viale, in quella stradina che i buontemponi del Callao chiamavano la via delle creste di gallo. Doveva essere lí, contro uno di quegli scheggiati banconi, a scolarsi una birretta. E, mentre camminava verso quegli antri, Lituma pensò alla smorfia di paura che avrebbe fatto Román se lui gli fosse spuntato alle spalle, d’improvviso. «Sicché beviamo alcolici in servizio. Ti sei fregato, Choclo».
Era avanzato di un duecento metri e si fermò di botto. Girò il capo: lí, nell’ombra, con una parete appena illuminata dal riflesso di un lampione miracolosamente indenne dalle fionde dei monelli, muto ora, stava il deposito. «Non è un gatto, – pensò, – non è un topo». Era un ladro. Il suo petto prese a pulsare con forza e sentí che la fronte e le mani gli si inumidivano. Era un ladro, un ladro. Rimase immobile per qualche secondo, ma sapeva già che sarebbe tornato indietro. Ne era sicuro: aveva sentito già altre volte quei palpiti. Sfoderò la pistola e le tolse la sicura e impugnò la pila con la mano sinistra. Tornò indietro a balzi, sentendo che il cuore gli usciva dalla bocca. Sí, sicurissimo, si trattava di un ladro. All’altezza del deposito si fermò di nuovo, ansante. E se non era uno solo? Non era meglio cercare il Chato, il Choclo? Scosse il capo: non aveva bisogno di nessuno, lui bastava e avanzava. Se erano diversi, peggio per loro e meglio per lui. Ascoltò, premendo la faccia contro il legno: silenzio completo. Udiva soltanto, in lontananza, il mare e qualche macchina. «Macché ladro d’Egitto, Lituma, – pensò. – Stai sognando. Era un gatto, un topo». Gli era passato il freddo, sentiva caldo e stanchezza. Aggirò il deposito, cercando l’uscio. Quando l’ebbe trovato, alla luce della pila verificò se la serratura era stata forzata. Stava già per andarsene, dicendosi «che cantonata, Lituma, il tuo fiuto non è piú quello d’una volta», quando, in un movimento macchinale della sua mano, il disco giallognolo della pila gli mostrò la breccia. Era a pochi metri dalla porta; l’avevano fatta maldestramente, rompendo il legno a colpi di ascia o a calci. Il foro era abbastanza grande per un uomo a carponi.
Aveva il cuore agitatissimo, impazzito. Spense la pila, verificò se la pistola era senza sicura, si guardò intorno: solo ombre e, in lontananza, come fiamme di cerini, i lampioni dell’avenida Huáscar. Riempí di aria i polmoni e, con tutta la forza di cui era capace, ruggí:
– Mi circondi questo magazzino con i suoi uomini, caporale. Se qualcuno tenta di scappare, fuoco a volontà. Svelti, ragazzi!
E, affinché fosse piú credibile, fece qualche corsetta da una parte all’altra, con grande scalpiccio. Poi appiccicò la faccia al tramezzo del deposito e gridò, a squarciagola:
– Siete fottuti, vi è andata male. Siete circondati. Cominciate a uscire da dove siete entrati, l’uno dietro l’altro. Trenta secondi per farlo con le buone!
Ascoltò l’eco delle sue grida che si perdevano nella notte, e, poi, il mare e qualche latrato. Contò non trenta ma sessanta secondi. Pensò: «Ci fai la figura del pagliaccio, Lituma». Ebbe un accesso di collera. Gridò:
– Aprite gli occhi, ragazzi. Alla prima, me li fate secchi, caporale!
E, risolutamente, si mise a carponi e aggattandosi, agile nonostante i suoi anni e l’uniforme pesante, varcò la breccia. Dentro, si raddrizzò senza fretta, in punta di piedi corse da un lato e incollò la schiena alla parete. Non vedeva niente e non voleva accendere la pila. Non udiva alcun rumore ma aveva di nuovo una sicurezza totale. C’era qualcuno lí, rannicchiato nel buio, come lui, che ascoltava e tentava di vedere. Gli sembrò di sentire un respiro, un ansito. Aveva il dito sul grilletto e la pistola all’altezza del petto. Contò fino a tre e accese. Il grido lo prese cosí alla sprovvista che, per la paura, la pila gli sfuggí dalle mani e rotolò a terra, rivelando balle, colli che sembravano di cotone, barili, travi, e (fugace, intempestiva, inverosimile) la figura del negro nudo e rattrappito, che tentava di coprirsi la faccia con le mani, e, tuttavia, guardava fra le dita, con gli occhiacci spaventati, fissi sulla pila, come se il pericolo potesse venirgli solo dalla luce.
– Calmo o ti faccio secco! Calmo o sei morto, zambo! – ruggí Lituma, cosí forte che gli fece male la gola, mentre, chino, smanacciava cercando la pila. E poi, con soddisfazione selvaggia: – Ti sei fregato, zambo! Ti è andata male, zambo!
Gridava cosí forte che si sentiva stordito. Aveva ricuperato la pila e il fascio di luce svolazzò in cerca del negro. Non era fuggito, era lí, e Lituma spalancava gli occhi, incredulo, dubbioso di quanto vedeva. Non era stata una visione, un sogno. Era nudo, sí, cosí com’era venuto al mondo, perché non si copriva le vergogne, che gli sballonzolavano allegramente, alla luce della pila. Era sempre raggomitolato, con la faccia mezzo nascosta fra le dita, e non si muoveva, ipnotizzato dal cerchio di luce.
– Mani in alto, zambo, – ordinò il sergente, senza avanzare verso di lui. – Tranquillo se non vuoi del piombo. Sei in arresto per aver invaso una proprietà privata e per girare con i gemellini all’aria.
E, nello stesso tempo – le orecchie all’erta per cogliere il minimo rumore che denunciasse qualche complice nelle ombre del deposito – il sergente si diceva: «Non è un ladro. È un pazzo». Non solo perché era nudo in pieno inverno, ma per l’urlo che aveva cacciato al momento di essere scoperto. Non era da uomo normale, pensò il sergente. Era stato un rumore stranissimo, qualcosa fra l’ululato, il raglio, la risata e il latrato. Un rumore che non sembrava unicamente della gola ma anche della pancia, del cuore, dell’anima.
– Ho detto mani in alto, perdiana, – gridò il sergente, facendo un passo verso l’uomo. Questi non obbedí, non si mosse. Era molto scuro, cosí magro che nella penombra Lituma distingueva le costole che tend...