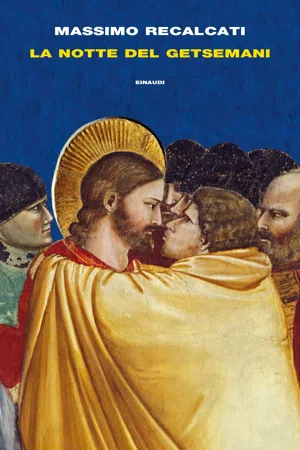Le citazioni della Bibbia sono tratte dall’edizione Cei (2008).
1. Cfr. PIER PAOLO PASOLINI, Trasumanar e organizzar (1971), Garzanti, Milano 2002.
2. Cfr. JACQUES LACAN, Il Seminario. Libro VII. L’etica della psicoanalisi (1959-1960), Einaudi, Torino 2016, p. 155.
3. Cfr. ID., Il Seminario. Libro VIII. Il transfert (1960-1961), Einaudi, Torino 2008.
4. Cfr. ID., Il Seminario. Libro X. L’angoscia (1962-1963), Einaudi, Torino 2007, p. 109.
5. Tutti questi interrogativi sono centrali nel mio Contro il sacrificio. Al di là del fantasma sacrificale, Raffaello Cortina, Milano 2017.
6. «Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo» (Gv 10,9).
7. JACQUES DERRIDA, Donare la morte (1999), Jaca Book, Milano 2002, p. 87.
8. Per un approfondimento di tutti questi temi, rinvio sempre a RECALCATI, Contro il sacrificio cit.
9. Cfr. Gn 3,1-13. Per questi versetti resta imprescindibile il commento di PIERANGELO SEQUERI, Il timore di Dio, Vita e Pensiero, Milano 1993, pp. 51-72.
10. PLATONE, Apologia di Socrate, in Id., Tutte le opere, a cura di G. Pugliese Carratelli, Sansoni, Firenze 1988, pp. 26-41.
11. LACAN, Il Seminario. Libro VIII cit., p. 108.
12. La prima ad aver interpretato la figura di Gesú a partire dalla forza del desiderio è stata FRANÇOISE DOLTO, I Vangeli alla luce della psicoanalisi. La liberazione del desiderio (1977), et al., Milano 2012.
13. La disputa storica sull’appartenenza o meno di Giuda allo zelotismo (movimento patriottico-religioso che interpretava il messianismo come liberazione politica della terra palestinese dal dominio romano) è controversa e non rientra nei limiti della mia riflessione. Cfr. MARTIN HENGEL, Gli zeloti. Ricerche sul movimento di liberazione giudaico dai tempi di Erode I al 70 d.C. (1961), a cura di G. Firpo, Paideia, Brescia 1996.
14. Cfr. JACQUES LACAN, Il Seminario. Libro XX. Ancora (1972-1973), Einaudi, Torino 1983, p. 67.
15. Utilizzo qui una traduzione lievemente diversa da quella Cei (2008) adottata per le altre citazioni: I Vangeli. Marco Matteo Luca Giovanni, a cura di G. Gaeta, Einaudi, Torino 2006, p. 323.
16. Su questo carattere fondamentale del rapporto di Gesú con la dimensione sensuale e immanentistica della vita, rimando, tra gli altri possibili riferimenti, a tutta la lettura che Enzo Bianchi ha sviluppato della figura di Gesú. Si veda, per esempio, ENZO BIANCHI, Gesú e le donne, Einaudi, Torino 2016.
17. Ho provato a mettere in evidenza il carattere sovversivo di questa sua predicazione antisacrificale in RECALCATI, Contro il sacrificio cit.
18. Le parole dimenticate di Gesú, a cura di M. Pesce, Vangelo degli Ebioniti, Mondadori, Milano 2004, p. 111.
19. Gilbert Keith Chesterton, citato in SLAVOJ ŽIŽEK, La paura di quattro parole: un modesto appello per una lettura hegeliana del cristianesimo, in SLAVOJ ŽIŽEK e JOHN MILBANK, La mostruosità di Cristo (2009), Transeuropa, Massa 2010, p. 95.
20. In Silence, in realtà, Dio parla, rompendo il suo silenzio, ma solo quando uno dei due giovani monaci gesuiti missionari in Giappone decide, dopo aver visto uccidere spietatamente i suoi fedeli, di abiurare per salvare la propria vita e quella dei suoi altri fratelli che altrimenti sarebbero morti (inutilmente) con lui, sacrificati alla Causa. Dio, in sostanza, parla solo quando la vita sa essere situata dal monaco portoghese come «insacrificabile» a ogni Dio e a ogni religione, quando, in altre parole, la vita del «prossimo» si situa, in quanto tale, al posto di Dio, rivelandosi, appunto, come «insacrificabile». La preghiera, dunque, non si limita a esaudire i voti dell’orante, ma modifica profondamente la sua postura consentendogli di avere un’altra visione delle cose. Cfr. DIETRICH BONHOEFFER, Imparare a pregare, Qiqajon, Magnano (BI) 2015.
21. Gesú non chiama gli uomini verso una nuova religione della Legge, ma verso la vita come «insacrificabile» di fronte a ogni possibile versione della Legge. Per questo evita che la discordia che si genera al momento del suo arresto precipiti in un conflitto armato tra religioni contrapposte. Invitando il discepolo (Pietro?) che avrebbe voluto proteggerlo dai soldati a rimettere la spada nel proprio fodero, egli mostra che il Dio cristiano non esige alcuna guerra nel suo nome. Piuttosto Gesú assume soggettivamente il passo di una donazione senza riserve nel nome della Legge del suo desiderio. Non vuole far pagare ad altri le conseguenze delle sue scelte. In questo senso può assistere alla fuga spaventata dei suoi discepoli di fronte ai suoi aguzzini senza richiamarli a intraprendere alcuna azione in sua difesa.
22. Cfr. RECALCATI, Contro il sacrificio cit.
23. Il rapporto tra Gesú e Giobbe è, non a caso, al centro della lettura proposta da CARL GUSTAV JUNG, Risposta a Giobbe (1952), Bollati Boringhieri, Torino 2007. Sulla figura di Cristo come risposta a Giobbe, si vedano anche le osservazioni di ŽIŽEK, La paura di quattro parole cit.
24. DIETRICH BONHOEFFER, Resistenza e resa. Lettere e altri scritti dal carcere, in Opere di Dietrich Bonhoeffer, vol. VIII, Queriniana, Brescia 2002, p. 498.
25. MARTIN HEIDEGGER, Essere e tempo (1927), Longanesi, Milano 1976, pp. 460-61, formula il paradosso di questo movimento singolare: scegliere la propria eredità.
26. Ricordiamoci delle ultime parole di Gesú sul «giudizio universale» riportate da Matteo che precedono il ciclo della passione. In questo giudizio il Figlio dell’Uomo dividerà gli uomini: da una parte coloro che hanno saputo «ereditare il Regno» offrendo accoglienza allo straniero, al povero, al malato, all’assetato, all’affamato; coloro che non hanno indietreggiato nei confronti dell’eteros. Alla destra del Signore sono, dunque, i «salvati», coloro che hanno saputo fare esperienza della mancanza e dell’amore. Dall’altra parte, invece, alla sinistra del Signore, sono i «maledetti», coloro che non sono stati in grado di interpretare in modo giusto l’eredità del Regno, che hanno rigettato la mancanza e l’amore. Per i primi il volto di Dio si è confuso con quello del prossimo; essi hanno visto il Padre nel Figlio e Dio nell’uomo. Hanno fatto all’uomo quello che Dio chiede che sia fatto a Lui. Gli altri, invece, si sono negati all’uomo e, quindi, si sono negati a Dio, perdendo l’occasione del Regno. Il giudizio della Legge sembra spietato e non conosce perdono. La colpa dei «maledetti» è quella di non aver amato, di aver rigettato la mancanza in tutte le sue figure. Il «giudizio universale» separa gli ...