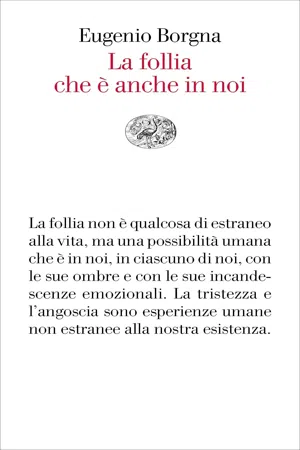La psichiatria è entrata negli ospedali civili, e fa parte del servizio sanitario nazionale; ma cambiare e migliorare radicalmente le strutture e i modi di fare psichiatria non basta se, come ancora oggi avviene, si dà esclusiva importanza ai farmaci, e se la cura non si nutre di attenzione e di ascolto, di sensibilità e di passione, di vicinanza emozionale, e di capacità nel cogliere il senso che si nasconde nella sofferenza psichica, nella follia, e se non si è consapevoli della enorme importanza che nella cura hanno le parole. L’homo faber, l’homo robot, dilaga in noi, nella vita di ogni giorno, e in psichiatria, che nondimeno non può non essere orientata alla relazione, al colloquio, donando a chi sta male tutto il tempo necessario. Solo se la psichiatria del futuro saprà recuperare questi valori, che le mie pagine vorrebbero ora ricostruire nelle loro linee essenziali, rinasceranno gli ideali che hanno animato l’opera di Basaglia, e che oggi tendono ad essere oscurati da una psichiatria divorata dalla tecnica che è il nocciolo conoscitivo del DSM.
Il cuore della riforma.
La conseguenza radicale e sconvolgente della legge di riforma è stata la chiusura degli ospedali psichiatrici, e questo, a quarant’anni dalla sua realizzazione, non può non essere continuamente ricordato nella sua rivoluzionaria significazione storica; ma non sono sempre ricordate le premesse teoriche che sono state a fondamento del pensiero e dell’azione di Basaglia, e alle quali la psichiatria del futuro dovrebbe guardare con estremo interesse e con quella leopardiana passione della speranza che ho invocato. Il cuore della rivoluzione, che ha cambiato il modo di fare psichiatria, si rispecchia in quello che Basaglia ha scritto: noi psichiatri non possiamo non andare alla ricerca di un ruolo che non abbiamo mai avuto, e che ci consente, per quanto è possibile, di metterci alla pari con chi sta male in una dimensione in cui la malattia, come categoria, è messa fra parentesi. Solo cosí è possibile entrare in immediata relazione di cura con chi è immerso nell’angoscia e nella tristezza, nell’inquietudine e nella disperazione, nelle allucinazioni e nei deliri, e ha bisogno di essere accolto e aiutato nel suo dolore e nella sua dignità ferita. Non potrei ora non dire che la psichiatria manicomiale non è scomparsa nel concreto agire di non pochi psichiatri, e continua a svolgersi nella esclusiva attenzione alla malattia, e non alla interiorità, alla soggettività, alla storia della vita dei pazienti; ignorando la radicale importanza delle emozioni nella conoscenza e nella cura della sofferenza psichica: non piú considerata come qualcosa da analizzare con la freddezza di un chirurgo che taglia e ricompone un organo malato, ma come ferita viva e sanguinante da curare con sensibilità e gentilezza, con vicinanza emozionale e introspezione, con insonne immedesimazione nella storia della vita di chi sta male, cosí da rifondare una psichiatria aperta agli orizzonti della psichiatria sociale. Insomma l’opera di Basaglia, lo vorrei ripetere, non si comprende fino in fondo se non è ricondotta alle sue sorgenti che sono state quelle fenomenologiche; e non è la mancanza di strutture alternative alla ospedalizzazione, o di adeguate forme di assistenza alle famiglie dei pazienti, a non consentire di realizzare le istanze normative della legge di riforma, ma la mancata valorizzazione degli ideali etici e sociali che ne sono a fondamento.
A questi ideali, alla loro realizzazione, dovrà guardare una psichiatria del futuro che intenda essere umana e gentile.
Le mete ideali.
La psichiatria ideale non potrà nel futuro non avviarsi alla eliminazione delle contenzioni e degli elettroshock, come forma crudele di terapia delle schizofrenie, e delle depressioni, e non potrà non confidare in una nuova generazione di psichiatri che sappiano trovare slancio e immaginazione per rilanciare e ricostruire modelli perduti di fare psichiatria che si richiamino a quelli che hanno cambiato gli orizzonti di senso della psichiatria manicomiale. Come dare un’anima alla rivoluzione incompiuta non è possibile dire, e nemmeno prevedere, anche se i sentieri ne sono tracciati nelle loro attese e nelle loro speranze, nella loro concretezza e nella loro storicità, nelle iniziative che Basaglia ha immaginato, e ha realizzato. Sarà necessaria una rivoluzione complementare, vorrei chiamarla cosí, che ridia slancio e passione ai contenuti della legge, dalle straordinarie implicazioni teoriche e pratiche, e che sconfigga le indifferenze e le inerzie degli psichiatri, e della opinione pubblica, divenuta estranea al tema che, negli anni Settanta, ha accompagnato coralmente il lavoro di superamento del manicomio. La disattenzione politica nei confronti della psichiatria, dei problemi umani e sociali della psichiatria, ha molto concorso nell’indebolire e nel mettere fra parentesi i grandi ideali della legge, ed è a questi che bisogna tornare, magari storicizzandoli nei modi applicativi, ma senza pensare a inutili modifiche, o integrazioni, che distraggano dalla considerazione dei roventi problemi ancora non risolti: quello dei servizi ospedalieri di psichiatria nei quali, come dicevo, si continuano a contenere i pazienti, a tenere le porte chiuse, e le finestre gelidamente sbarrate, che accentuano nei pazienti la solitudine autistica, e quello della somministrazione di spropositati cocktail farmacologici stralciati dai contesti relazionali che non possono non essere di natura psicoterapeutica e socioterapeutica.
Non dimenticare.
Il drago dell’oblio è sceso crudelmente sui luoghi del deserto manicomiale, su questi luoghi di infinito dolore, e di indicibile solitudine. Un’epoca, la nostra, nella quale si vive il presente, e nel presente, dimenticando il passato, e non guardando al futuro, che non può non riannodarsi al passato: come ci dice la splendida immagine di sant’Agostino che definisce la speranza come memoria del futuro. Non si può capire cosa sia la psichiatria, se non si riflette sugli abissi di dolore che si accompagnava alla sofferenza psichica, alla sua solitudine e al suo isolamento in manicomio, e che contrassegnava i giorni e le notti di persone giovani e di persone anziane, di persone giovani che divenivano anziane, senza mai muoversi magari da un locale, da uno stesso locale, o magari da una sedia, da una stessa sedia. Non tutti i manicomi erano cosí: non lo era, lo vorrei ancora ripetere, quello di Novara, almeno nella sua parte femminile, nel quale siamo riusciti in tempi anche brevi a ricreare condizioni umane e gentili di vita. Sí, la follia femminile sa resistere meglio al dolore, e sa esprimere il dolore con emozioni e con parole piú intense, e creatrici; e dare parole al dolore, farne partecipare un altro da noi, significa almeno un poco mitigarlo. Le parole di queste pazienti sono raccolte nei miei libri, e sia pure nel tempo brevissimo di un mattino sono state salvate dal naufragio, e dal silenzio. Sono parole che nella mia memoria sono ricollegate alle lacrime e al sorriso, alla gentilezza inerme e indifesa delle pazienti; e questa è stata talora la psichiatria manicomiale.
Alla memoria delle persone ferite nella loro anima si dovrebbe accompagnare la memoria dei luoghi da loro abitati, e da loro vissuti nel dolore e nella speranza contro ogni speranza, anche se ora sono presenti solo alla memoria di chi li ha conosciuti. Sono luoghi, sigillati dal dolore, dei quali dovremmo avere cura e rispetto: come di cose che sono state segnate dalla sofferenza. Sono cose che, lo vorrei ripetere, nelle scuole, anche in quelle primarie, dovrebbero essere ricordate e illustrate; e questo al fine di fare capire cosa sia la sofferenza psichica, di quale sensibilità, e di quale fragilità, sia nutrita, e come possa manifestarsi in ciascuno di noi. Solo cosí – la cosa è avvenuta in alcune scuole austriache –, si smorzerebbero i pregiudizi ancora dilaganti che considerano la sofferenza psichica una forma di vita estranea alla condizione umana, e destituita di senso; ignorandone la gentilezza e la tenerezza, la solitudine e la disperazione, la nostalgia di un sorriso e di una lacrima.
Sono indicazioni, queste, che si comprendono nel loro radente significato umano solo se la psichiatria sia riconosciuta e sia vissuta nella sua articolazione non solo tecnica, e scientifica, ma etica, che la psichiatria del futuro dovrebbe cercare disperatamente di realizzare nella sua complessa e ardente ricchezza umana: inconciliabile con la sua riduzione a scienza naturale.
Le parole in psichiatria.
Non si è mai data grande importanza, in psichiatria, alle parole che si rivolgono ai pazienti: non pensando alle risonanze dolorose che le parole indifferenti e crudeli trascinano con sé. Un tema, già svolto in alcuni miei lavori, certo, che vorrei ora riformulare brevemente nell’orizzonte di una psichiatria che dal passato e dal presente si progetti in un futuro intessuto di speranza, e indirizzato al rispetto della fragilità e della dignità della follia. Un tema al quale, in una psichiatria rifondata eticamente sulle macerie di quella manicomiale, non si può non dare grande importanza nell’orizzonte di quella che dovrebbe essere la psichiatria del futuro, e al quale non ci si dovrebbe mai stancare di pensare. Un tema che nei testi di psichiatria clinica non è nemmeno accennato, e semmai liquidato come arcaico e antiscientifico. Ne vorrei invece ancora una volta sottolineare l’enorme significazione diagnostica e terapeutica, e non solo in psichiatria.
Da Hugo von Hofmannsthal, un grande scrittore austriaco del secolo scorso, dalla straordinaria sensibilità e dalle grandi intuizioni psicologiche, le parole sono chiamate creature viventi. Nascono, si modulano, si modificano, cambiano, negli incontri che abbiamo in vita, ridestando risonanze emozionali molto diverse: talora serene e gioiose talora dolorose e scarnificanti. Sono impegnative per chi le dice, e per chi le ascolta, cambiano nel loro significato nella misura in cui cambiano i nostri stati d’animo, le nostre emozioni e le nostre passioni; e cosí non è facile coglierne fino in fondo le risonanze che destano in noi e negli altri. Una volta dette, non ci appartengono piú, e cambiano in arcana relazione con il linguaggio del sorriso e delle lacrime, degli sguardi e dei gesti, e del silenzio: sí, anche il silenzio parla, bisogna saperlo ascoltare, ed esserne in dialogo senza fine. Il cammino delle parole, di quelle che diciamo, e di quelle che ascoltiamo, è misterioso. Le parole, che sono belle e creatrici in un determinato contesto, possono non esserlo in un altro, ed è necessario saperle riconoscere nelle loro luci e nelle loro ombre, nei loro orizzonti aperti alla speranza e in quelli chiusi alla speranza.
Quando la psichiatria si confronta con esperienze complesse, come sono quelle psicotiche, avrebbe ancora piú bisogno di parole fragili e silenziose che siano capaci di creare relazioni di cura. Senza queste parole non è possibile fare riemergere il discorso infinito del dolore e dell’angoscia, della tristezza e della disperazione, delle inquietudini del cuore e dei trasalimenti dell’anima, delle voci e del silenzio, che fanno parte di ogni condizione umana di sofferenza. In particolare, le parole da dire ad una paziente depressa, smarrita e disperata, devono essere in sintonia con il suo modo di vivere il tempo: vive nel passato, e il futuro rinasce lentamente a mano a mano che la malattia si spegne. Ancora meno facili le parole da dire ad una paziente lacerata dalle ombre di una schizofrenia – ci sono nondimeno forme lievi e forme gravi – che la rende sensibile ad ogni parola che non sia gentile e attenta a non destare insicurezza, o sentimenti di persecuzione. La psichiatria del futuro non consideri futili, o rapsodiche, queste apparenti divagazioni linguistiche, sí, sconosciute alle psichiatrie manicomiali, e non solo.
Le parole che non fanno male.
Non troveremo mai le parole che non fanno male, e che aiutano le persone che vivono nel dolore, se non essendo capaci di immedesimarci nelle loro emozioni, e di riviverle per quanto è possibile in noi. Non ci sono ricette, non ci sono consigli, in questo campo, ed è solo necessario affidarsi alle antenne leggere della intuizione e della sensibilità personali. Ci sono psichiatri e psicologi che non le hanno, e persone semplici che le hanno: sono antenne almeno in parte innate, anche se piú, o meno, educabili in ciascuno di noi. Certo, non si comunica con la sofferenza psichica se non quando si evitano parole indistinte e banali, ambigue e indifferenti, glaciali e astratte, crudeli e anonime. Se non siamo tristi, o ansiosi, inquieti, o disperati, le parole, anche quelle infelici, non ci toccano molto, ma, se lo siamo, o lo siamo stati, le risonanze emozionali a queste parole crescono in noi dolorosamente: lasciando ferite sanguinanti che non guariscono. Ancora: se non stiamo bene, e come può non accadere almeno in alcune stagioni della nostra vita, non potremmo mai ascoltare parole come «pazzia», «matto», «utente di servizi di psichiatria», «pericoloso», o una parola come «demenza» (sbandierata con terribile leggerezza dinanzi a qualche défaillance della memoria in persone anziane, che non si liberano piú da questa etichetta, nemmeno quando la diagnosi sia sbagliata), senza sentirci inutilmente lacerati da ferite che non guariscono talora mai piú.
Sono parole, queste, che fanno del male anche a chi le dice; desertificandone la interiorità.
Non solo in psichiatria.
Come ha scritto un grande oncologo francese, David Khayat, le parole hanno un grande potere: sono in grado di portare la speranza nel cuore dei pazienti, sono il dono di una particella di umanità che insieme al sapere tecnico il medico deve tenere viva nel suo cuore. Molte volte alla sua consulenza giungevano persone ferite dalle parole troppo dure, inumane, che i medici avevano detto loro. Le parole di un medico, oncologo, o non oncologo, non sono mai incolori, non sono mai neutrali, o insignificanti, e lasciano tracce profonde nel cuore di una paziente, o di un paziente, che ne è in dolorosa attesa. (Queste parole so di non trovarle nei testi di psichiatria, e di trovarle invece, ad ese...