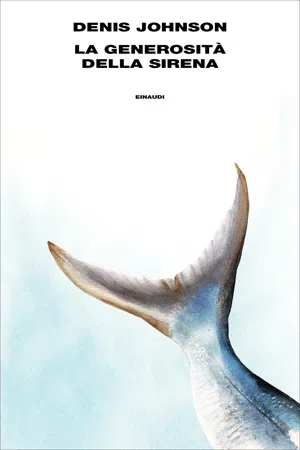Ieri, 8 gennaio 2016, era l’ottantunesimo anniversario della nascita di Elvis Presley. Sono passati due giorni da quando ho saputo che il poeta Marcus Ahearn (noi lo chiamiamo Mark) è stato arrestato, o trattenuto, una settimana fa per aver scatenato un pandemonio a Graceland, la tenuta della famiglia Presley a Memphis. Di fatto, Mark è stato fermato per avere danneggiato, o tentato di danneggiare, la tomba di Elvis Presley. Le bravate di un poeta non si guadagnano titoli sui giornali. Ho saputo dei guai di Mark da amici comuni. E mi sono detto che è caduto, infine, tra le fauci dei poteri che ha infastidito e tormentato per quasi quarant’anni: dico quarant’anni perché so che il 29 agosto 1977, quando era ancora minorenne, Mark partecipò con altre persone al tentativo di depredare la tomba originale di Presley nel cimitero di Forest Hill a Memphis, un tentativo – immancabilmente corredato, nei resoconti dei giornali, dall’aggettivo «bizzarro» – che portò al trasferimento dei resti di Elvis, insieme a quelli di sua madre Gladys Love Smith Presley, nella tenuta di Graceland, dove ora madre e figlio riposano al sicuro, fianco a fianco, in due identiche bare di rame da quattrocento chili l’una… E Mark mi ha confessato, a tu per tu, che poco dopo la mezzanotte dell’8 gennaio 2001, al debole chiarore di una falce di luna, era entrato nel cimitero di Priceville vicino a Tupelo, in Mississippi, aveva dissotterrato una bara in miniatura da una tomba senza lapide e l’aveva forzata per spogliarla del suo contenuto, cioè il cadavere del gemello di Elvis Presley, Jesse Garon Presley, nato morto.
Nella misura in cui possediamo un elenco di autentici poeti, Marcus Ahearn ne fa certamente parte. Lo conobbi nel 1984, mentre tenevo un laboratorio di poesia alla Columbia. Mark aveva poco piú di vent’anni. Io ne avevo trentacinque. Avevo già tenuto alcuni laboratori di quel genere nel decennio precedente, analizzando faticosamente i versi di studenti di ogni tipo, non solo i dottorandi dei laboratori di scrittura, ma anche i bambini dei programmi di «poesia nelle scuole» finanziati dallo stato, i pensionati dei corsi d’arte dei centri ricreativi, e una volta, per piú di un anno, i rapinatori, i contrabbandieri e i gangster di una prigione federale, chiedendomi, piú o meno costantemente: i miei lavori sono migliori dei loro? Le prime cinque o sei poesie di Marcus Ahearn mi fornirono la risposta. Quella sí che era poesia, verso dopo verso di autentica poesia, e mentre tenevo in mano quei fogli un’angoscia segreta allentò la stretta sul mio cuore, e io accettai il fatto che non sarei mai stato un poeta, ma solo un insegnante di poesia.
Mark aveva il look giusto: giacche di tweed, pantaloni cascanti di velluto a coste e cardigan voluminosi. Aveva una capigliatura da poeta, tempestosi riccioli color rame, e una faccia molto gradevole, liscia come quella di una bambola, con rotondi occhi azzurri da bambola e guance rosa da bambola. Naso a patata, bocca piccola, un sorriso ammaliante che sfoggiava volentieri. Era pieno di fascino. Quando entrava in classe si percepiva un’atmosfera di benvenuto. Non sembrava che gli altri fossero infastiditi dal suo talento. Forse non lo vedevano neppure.
Dunque. Dov’è cominciato il mio coinvolgimento in questa storia? In quell’aula della Columbia, è logico, con i suoi pavimenti di legno rovinati, le finestre alte, il soffitto lontano – un eccesso di spazio acustico che creava, almeno nelle mie orecchie, un’eco beffarda di tutto quel che dicevamo. Presumo che fossimo seduti intorno a un tavolo, e che quei bravi studenti di ogni estrazione sociale esplorassero nuove idee in un’atmosfera di generosità intellettuale e sostegno reciproco mentre io mi annoiavo, poi mi irritavo, e infine morivo dalla voglia di sentire qualcosa di stupido e assurdo. Era il momento, insomma, che il professore dicesse la sua. Può darsi che abbia cominciato con un aneddoto, uno dei miei preferiti, su Frank Sinatra: dopo aver cantato America the Beautiful alla convention democratica del 1956, Sinatra venne avvicinato da Sam Rayburn, un deputato texano settantaquattrenne che era stato eletto in ventidue legislature e all’epoca era da sedici anni presidente della Camera. Rayburn prese il cantante per un braccio e implorò: «Canta The Yellow Rose of Texas, figliolo», al che Sinatra rispose: «Giú le mani dal mio vestito, maniaco». Questo probabilmente mi ricordò un’altra delle battute di Sinatra, pronunciata nel 1955, quando descrisse il rock’n’roll di Elvis Presley come «un afrodisiaco che puzza di rancido». Elvis! E di punto in bianco comincio a dibattermi nella trappola della passione e della memoria, rivivendo per i ragazzi la sera del 1957 in cui io, bambino di terza elementare, mi trovavo in un cinema pieno soprattutto di adolescenti e battevo le mani con loro al ritmo dei numeri musicali di Elvis Presley in Jailhouse Rock, e tutti quanti formavamo un’unica, sinistra entità sessuale infantile governata solo dal ritmo della giungla nel buio – «solo dalle pulsazioni», scommetto di aver detto, «del nostro sangue». Sarebbe stato il momento giusto per affrontare un qualche aspetto dei nostri studi – il ritmo, perdio –, e invece cado preda di riflessioni ossessive e parlo troppo a lungo del mio sconcerto per il fatto che l’Elvis insulso e noioso degli ultimi anni non somiglia affatto all’Elvis del 1957. «I disinformati», è probabile che abbia detto, «attribuiscono quel cambiamento alle droghe, ma per me la colpa è del manager di Presley, il “Colonnello” Tom Parker, un letale campione di mediocrità. Nel 1957 Parker aveva già cominciato a iniettare la sua melma paralizzante nella creatura incandescente e vorticosa che era Elvis Presley, e all’inizio del 1958 lo consegnò all’esercito americano perché lo sciogliesse e ne facesse colla». A questo punto, ne sono certo, avrò cercato di chiudermi la bocca con un’osservazione che faccio spesso: «Non fu l’assassinio di Kennedy nel 1963 a spezzare la schiena al secolo americano: fu l’arruolamento di Elvis Presley nel 1958», dopodiché il mondo assistette all’evaporazione di Elvis, alla rasatura delle sue basette, alle foto in cui appariva impacciato nell’uniforme con i bottoni d’oro, all’annuncio che lo snello, ardente androgino di Jailhouse Rock si era messo a studiare il karate. E questa trasformazione era stata fomentata dal «Colonnello» Tom Parker, «che non era affatto un colonnello, ma solo un soldato semplice di fanteria, espulso dall’esercito perché disertore e psicopatico». Sono io che picchio sul tavolo? Qualcuno lo sta facendo. «E ascoltatemi! Fate attenzione ora! Dentro ciascuno di noi vive un avvelenatore come il Colonnello Tom Parker». A questo punto sono in piedi, sto gridando, probabilmente piangendo – il mio matrimonio, mi sono dimenticato di dirlo, è ingarbugliato; le mie finanze stanno andando in fumo; e la mia cattedra di poesia in questa prestigiosa università è appesa a un filo, una circostanza che non c’entra nulla con la qualità del mio insegnamento, che è mediocre, o con le mie poesie, che sono disoneste, e invece c’entra con le politiche accademiche, che non so gestire –, e allora sí, grido e piango, ordino ai miei studenti di lasciarmi solo, di andarsene, tornare a casa: «Sedetevi alla scrivania senza penna, senza carta, e anche senza parole. Frugatevi dentro il cuore e tirate fuori il Colonnello Parker che è in voi, aprite le fauci, masticatelo bene, riducetelo in poltiglia nelle budella e cacatelo fuori – proprio cosí, espelletelo! – e poi portatemelo spalmato sulla pagina!» E dalla prima all’ultima parola di quel monologo il giovane poeta di talento Marcus Ahearn non avrà smesso di fissarmi con quei lucidi occhi da bambola, anche se in quel momento, agitato com’ero, senz’altro non l’avrò notato.
Con tutta probabilità quello fu il giorno in cui mi sbattei la porta dell’aula alle spalle, percorsi il corridoio con passo deciso fino all’ufficio del direttore del programma di scrittura creativa della Columbia, un uomo molto, molto gentile, e gli dissi: – Vaffanculo. Tu e il tuo programma. E questi studenti. Incoraggiarli è un crimine. Mi licenzio –. E cosí via, ancora per un bel po’. Quell’uomo mi affrontò con grande professionalità. Tenne le mani unite davanti a sé sulla scrivania, le dita intrecciate, la testa piegata, e mi ascoltò. A intervalli di cinque secondi annuiva. Non mi diede ragione né mi contraddisse quando affermai che Ahearn era un poeta mentre gli altri erano congenitamente mediocri, che il nostro programma di scrittura equivaleva a uno schema di Ponzi accademico, a una truffa letteraria… Quando esaurii le parole, lui si schiarí la gola, mi assicurò che capiva il tormento e i dubbi che mi opprimevano, lodò la mia franchezza, addirittura il mio coraggio, e mi fece promettere che non avrei piantato in asso quei giovani ma sarei arrivato alla fine del semestre, alla quale, dopotutto, mancavano solo tre lezioni. Mi strinse la mano. Ci separammo da amici. Si chiamava Dusseldorf. Aveva scritto alcuni libri e nessuno li aveva comprati, e quel giorno… si comportò cosí. Percorsi i corridoi, scesi le scale e uscii nell’Upper West Side di Manhattan nel crepuscolo di aprile, mi misi a camminare e aspettai che il tramonto chiudesse il coperchio su uno dei cinque episodi piú imbarazzanti della mia vita.
Il coperchio, tuttavia, non voleva chiudersi. La mente teneva a distanza il cielo. La mente ripercorreva la scena recente, spiegava, negava, componeva, correggeva, e tutto con una voce piagnucolosa. Nel frattempo, la città gridava e pulsava. Negli anni Ottanta, Manhattan aveva una pulsazione esaltante, potente, ma simile a quella di una ferita. Vi ricordate? Senzatetto come prigionieri di campi di sterminio. Venditori ambulanti come guerriglieri. Gioco delle tre carte. Spazzatura dappertutto. Come sono sopravvissuto a quell’attacco su piú fronti, come ho fatto ad attraversare la strada senza venire ucciso da una macchina, non riesco a immaginarlo. Forse mi ha salvato Marcus Ahearn. Può darsi che quello sia stato il giorno in cui Marcus Ahearn mi affiancò sulle strisce pedonali, mi prese per un braccio e disse: – Professor Harrington! Un’altra lezione disastrosa, – e la nostra amicizia cominciò.
È del tutto possibile che sia stato quel giorno. Sto solo tirando a indovinare. E allora? Il Passato semplicemente non c’è piú. Quel che ne resta, secondo me, è piú che altro finzione. Siamo arenati qui con uno sdrucito patchwork di memoria, voi con la vostra e io con la mia, e nella mia venti minuti dopo sono seduto con Marcus Ahearn in un parchetto dove spesso mi rifugiavo in quei giorni, un minuscolo triangolo verde dove 106th Street incrocia Broadway e poi, immediatamente, West End Avenue: un paio di panchine tra querce appena germogliate, sporadici piccioni, scoiattoli smaniosi e anche grossi ratti di fiume, migrati dall’Hudson che scorre a pochi isolati da lí, assimilati dalla cultura dell’Upper West Side e adattatisi a vivere come scoiattoli. Questi ratti stanno in piedi su due zampe, implorano il cibo e mangiano dalle mani dell’uomo. Mentre bevevamo caffè nei bicchieri di carta, Mark disse: – Lei è molto appassionato di Elvis Presley.
– Quel discorso è saltato fuori da solo.
– È saltato fuori, – concordò lui, – e si è messo a correre senza pantaloni.
– Era per chiarire un concetto.
– Sul Colonnello Tom Parker.
– Il colonnello ha rovinato Elvis. Lo ha prosciugato e scolorito.
Mark tolse il coperchio del bicchiere e scrutò i fondi del caffè, interrogandoli: – Alla Columbia University importa, anche marginalmente, di quello che succede in classe? Voglio dire, – e qui si girò a guardarmi, – delle sue crisi e dei suoi crolli nervosi?
– Attacchi di bile.
– Le creano problemi per le sue sfuriate?
Sí, ero pazzo. Da qualche parte fra le pagine di un pesante manuale, la diagnosi mi stava aspettando. Ma in quel momento ero il professor Kevin Peter Harrington che discuteva con uno studente, moralmente obbligato a proteggerlo dall’abisso del mio mondo interiore, l’abisso «che ci separa», come ha osservato il poeta Nicanor Parra, «dagli altri abissi».
Cosí mi limitai a dire: – Lei scrive magnificamente.
– Non è la cosa piú importante che faccio.
Poi tacque. Mi sentii sollecitato a rivolgere l’ovvia domanda: mi sentii sollecitato, e cosí puntai i piedi e non gli chiesi quale fosse la cosa piú importante.
Lui cambiò argomento senza fare una piega. – Lei ha ragione a definire il colonnello «letale».
– Chi lo ha definito letale?
– «Un letale campione di mediocrità»: è stato lei a definirlo cosí.
– Buon per me.
– Il colonnello, sa, era sospettato di aver ucciso una donna quando era giovane. Letale. Concorda perfettamente con una mia teoria sulla vita e la morte di Elvis.
– Come mai questa attrazione per Elvis Presley? Non è fuori tempo massimo? Quanti anni ha?
– Ne ho compiuti ventiquattro lo scorso settembre –. E poi mi forní i dettagli: Charles Marcus Ahearn (ma non menzionò il Charles; quello venne fuori piú tardi), nato il 10 settembre 1959 a Potomac, un sobborgo di Washington, nel Maryland; il padre era un medico, specialista in malattie del fegato e per quasi vent’anni vicedirettore degli Istituti nazionali di sanità; la madre, che aveva tenuto il discorso di commiato il giorno della propria laurea allo Smith College, era una rispettata bibliografa dilettante (delle poetesse Marianne Moore ed Elizabeth Bishop) e un’attivista per i diritti degli animali. Mark aveva frequentato le scuole pubbliche, diplomandosi nel 1977 alla Winston Churchill High di Potomac, l’unico istituto scolastico di mia conoscenza che prende il nome da un personaggio non americano. I genitori di Mark, abbastanza vecchi da poter essere i suoi nonni, lo avevano cresciuto in un’atmosfera di benevola tolleranza e gradevole ordine e, al momento della nostra conversazione nel parchetto, vivevano ancora insieme nella casa che Mark aveva conosciuto dall’infanzia fino all’età di diciotto anni, quando li aveva lasciati per andare al Williams College. L’improvvisa morte del suo unico fratello, di undici anni piú grande di lui, gli aveva procurato la sola ferita duratura della sua infanzia. Mentre passava l’estate a lavorare in una foresta nazionale da qualche parte nel Nord-Ovest, prima di cominciare gli studi a Harvard, questo fratello, Lancaster, soprannominato Lance, era precipitato dalla cima di un altissimo sempreverde. Cosa ci facesse lassú non sono riuscito a chiederlo. E se fosse stato qualcosa di sciocco, una scommessa fra ubriachi, un folle e puerile impulso scimmiesco? O peggio, un suicidio?
– Mio fratello Lance, – disse Mark, – era un ragazzo leggendario. Aveva un carisma spontaneo, del tutto irresistibile per quelli della sua età, e anche per i piú giovani, come me, che annaspavano in un caos brufoloso mentre Lance viveva ogni minuto come se lo avesse provato prima, da rocker strafico in jeans e stivali, sfrecciando per tutta la contea di Montgomery con una vecchia spider MG di un rosso sbiadito senza piú tettuccio, estate e inverno, con pioggia e neve, come se lasciasse una scia ardente nel cielo. Le ragazze lo veneravano, e lui poteva scegliere quelle che voleva; deve averne deflorate decine. Nelle scazzottate era una specie di Errol Flynn, danzava qua e là come ...