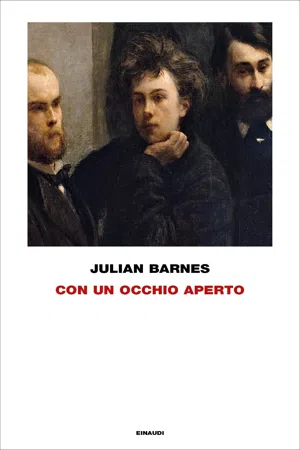I.
Tutto ebbe inizio con un presagio.
Avevano doppiato Capo Finisterre e facevano rotta verso sud spinti da un vento fresco quando un branco di piccoli delfini circondò la fregata. I passeggeri a bordo si affollarono a poppa e lungo i parapetti, meravigliandosi per la destrezza con cui gli animali avevano accerchiato il vascello che navigava già spedito a nove o dieci nodi. E mentre tutti ammiravano lo spettacolo dei delfini, un grido squarciò l’aria. Un mozzo era caduto in mare a babordo, scivolando da un oblò di prua. La pistola di segnalazione esplose un colpo, la zattera di salvataggio fu gettata in acqua e la nave si fermò. Ma l’impaccio delle manovre rallentò le operazioni e, quando la pesante scialuppa a sei remi fu calata in acqua, era già troppo tardi: la zattera era scomparsa e del ragazzo non c’era piú traccia. Aveva soltanto quindici anni e chi lo conosceva sostenne che aveva bracciate robuste e che molto probabilmente aveva raggiunto la zattera a nuoto. In tal caso doveva essere morto a seguito di sofferenze atroci.
La spedizione in Senegal comprendeva quattro imbarcazioni: una fregata, una corvetta, un fluyt e un brigantino. Era salpata dall’isola di Aix il 17 giugno 1816 con 365 persone a bordo, ma ora procedeva verso sud con il suo equipaggio ridotto di un’unità. Fecero provviste a Tenerife, rifornendosi di vini pregiati, arance, limoni, baniani e ogni sorta di ortaggi. Fu in quella occasione che notarono il comportamento depravato dei locali: le donne di Santa Cruz, sull’uscio di casa, esortavano i francesi a entrare, fiduciose che la gelosia dei mariti sarebbe stata risanata dai monaci dell’Inquisizione pronti a condannare la smania coniugale quale dono accecante di Satana. Riflettendoci, i passeggeri avevano attribuito tali costumi al sole del Sud il cui potere, com’è noto, scioglie ogni freno inibitore – naturale e morale.
Da Tenerife il viaggio riprese verso sud, sud-ovest. Nuovi venti e inettitudine nautica dispersero la flottiglia. La fregata, sola, attraversò il tropico e circumnavigò Cap Barbas. Procedeva lambendo la costa, ritrovandosi a tratti a mezza cannonata di distanza. Il mare era cosparso di scogli; i fondali troppo bassi per i brigantini. Avevano doppiato Cap Blanc, o almeno questa era la loro convinzione, quando si trovarono nelle acque basse; lo scandaglio veniva gettato ogni mezz’ora. All’alba Monsieur Maudet, guardiamarina di turno, in piedi su una stia di polli, fece i suoi calcoli e stabilí che si trovavano sull’orlo del banco di Arguin. Nessuno gli diede credito, ma persino i meno esperti si accorsero che il mare aveva cambiato colore; sul fianco della nave comparvero molte alghe e la pesca fu abbondante. Nelle acque immobili e con un’aria cristallina era ormai chiaro che si sarebbero arenati. Lo scandaglio misurava diciotto braccia; poco dopo sei. La fregata, ondeggiando piano, sbandò quasi subito; lo fece una seconda volta, poi una terza, infine si arrestò. L’apparecchio, questa volta, segnava cinque metri e sessanta centimetri.
Per disgrazia, avevano urtato il banco con l’alta marea. Le acque si facevano via via piú agitate e i tentativi di disincagliare la nave fallirono: la fregata era perduta di sicuro. Poiché le scialuppe non erano abbastanza capienti da contenere l’intero equipaggio, si decise di costruire una zattera per caricare chi non avesse trovato posto sulle barche. La zattera doveva essere trascinata a riva, per mettere tutti in salvo: un piano perfetto ma, come due di loro avrebbero in seguito affermato, tracciato sulla sabbia, presto dispersa dal vento dell’egoismo.
La zattera fu costruita, e costruita a regola d’arte; vennero assegnati i posti e preparate le provviste. All’alba, con due metri e settanta centimetri d’acqua nelle stive e le pompe fuori uso, venne lanciato l’ordine di abbandonare la nave. Ma la confusione si sostituí presto al rigore delle intenzioni: l’assegnazione dei posti fu del tutto ignorata e le cibarie maneggiate senza alcun riguardo, dimenticate o persino lasciate cadere in acqua. La zattera doveva accogliere centocinquanta passeggeri: centoventi militari, compresi gli ufficiali, ventinove marinai e passeggeri maschi, una sola donna. Tuttavia, non appena una cinquantina scarsa di uomini vi salí – era lunga venti metri e larga sette –, la zattera sprofondò sott’acqua per almeno settanta centimetri. Si alleggerirono dei barili di farina precedentemente imbarcati e l’imbarcazione di fortuna tornò a galla; poi i restanti passeggeri presero posto e l’imbarcazione affondò un’altra volta. Quando fu al completo, si ritrovò un metro sotto la superficie e cosí affollata che nessuno riusciva a muovere un passo; alle due estremità i passeggeri erano immersi fino alla vita. La furia delle onde scagliò loro addosso i barili natanti di farina e una sacca di biscotti da venticinque libbre si rovesciò, trasformandosi subito, a contatto con l’acqua, in un impasto colloso.
L’accordo era che un ufficiale di marina avrebbe preso il comando, ma questi si rifiutò di salire sulla zattera. Alle sette del mattino venne dato il segnale di partenza e la piccola flottiglia si allontanò dalla nave abbandonata. Diciassette persone avevano disobbedito all’ordine oppure si erano nascoste ed erano rimaste a bordo in attesa di scoprire il proprio destino.
La zattera fu trainata da quattro barche allineate a poppa, precedute da una scialuppa che scandagliava il fondale. Non appena le barche assunsero la giusta posizione, gli uomini cominciarono a urlare Vive le roi! e una piccola bandiera bianca venne issata sulla canna di un moschetto. Ma fu in quel preciso istante di massima speranza e aspettativa che il vento dell’egoismo andò ad aggiungersi ai consueti venti marini. Non si sa bene se per interessi personali, incompetenza, cattiva sorte o apparente necessità, sta di fatto che i cavi di traino furono sganciati a uno a uno.
La zattera si trovava a sole due leghe di distanza dalla fregata quando fu abbandonata al suo destino. Chi si era imbarcato poteva contare su vino, un po’ di brandy, poca acqua e una porzione ridotta di biscotti inzuppati. Niente bussole, né mappe. Sprovvisti di remi e di timone, non vi era modo di controllare la zattera e men che meno gli uomini, sballottati l’uno contro l’altro dalle acque. Durante la prima notte scoppiò un temporale che si abbatté su di loro con grande violenza; le urla degli uomini a bordo si mescolavano ai ruggiti dei marosi. Qualcuno legò delle funi ai tronchi dell’imbarcazione e vi si aggrappò forte, ma tutti venivano colpiti senza pietà. All’alba l’aria riecheggiava di grida laceranti, voti che mai avrebbero potuto essere mantenuti venivano offerti al Cielo e tutti si preparavano a una morte imminente. Era impossibile farsi un’idea adeguata alla realtà di quella prima notte.
Il giorno successivo le acque erano calme e in molti si riaccese la speranza. Ciononostante, due ragazzi e un fornaio, convinti dell’impossibilità di sfuggire alla morte, dissero addio ai loro compagni e scelsero la via del mare. Man mano che le ore trascorrevano i passeggeri della zattera cominciarono ad avere le prime allucinazioni: qualcuno si illudeva di aver scorto la terraferma, altri avvistavano vascelli venuti per trarli in salvo e, quando le speranze ingannevoli si infrangevano contro gli scogli, lo sconforto aumentava.
La seconda notte fu piú tremenda della prima. Il mare era terribilmente agitato e la zattera rischiava ogni minuto di capovolgersi. Radunati intorno all’albero, gli ufficiali ordinarono alla truppa di spostarsi sul fianco opposto, cosí da respingere la forza delle onde. Alcuni, certi ormai di essere perduti, sfondarono un barilotto di vino, decisi a mitigare quegli ultimi istanti rinunciando al potere della ragione. E in effetti vi riuscirono eccome, finché l’acqua di mare, infiltrandosi attraverso il foro che avevano praticato, guastò la bevanda. Doppiamente furibondi e del tutto frastornati, gli uomini erano decisi a mandare tutto in rovina e con questo obiettivo si accanirono contro le funi che tenevano insieme la zattera. Ma gli ammutinati trovarono resistenza e una feroce battaglia fu combattuta tra i marosi nell’oscurità della notte. L’ordine venne infine ristabilito e su quella pedana maledetta trascorse un’ora di tranquillità. Ma a mezzanotte la truppa insorse un’altra volta, attaccando i superiori con pugnali e sciabole; chi era disarmato era sconvolto al punto da aggredire gli ufficiali con i denti e molti dovettero difendersi dai morsi. Alcuni uomini furono gettati in mare, presi a randellate o trafitti dai pugnali. Due barili di vino furono scagliati fuoribordo insieme alle ultime riserve d’acqua. Quando gli infami vennero infine sopraffatti, la zattera era carica di cadaveri.
Durante la prima insurrezione un operaio di nome Dominique, che si era unito agli ammutinati, fu scaraventato in mare. Nell’udire le urla di quel sottoposto traditore l’ingegnere responsabile si gettò subito in acqua e, afferrato il vigliacco per i capelli, riuscí a metterlo in salvo. Per un colpo di sciabola Dominique aveva una ferita aperta alla testa che gli venne fasciata nell’oscurità, restituendolo alla vita. Lungi dal provare gratitudine, appena si riprese il delinquente tornò a unirsi agli ammutinati e di nuovo insorse con loro. Questa volta il destino fu meno clemente e misericordioso: spirò la notte stessa.
Era il delirio, adesso, a minacciare i meschini sopravvissuti. Qualcuno si buttò in acqua, altri si abbandonarono al torpore, qualche povero sciagurato si scagliò contro i compagni impugnando la sciabola sguainata e pretendendo un’ala di pollo. L’ingegnere al cui coraggio si doveva il soccorso dell’operaio Dominique si immaginava sulle belle pianure italiane, mentre uno degli ufficiali si rivolse a lui dicendogli: «Ricordo che le navi ci hanno abbandonato, ma non abbiate paura: ho appena scritto al governatore e fra qualche ora saremo in salvo». L’ingegnere, calmo nel suo delirio, gli rispose: «E lo avete un piccione che possa trasportare gli ordini tanto rapidamente?»
Era rimasto un solo barile di vino per i sessanta passeggeri ancora sulla zattera. Si raccolsero le piastrine dei soldati per ricavarne ami da pesca; poi si prese una baionetta e la si trasformò in un attrezzo per catturare gli squali. Ma, quando un pesce abboccò, con uno strappo violento delle fauci riuscí a raddrizzare la baionetta e a riprendere il largo.
Per prolungare quella miserabile esistenza dovettero ricorrere a una risorsa estrema. Alcuni dei sopravvissuti alla notte dell’ammutinamento si gettarono sui cadaveri, li fecero a pezzi e ne divorarono le carni all’istante. Gran parte degli ufficiali si rifiutò di cibarsene, benché uno propose di essiccarla per renderla piú appetibile. Alcuni addentarono i foderi delle sciabole, le fiaschette delle cartucce, il cinghietto di cuoio del cappello, ma con scarsissimi risultati. Un marinaio si risolse a mangiare i propri escrementi, ma alla fine non ci riuscí.
Il terzo giorno ci fu bel tempo e tornò la calma. Dormirono a lungo, ma la crudeltà degli incubi si aggiunse agli orrori inflitti dalla fame e dalla sete. La zattera, che ora trasportava meno della metà del carico umano presente alla partenza, era riemersa dall’acqua, un vantaggio imprevisto dell’ammutinamento notturno. Gli uomini a bordo, tuttavia, avevano l’acqua alle ginocchia e potevano riposarsi solo rimanendo in piedi, premuti gli uni agli altri in una massa compatta. La mattina del quarto giorno presero atto che una decina di compagni erano morti nottetempo; i corpi furono gettati in mare, tranne uno che venne conservato come risorsa per ovviare alla fame. Alle quattro di quel pomeriggio un branco di pesci volanti sorvolò la zattera, e molti rimasero intrappolati ai bordi dell’imbarcazione. Quella sera prepararono il pesce, ma la fame era insaziabile e le porzioni cosí modeste che alcuni vi aggiunsero della carne umana: camuffata, pareva meno ripugnante, al punto che persino gli ufficiali cominciarono a cibarsene.
Da quel giorno tutti impararono a consumare carne umana. La notte successiva avrebbe assicurato nuovi rifornimenti. Un gruppo di spagnoli, italiani e negri che durante i primi ammutinamenti erano rimasti neutrali tramò un complotto con l’intento di gettare in mare i superiori e raggiungere a nuoto la costa che immaginavano vicina. Con sé avrebbero portato i preziosi e gli oggetti di valore contenuti in una sacca appesa all’albero. Si scatenò l’ennesima rissa e ancora una volta venne sparso del sangue su quella zattera maledetta. Quando questo terzo ammutinamento fu infine sedato a bordo erano rimasti non piú di trenta uomini e la zattera era di nuovo affiorata in superficie. Non c’era nessuno che giacesse a terra senza una qualche ferita e l’acqua salata, bagnandole senza sosta, scatenava grida strazianti.
Il settimo giorno due soldati si nascosero dietro l’ultimo barile di vino, vi praticarono un foro e cominciarono a succhiare da un fuscello di paglia. Quando furono scoperti i due trasgressori vennero sbattuti in acqua all’istante secondo la legge promulgata per necessità.
Fu a quel punto che si dovette prendere la decisione piú terribile. Si ricontarono: erano rimasti in ventisette. Di questi, quindici avrebbero resistito per qualche giorno ancora; quanto agli altri, tra i quali alcuni feriti gravi e in preda a violenti deliri, era evidente che le probabilità di sopravvivenza erano minime. Inoltre, nel lasso di tempo che li separava dalla morte, le loro già esigue provviste si sarebbero ulteriormente ridotte. Calcolarono che fra tutti avrebbero potuto bere dalle trenta alle quaranta bottiglie di vino. Dimezzare le dosi agli ammalati significava ucciderli per gradi. Pertanto, dopo un lungo dibattito a cui presiedette il piú cupo sgomento, le quindici persone sane giunsero alla conclusione che, per il bene di coloro che ancora potevano sopravvivere, era inevitabile che i feriti venissero gettati in mare. Tre marinai e un soldato, con il cuore ormai indurito dalla costante visione della morte, adempirono quelle esecuzioni tanto ripugnanti quanto indispensabili: i sani furono separati dai malati, come i mondi dagli immondi.
A seguito di quel crudele sacrificio gli ultimi quindici sopravvissuti gettarono in mare tutte le armi a esclusione di una sciabola, caso mai si fosse reso necessario tagliare una fune o un pezzo di legno. Per altri sei giorni avrebbero avuto di che vivere in attesa della morte.
Poi, all’improvviso, ci fu un episodio che ciascuno interpretò secondo la propria natura: una farfalla bianca, di una specie comune in Francia, fece la sua comparsa, svolazzò sulle loro teste e si posò infine sulla vela. A qualcuno, impazzito dalla fame, venne in mente che persino di una farfalla avrebbe fatto un ottimo boccone. Ad altri la disinvoltura con cui si aggirava su quei corpi esausti e ormai quasi immobili parve una vera sfrontatezza. Per altri ancora la farfalla apparve come un segno divino, un messaggero bianco come la bianca colomba di Noè. Ma persino i piú scettici, che si rifiutarono di riconoscere in quell’insetto uno strumento del Cielo, sapevano che le farfalle non possono allontanarsi molto dalla terraferma e pertanto furono animati da una debole speranza.
Ma la terra non apparve. Sotto il sole cocente i naufraghi erano consumati dall’arsura e a un certo punto cominciarono a umettarsi le labbra con la loro stessa urina. La portavano alla bocca in gavette che immergevano nell’acqua affinché il liquido si raffreddasse piú rapidamente. Talvolta accadeva che una gavetta venisse sottratta da qualcuno e restituita vuota. C’era un uomo che non riusciva proprio a berla nonostante stesse morendo di sete, mentre un altro, un chirurgo, osservò che l’urina di alcuni aveva un sapore migliore di quella di altri, e aggiunse che l’effetto immediato del bere urina consisteva nello stimolo a produrne dell’altra.
Un ufficiale dell’esercito scovò un limone che aveva intenzione di tenere tutto per sé, ma il coro violento delle richieste lo persuase dei pericoli dell’egoismo. In seguito furono rinvenuti trenta spicchi d’aglio, ragione per cui scoppiò un’altra disputa e se, con l’eccezione di una singola sciabola, non si fossero disfatti delle armi, probabilmente avrebbero sparso altro sangue. C’erano due boccette di liquido alcolico per la pulizia dei denti: un paio di gocce, dispensate con parsimonia dal possessore, produceva una piacevole sensazione sulla lingua che, per pochi secondi, riusciva a mitigare la sete. Anche alcuni piccoli oggetti in peltro, se tenuti in bocca, offrivano un’illusione di frescura. Un’ampolla vuota, che un tempo conteneva un’essenza di rose, passò di mano in mano tra i sopravvissuti che l’inalarono: il profumo persistente procurava un senso di sollievo.
Il decimo giorno, dopo aver ricevuto la razione quotidiana di vino, alcuni uomini concepirono un piano per ubriacarsi e farla finita; a nulla valsero i tentativi di dissuasione del resto dell’equipaggio. La zattera era ormai circondata dagli squali e alcuni soldati, nella loro confusione mentale, decisero di immergersi in acqua in piena vista e nella traiettoria di quei pesci colossali. Otto uomini, convinti che la terra non potesse essere distante, costruirono una seconda zattera sulla quale immaginarono di poter fuggire. La realizzarono lunga e stretta, la dotarono di un albero basso, mentre da un’amaca ricavarono la vela. Tuttavia, messa alla prova, la struttura si rivelò subito fragilissima e l’impresa incosciente, tanto da essere abbandonata.
Il tredicesimo giorno della loro odissea il sole sorse in un cielo terso e senza nuvole. I quindici sciagurati avevano offerto le loro lodi all’Onnipotente e distribuito a ciascuno la propria razione di vino, quando un capitano di fanteria, scrutando l’orizzonte, avvistò una nave ed emise un grido per annunciarlo. Tutti intonarono un canto di ringraziamento a Dio, lasciandosi trasportare dalla gioia. Radd...