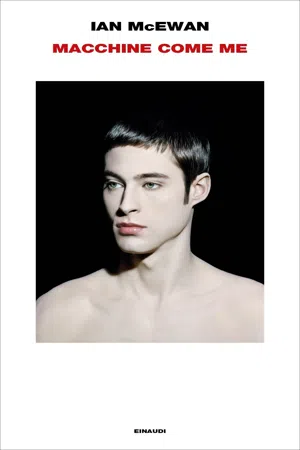Il giorno prima della gita prevista a Salisbury raggiunsi a piedi l’ambulatorio del medico di zona per farmi togliere il gesso. Mi portai di nuovo da leggere la rivista che conteneva il profilo biografico di Maxfield Blacke. Lo si definiva un uomo «dalla mente un tempo poliedrica». Poteva vantare svariati successi, ma nessun autentico «risultato». Fra i trenta e i quarant’anni aveva scritto una cinquantina di racconti, tre dei quali erano confluiti nella sceneggiatura di un celebre film. Nello stesso periodo aveva fondato e diretto una rivista letteraria che, pur essendo sopravvissuta a fatica per otto anni, era attualmente nominata con riguardo da qualsiasi scrittore all’epoca attivo. Scrisse un romanzo perlopiú ignorato nel mondo anglofono, ma che ebbe successo nei paesi nordici. Diresse le pagine culturali di un supplemento domenicale per cinque anni. Anche in questo caso, i collaboratori lo ricordavano con rispetto. Si dedicò per anni alla traduzione della Comédie humaine di Balzac, pubblicata in cofanetto, senza suscitare reazioni di sorta. Fu poi la volta di un dramma in versi, cinque atti in omaggio all’Andromaca di Racine – una scelta poco felice, in quel momento. Compose due sinfonie nello stile di Gershwin con un impianto tonale ben definito, proprio quando la tonalità era caduta in disgrazia.
Di se stesso Maxfield Blacke diceva di avere sparpagliato le energie in cosí tante direzioni da avere ormai una reputazione di «spessore monocellulare». Per assottigliarla ulteriormente, consacrò tre anni alla complessa stesura di un canzoniere di sonetti sulle esperienze del padre durante la Grande Guerra. Era un pianista jazz «non male». La sua guida per rocciatori al massiccio del Giura ebbe buona accoglienza, ma le cartine erano scadenti, non per colpa sua, perciò risultò presto superata. Viveva costantemente sull’orlo dei debiti, a volte con l’acqua alla gola, anche se solo per brevi periodi. La sua rubrica settimanale sui vini probabilmente lo avviò a una carriera di invalido. Quando il corpo di Maxfield entrò in guerra con se stesso, il primo male a manifestarsi fu la Pti, Porpora trombocitopenica idiopatica. Era un abile conversatore, a detta di tutti. Finché non gli comparvero delle chiazze nere sulla lingua. Nonostante la malattia, con l’aiuto di alcuni giovani colleghi scalò la vetta del Ben Nevis dal versante nord: impresa ragguardevole per un uomo di quasi sessant’anni, che per giunta ne scrisse in seguito in modo eccellente. Purtroppo, l’etichetta che lo definiva «un quasi uomo» pareva destinata a resistere.
L’infermiere mi fece entrare e mi tagliò il gesso con un paio di cesoie mediche. Privato di quel peso, il mio braccio pallido e mingherlino levitò in aria come se fosse gonfio di elio. Camminando su Clapham Road, lo flettevo e agitavo festeggiando la sua recuperata libertà. Si fermò un taxi. Per educazione lo presi, rassegnandomi a un costoso passaggio per i trecento metri che mi separavano da casa.
Quella sera chiesi a Miranda se suo padre sapeva di Adam. Disse che sí, gliel’aveva detto, ma lui non sembrava molto interessato. Allora come mai ci teneva tanto a portare anche Adam a Salisbury? Perché voleva vedere come se la sarebbero cavata quei due, mi spiegò sdraiata a letto accanto a me. A suo parere, il padre aveva bisogno di un incontro ravvicinato con il ventesimo secolo.
Un alpinista che aveva letto mille volte piú libri di me, un uomo che non «sopportava facilmente gli stolti»: con la mia scarsa cultura letteraria avrei dovuto sentirmi intimorito e invece, adesso che la decisione era presa, non vedevo l’ora di stringergli la mano. Mi sentivo immune. Sua figlia e io ci amavamo, perciò Maxfield doveva accettarmi com’ero. Senza contare che il pranzo nella casa dove Miranda era stata bambina, un posto che desideravo molto scoprire, non era che l’innocuo preludio alla visita a Gorringe, e quella sí che mi spaventava, nonostante le indagini svolte da Adam.
Uscimmo di casa dopo colazione, un ventosissimo mercoledí mattina. La mia macchina era una due porte. Mi colpí l’inettitudine di Adam che cercava di infilarsi nel sedile posteriore. Il bavero della giacca gli si impigliò in una delle placche metalliche che ospitano la bobina della cintura di sicurezza. Quando lo liberai, sembrava convinto di aver pregiudicato la propria dignità. Fu scorbutico durante il lungo tragitto a passo d’uomo per uscire da Wandsworth: il classico figlio adolescente di pessimo umore seduto dietro in macchina durante una gita di famiglia. Date le circostanze, Miranda si mantenne allegra mentre mi ragguagliava sul padre: l’andirivieni dall’ospedale per ulteriori analisi; il susseguirsi di infermieri a domicilio, sostituiti uno dopo l’altro per volere di lui; il ripresentarsi della gotta al pollice destro ma non al sinistro; il rimpianto di non avere abbastanza energia per scrivere tutto quello che avrebbe voluto; l’entusiasmo per il romanzo breve che stava per concludere. Peccato non aver scoperto molto prima quella forma letteraria. L’idea dell’appartamento a New York era finita nel dimenticatoio. Aveva in mente una trilogia, dopo questo libro. Ai piedi di Miranda c’era la borsa di tela del nostro pranzo: Maxfield l’aveva avvertita che la nuova domestica era una pessima cuoca. A ogni sobbalzo, tintinnavano parecchie bottiglie.
Ci mettemmo un’ora per cominciare a uscire dal campo gravitazionale di Londra. Dovevo essere il solo guidatore al volante della propria auto. In quello che un tempo era stato il posto di guida viaggiavano individui perlopiú addormentati. Appena conclusa l’operazione finanziaria per la casa di Notting Hill, intendevo comprarmi un potente veicolo autonomo. Nei viaggi lunghi, Miranda e io avremmo bevuto vino, guardato film e fatto l’amore sui sedili posteriori reclinabili. Mentre le illustravo allusivamente il mio piano, costeggiavamo le linee di bosco autunnali dell’Hampshire. C’era qualcosa di pressoché innaturale nelle dimensioni degli alberi che incombevano sulla strada. Avevamo deciso di fare una deviazione passando per Stonehenge, anche se speravo che la cosa non inducesse Adam a tenerci una lezione sulle origini del sito. Per fortuna non era in vena. Quando Miranda gli chiese se era triste, bofonchiò: – Tutto a posto, grazie –. In macchina calò il silenzio. Cominciavo a domandarmi se fosse pronto a cambiare idea riguardo alla visita a Gorringe. Personalmente non avrei avuto nulla in contrario. Se ci andavamo comunque, magari con quell’umore alterato Adam non sarebbe stato abbastanza disposto a difenderci. Gli lanciai un’occhiata nello specchietto retrovisore. Teneva la testa voltata alla sua sinistra per guardare la campagna e le nuvole. Mi sembrò di notare un movimento sulle sue labbra, ma non ero sicuro. Quando tornai a guardarlo, le aveva immobili.
Mi impensierí addirittura superare Stonehenge senza un commento da parte sua. Rimase in silenzio anche dopo la piana di Salisbury e quando cogliemmo il primo scorcio di guglia della cattedrale. Io e Miranda ci scambiammo uno sguardo. Ma poi ci scordammo di lui per una ventina di minuti, innervositi dal tentativo di rintracciare casa sua nel dedalo di sensi unici. Salisbury era la sua città e Miranda non voleva saperne di affidarsi al satellitare. Solo che la sua mappa mentale era quella di un pedone, perciò mi dava indicazioni tutte sbagliate. Dopo alcune faticose inversioni a U tra veicoli poco concilianti, una retromarcia in una via a senso unico e una lite evitata per un soffio, parcheggiammo a circa duecento metri dalla destinazione. La flessione subita dal nostro umore sembrava aver fatto bene a quello di Adam. Appena scesi sul marciapiede, volle a tutti i costi prendermi di mano la pesante borsa di tela. Eravamo vicini alla cattedrale, non proprio all’interno delle mura, ma la casa mi parve abbastanza austera da poter essere stata il compenso accessorio di qualche illustre ecclesiastico.
Adam fu il primo a pronunciare un saluto squillante quando la domestica aprí la porta. Una donna sui quarant’anni di aspetto gradevole e dall’aria in gamba; difficile credere che non sapesse cucinare. Ci condusse in cucina. Adam sollevò la borsa e la depose sul tavolo in legno chiaro, poi si guardò attorno, batté le mani e disse: – Beh, ma è fantastico –. Si trattava di un’imitazione poco credibile del tipo disinvolto, il rompicoglioni da circolo del golf. La domestica ci accompagnò al primo piano nello studio di Maxfield. Una stanza spaziosa come tutte quelle di Elgin Crescent. Librerie a soffitto su tre lati, scaletta a tre gradini per gli scaffali piú alti, tre finestre verticali a ghigliottina affacciate sulla strada, scrivania con ripiano in pelle esattamente al centro della sala, con due lampade da lettura, e dietro la scrivania, una sedia ergonomica piena di cuscini in mezzo ai quali sedeva eretto Maxfield Blacke, stilografica in mano, e mandibola talmente serrata da far pensare che potesse spaccarsi i denti. Al nostro ingresso ci aveva lanciato un’occhiata carica di irritazione, prima di riuscire a rilassare i tratti del viso.
– Sono a metà di un capoverso. Mi sembra buono. Perché non vi levate dalle palle per un’altra mezz’ora.
Miranda intanto attraversava la stanza. – Non darti tante arie, papà. Siamo reduci da tre ore di viaggio.
Le sue ultime parole risultarono attutite dall’abbraccio, che durò parecchio. Maxfield aveva messo giú la penna e bisbigliava qualcosa all’orecchio della figlia. Lei si appoggiava su un ginocchio solo e gli cingeva il collo con le braccia. La domestica intanto era sparita. Metteva a disagio starsene a guardare, perciò diressi gli occhi sulla penna. Era adagiata lí, senza cappuccio, accanto a tanti fogli di carta non rigata sparsi sulla scrivania e coperti di una grafia minuta. Da dove mi trovavo, riuscivo a vedere che non c’erano cancellature, né frecce, sottolineature o aggiunte lungo i margini perfettamente rispettati. Ebbi anche il tempo di notare che, a parte le due lampade da scrivania, non c’era nessun altro apparecchio nella stanza, nemmeno un telefono, nemmeno una macchina da scrivere. Forse, solo i titoli dei libri e la sedia dell’autore confermavano che non poteva essere il 1890. Una data che non pareva poi cosí lontana.
Miranda fece le presentazioni. Adam, ancora tutto affabile, fu il primo. Poi venne il mio turno di farmi avanti e stringergli la mano. Senza un sorriso, Maxfield disse: – Miranda mi ha parlato tanto di te. Avevo una gran voglia di fare due chiacchiere.
Risposi cortesemente che anch’io avevo sentito molto parlare di lui e che anch’io avevo voglia di chiacchierare. Lui intanto faceva una faccia. Dovevo apparirgli come l’incarnazione di qualche previsione negativa. Lui sembrava molto piú vecchio rispetto alla foto del profilo, pubblicato cinque anni prima. Il viso era affilato, la pelle tesa, come stanca di troppi sguardi furiosi, troppe espressioni ringhianti. Miranda mi aveva detto che nella generazione di suo padre andava di moda un certo scetticismo iracondo. Bisognava tollerarlo, mi disse, perché sotto sotto nascondeva dell’allegria. Quel che volevano, disse, era che l’interlocutore rilanciasse dimostrandosi all’altezza. Ora, mentre Maxfield mi lasciava andare la mano, sentii che forse avrei potuto rilanciare. Quanto a mostrarmi all’altezza… aiuto.
La domestica, Christine, si presentò con un vassoio di sherry. Adam disse: – Per il momento, no, grazie –. Aiutò Christine a prendere tre seggiole dagli angoli della stanza e a sistemarle in un ampio semicerchio di fronte alla scrivania.
Quando ciascuno ebbe in mano il suo bicchiere, Maxfield disse a Miranda, indicandomi: – A lui piace lo sherry?
Lei si girò a guardarmi e io risposi: – Abbastanza, grazie.
In realtà, lo detesto e mi chiesi se dirglielo avrebbe fatto di me un interlocutore all’altezza, nel senso inteso da Miranda. Lei cominciò a rivolgere al padre una serie di domande di routine sui suoi svariati malanni, le terapie, il cibo dell’ospedale, uno specialista troppo evasivo, una nuova pillola per l’insonnia. Era incantevole ascoltarla: la dolcissima figlia devota. La sua voce era pacata, affettuosa. Allungò una mano per scostargli una ciocca di capelli fini che gli era scesa sulla fronte. Maxfield le rispondeva come uno scolaretto diligente. Se una delle sue domande gli suscitava il ricordo di qualche insoddisfazione o incompetenza da parte dei medici, e Maxfield si spazientiva, lei lo tranquillizzava accarezzandogli il braccio. Quel catechismo da invalidi placò anche me, ingigantendo il mio amore per Miranda. Il viaggio in macchina era stato lungo; lo sherry dolce e liquoroso fu un conforto. Alla fine forse mi piaceva. Mi si chiusero gli occhi e dovetti fare uno sforzo per riaprirli. Giusto in tempo per sentire la domanda di Maxfield Blacke. Aveva abbandonato i modi da lamentoso ipocondriaco, ades...