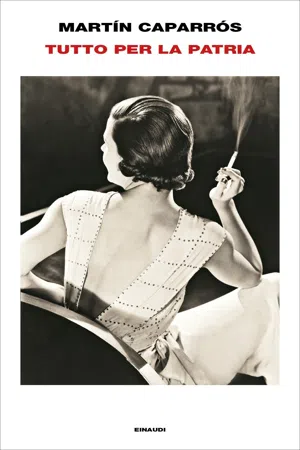È sempre strano salire su un treno: rinchiudersi in un vagone che ti sposta a cinquanta, sessanta chilometri all’ora, lanciato come un proiettile su pezzi di metallo consumato. Lo so che non devo essere codardo: che vivo nell’era della velocità e che va bene, ogni tanto, provare quella strana sensazione che tutto passa troppo in fretta. E so che il Ferrocarril Pacífico è gestito dagli inglesi e che gli inglesi le cose le fanno bene – ma a tratti, quando lo sferragliamento si fa piú intenso, non riesco a non tenermi stretto al bracciolo, come se questo potesse cambiare qualcosa.
E a maggior ragione oggi, in mezzo a questa follia. Mi viene in mente una parola quasi stupida: la parola avventura. Per quanto provi a non darle importanza, la cosa è strana e affascinante: sono su un treno lanciato a tutta birra verso un paesello di campagna per andare a parlare con il tizio piú famoso del paese. Quindi meglio stare calmi: guarda il paesaggio, Rivarola, goditi il paesaggio, tu che sei un animale di città, gustati la gita; magari ti suggerisce qualcosa, Rivarola, un paio di frasi. Cerca di darmi retta, Rivarola: vedo quella sterminata distesa incolta che chiamano pampa, vacche, vacche e ancora vacche, quell’odore di carne morta che ritorna. Ma ho dormito molto poco – due o tre ore quando sono passato dalla pensione per prendere una camicia pulita e, con mia grande sorpresa, l’ho anche trovata – e la paura della velocità si fa meno forte, lo sferragliamento del treno mi culla e solo ogni tanto mi sveglia il fischio quando si ferma in qualche stazione. Allora salgono e scendono signori e signore con le valigie di cartone legate con lo spago, pacchi avvolti nella iuta legati con lo spago, qualche borsa. Devono mancare ancora un paio d’ore per arrivare a Junín: il rifugio del fuggitivo Bernabé Ferreyra. Mi infastidisce il ricordo del Gorrión: come posso concludere l’affare proposto da Cuitiño senza tradirlo. O perlomeno senza tradirlo troppo.
– Scommetto che lei non sa da dove deriva la parola cana!
Mi chiede all’improvviso un uomo magro di 35 o 40 anni, seduto accanto a me. L’uomo ha baffi sottili e la madre di tutti gli occhiali stampata in faccia. Scuoto la testa mezzo addormentato:
– Cana?
– Sí, come in ahí viene la cana, o in araca la cana: arrivano gli sbirri, attenti agli sbirri.
– E che ne so.
Gli dico, e mi rimetto a guardare le vacche dal finestrino, ma l’uomo è cocciuto: il suo bisogno di parlare deve essere decisamente maggiore del suo pudore.
– Quel fannullone di Arlt lo spiega nel suo articolo sul «Mundo»: si vede che non ha piú niente con cui riempire le pagine. E dire che prima i giornali li scrivevano i giornalisti…
Un altro che non sa come tenere la bocca chiusa. Ma stavolta sí che non ho via di scampo: è difficile fuggire da qualcuno disposto a tutto, seduto sul lato del corridoio, che ti impedisce la ritirata.
– Dev’essere una sua invenzione, ma è simpatica: dice che c’era un tale commissario Racana che era diventato molto famoso in non so quale quartiere e che era un gran noioso, che non faceva che tormentare i ragazzi che volevano giocare a calcio per strada. I vicini si lamentavano degli schiamazzi, dei vetri rotti, si lamentavano perché volevano lamentarsi, e allora il commissario Racana, per fare bella figura e perché gli piaceva rompere le scatole, li andava a cercare, i ragazzi, gli rovinava le partite, gli sequestrava il pallone, e in certe occasioni li arrestava persino. E allora dice che i ragazzi del quartiere presero l’abitudine di mettere una campana che li avvisasse in modo da aver tempo di scappare e non perdere il pallone, considerato quanto costa un pallone, per cui quando arrivava il commissario urlavano Ahí viene Racana, e da lí l’urlo iniziò a diffondersi in altri quartieri, va’ a sapere perché, e siccome negli altri quartieri non conoscevano il commissario e non la capivano, la frase divenne ahí viene la cana. Ahí viene la cana, ma se ne rende conto?
Sollevo le sopracciglia, provo a fare un sorriso, penso che forse Señorans aveva ragione: che fare il giornalista non è poi cosí difficile. A essere difficile, davvero difficile, è il silenzio. Si vede che l’uomo intuisce qualcosa perché mi spiega:
– Scusi, non volevo disturbarla. Ma ha idea di cosa voglia dire essere chiamato tutto il tempo cana e non sapere perché?
– Quindi lei è un poliziotto.
Gli dico, come chi rispetta un suo dovere civico.
– Be’, no.
– E allora?
– Glielo racconto un’altra volta.
Dice l’uomo, e si perde nel suo giornale. Se fossi rimasto a Buenos Aires avrei potuto provare a vedere Estelita; avrei potuto provare e sicuramente avrei di nuovo fallito. E forse questo viaggio serve per questo: se faccio quello che ha detto Cuitiño e mi dà da lavorare, quella stronza non avrà piú scuse per tenermi alla larga dalla bambina. Anche se, conoscendola, di sicuro si inventerà qualcos’altro.
Già trovare dei fiori in un paese della pampa dei gringo è difficile, figuriamoci di sabato pomeriggio. Gli abitanti del posto non sono per queste frivolezze; se qualcuno ne vuole, li coltiva. Faccio un giro per le strade intorno alla piazza – marciapiedi rotti, canali di fango essiccato, qualche cavallo legato, qualche piccolo furgone – e alla fine mi ritrovo a comprare una dozzina di paste nella Nueva San Martín Panadería Confitería, il panificio-pasticceria tra il Banco Provincia e la chiesa di Sant’Ignazio, aperta anche all’ora della siesta. La grassa panettiera mi conferma che doña Matilde de Ferreyra, la madre di Bernabé, vive in calle Moreno, quattro isolati a sud, ma non le dica che gliel’ho detto io, perché adesso la signora fa la preziosa.
– Il successo le cambia proprio le persone… O saranno i soldini?
Preferisco non star troppo a parlarne. Le pago un peso, la ringrazio, esco tenendo ben stretto il mio pacchetto. Fa un caldo da cani e i cani dormono all’ombra e il sombrero sembra un forno da panettiere. Riorganizzo le idee; per qualche ragione che mi sfugge, ho sempre pensato che, se lo voglio, posso andare a genio alle persone. Ci credo ma non ne devo essere cosí sicuro perché adesso, mentre cammino con il mio pacchettino, risento piú volte la cantilena in testa: io posso andare a genio a qualcuno.
– Io posso andare a genio a qualcuno.
Cammino, sudo, sveglio i latrati dei cani addormentati, trovo l’indirizzo, batto le mani. La casetta è bassa, ben curata, mattoni imbiancati a calce, in fondo a un terreno; davanti ci sono erbacce e un’ortensia viola e qualche piantina di pomodoro.
– Doña Matilde! Doña Matilde!
Una vecchia di sessanta e rotti anni compare alla porta. Si sta allacciando una vestaglia di colore indefinito e sistemando i capelli bianchi come i mattoni.
– Chi la cerca?
– Io, doña Matilde, Andrés, il nipote di doña María. Non le ha detto che sarei venuto a trovarla?
La signora si sfrega il volto con le mani, come chi cerca di ricordare o ricordarsi. Non dice niente: mi guarda con gli occhi cisposi, la bocca aperta.
– Be’, non si preoccupi, di sicuro gliel’ha detto. Le ho portato qualche pasta per il mate…
– Silenzio, signore, che mi sveglia Bernabé.
– Non preoccuparti, figliolo, è Andrés, il nipote di doña María.
– Di quale doña María?
– Doña María, Berna, non fare cosí.
È il momento: lascio il mate sulla tovaglia di tela cerata, insieme al resto delle paste, e mi alzo dalla sedia e m’incammino verso la porta dove se ne sta fermo Bernabé Ferreyra, con i pantaloncini da calciatore, larghi, neri, logori, le ciabatte di pelle: il torace potente, il collo ampio, le gambe ad arco, molto ricurve. Gli tendo la mano; Ferreyra me la guarda come se fossi uno strano animale, ma alla fine mi porge la sua. Poi gliela rendo.
– E che cazzo ci fai qui?
– Niente, maestro, sono passato a trovare sua madre. E, se mi concede l’onore, vorrei parlare un attimo con lei.
– Non sarai per caso un giornalista?
– Io giornalista? Le sembra che abbia la faccia da giornalista?
– E che ne so. O adesso pensano anche di averla, una faccia.
Gli sorrido, cerco di rendermi complice:
– La faccia ce l’hanno, maestro, di bronzo. Che Dio ce ne scampi…
Ferreyra mi concede mezzo sorriso – un quarto – e mi chiede di nuovo che cazzo ci faccio lí, nella cucina di casa sua. Io insisto a sorridere e gli dico che lo invito a bere una birra, che almeno ce ne andiamo a prendere un po’ il fresco. Ferreyra mi guarda come se dovesse capirmi, fa un cenno del tipo e va be’ chisseneimporta, mi dice di dargli cinque minuti, il tempo di lavarsi la faccia e infilarsi una camicia.
– E ti conviene non essere un giornalista.
– E se sono qualcosa di peggio?
– Peggio?
Mi dice Ferreyra, e sbuffa. Si vede che non gli viene in mente niente.
Al bar, Rodríguez, il proprietario, don Rodríguez – grasso, basso, con le sopracciglia folte –, saluta Ferreyra con un sacco di smancerie e il suo accento asturiano – tu da queste parti, Bernabé, quanto tempo –, e ci fa accomodare al suo miglior tavolino, tranquillo, un po’ isolato, accanto alla finestra ombreggiata da un platano. È ancora presto; ci sono clienti soltanto ad altri due tavolini: uomini, ovviamente.
– Birra?
– Sí, due boccali. E un po’ di noccioline.
Io preferirei non dover affrontare cosí, subito, di colpo, l’argomento, ma non ne ho nessun altro. Faccio qualche domanda: come si sta in paese, non è un po’ noioso, che a un tipo come lui Junín deve stare un po’ stretta. Ferreyra mi risponde senza dilungarsi, gentile, circospetto: come chi sta aspettando in agguato.
– Guarda, capo, questo è il mio paese. Io non sono come quei coglioni che diventano importanti e si mettono a sputarci sopra.
E subito arrivano le sfumature: è affezionato però si annoia, non ha voglia di stare qui senza far niente.
– Ma tu mi vedi a uscire qui in giro? Non posso andare da nessuna parte. Qui devo rigare dritto, c’è mia madre, la mia famiglia, mi conoscono tutti. Qui tutti mi giudicano.
In breve il calciatore si rilassa: inizia a cedere. Ipotizzo di attaccare ma preferisco continuare a girarci attorno, a fare domande sceme. Adesso mi racconta di quel portierino peruviano che è svenuto per una pallonata e l’hanno portato in ospedale e lui è andato a trovarl...