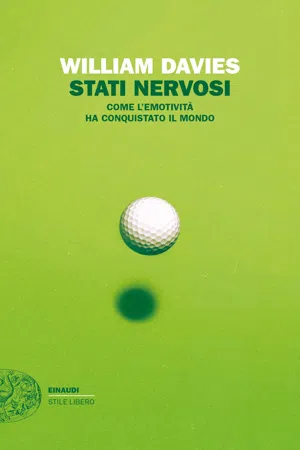La nuova era delle folle.
La presidenza di Donald J. Trump è iniziata con una discordanza su un numero, per la precisione il numero di partecipanti alla cerimonia del suo insediamento. Su quella sera il «New York Times» ha pubblicato una stima secondo la quale l’affluenza di pubblico era pari a un terzo di quella per l’insediamento di Obama nel 2009, che secondo alcuni ammontava a 1 800 000 persone. Questo dato sembrava confermato dalle riprese aeree della folla del 2017, che all’interno del National Mall mostravano zone molto piú ampie di spazi vuoti rispetto al 2009. Tutto ciò ha provocato la prima di molte conferenze stampa straordinarie, in cui l’allora portavoce della Casa Bianca Sean Spicer accusava la stampa di voler «sminuire il sostegno enorme» di cui aveva goduto Trump e affermava che quel pubblico fosse in effetti «il piú ampio che avesse mai partecipato a una cerimonia di insediamento, punto». Nello stesso giorno, a una riunione nel quartier generale della Cia, Trump ha comunicato che i partecipanti corrispondevano a una cifra tra il milione e il milione e mezzo di persone.
Diversi organi di stampa e social media hanno messo Spicer alla berlina, non da ultimo perché la sua conferenza stampa sembrava quella di un propagandista che si atteneva goffamente alle direttive del partito, senza permettere ai giornalisti di fare domande. Di conseguenza la linea della Casa Bianca si è soltanto irrigidita, arrivando a utilizzare nuove e sorprendenti giustificazioni filosofiche.
La consigliera di Trump Kellyanne Conway ha negato con decisione che Spicer avesse mentito, sostenendo invece che avesse semplicemente offerto «fatti alternativi» a quelli ritenuti veri dai giornalisti. Il giorno successivo, durante un’altra conferenza stampa, Spicer ha affermato che «talvolta si può essere in disaccordo con i fatti». Ad appena settantadue ore dal giuramento di Trump, sembrava che la Casa Bianca avesse sospeso i criteri di base della verità.
Questo conflitto con i mezzi di informazione è sembrato rinvigorire Trump, consentendogli di tornare agli stratagemmi morali ed emotivi che si erano rivelati cosí efficaci in campagna elettorale. Trump ha considerato ingiuste, elitarie e persecutorie le dichiarazioni rilasciate dai mezzi di informazione sul numero di partecipanti, evidentemente basate sui fatti. «Mi sminuiscono in modo ingiusto», ha detto a un inviato di Abc News qualche giorno dopo, prima di accompagnarlo a vedere una fotografia del giorno dell’insediamento appesa al muro, che a quanto pare mostrava la folla da una prospettiva piú precisa. «Questo per me è un mare d’amore», ha detto indicando l’immagine. «Sono persone venute qui da ogni parte del paese, forse del mondo; per loro è stato difficile arrivare. E quello che avevo da dire gli è piaciuto». Per Trump non era una semplice discordanza sui «fatti». Si trattava di due emozioni contrapposte: lo scherno arrogante dei suoi critici e l’affetto dei suoi sostenitori. Almeno su questo punto, aveva ragione.
Non ci sono dati ufficiali sul numero dei partecipanti alle cerimonie di insediamento. Il National Park Service non presenta piú stime dopo l’episodio della disputa sui numeri della «Million Man March», che nel 1995 ha portato uomini afroamericani a Washington. In quell’occasione il Park Service aveva stimato 400 000 persone, ma questo dato (per ovvie ragioni) gettava qualche dubbio sul successo dell’iniziativa. Vista la scottante valenza politica acquistata da questioni del genere, il Park Service ha smesso di fornire ulteriori stime.
I numeri delle folle producono valutazioni violentemente diversificate anche al di là della politica: per le persone che nel 2011 hanno seguito il royal wedding di William e Kate a Londra, le cifre variano dai 500 000 a oltre il milione. Le foto scattate dai satelliti e dalle mongolfiere, adattando tecniche originariamente sviluppate per spiare gli armamenti sovietici, hanno sempre costituito la fonte piú autorevole ma presentano diversi difetti. Le immagini satellitari possono essere disturbate dalla presenza di nuvole e la densità delle persone nella folla può risultare distorta dalla quantità di ombra che proiettano i loro corpi e dal colore del terreno sottostante.
Uno degli aspetti fondamentali della folla è che dimensioni e densità appaiono radicalmente diverse in base al punto di osservazione. Senza dubbio, parlando davanti al palazzo del Campidoglio in qualità di neo incaricato presidente degli Stati Uniti, Trump deve aver visto davvero una folla molto fitta che si estendeva in lontananza. Cosí gli era dovuta apparire. Potrebbe anche aver pensato che se solo i giornalisti avessero visto quello che vedeva lui allora sarebbero stati d’accordo. Gli organizzatori di manifestazioni e marce di protesta hanno sempre un particolare interesse a gonfiare il numero dei partecipanti, ma bisogna anche dire che le folle appaiono (o vengono percepite) molto piú ampie da chi ne fa parte rispetto a chi ne è al di fuori. Potrebbe trattarsi di un’illusione ottica, ma non è necessariamente disonestà.
La diffusione dei dispositivi smart nell’ambiente urbano produce ulteriori dati per analizzare i movimenti della folla in vari intervalli di tempo, ma non per questo si arriva a una cifra definitiva. Si può studiare il numero di segnali dei telefoni cellulari in un certo posto a una cert’ora, o dotare le infrastrutture urbane (per esempio i lampioni) di sensori intelligenti, ma il dato che viene catturato resta per sua natura sfuggente. È utile per percepire impennate nell’attività e nel movimento, che è il motivo principale per cui questi interventi da «smart city» vengono progettati, ma una folla resta di per sé un’entità difficile da afferrare oggettivamente.
Per quanto le affermazioni di Trump, Spicer e Conway possano essere sembrate assurde, c’è qualcosa di rivelatore nell’argomento particolare che ha causato questo scontro sull’insediamento: una questione di grande importanza emotiva, nella quale però gli esperti sono relativamente impossibilitati a trovare un accordo. Non solo le folle sfuggono a tecniche scientifiche di osservazione e misurazione, ma sono anche in tanti – organizzatori di grandi manifestazioni, relatori e partecipanti – a non volerle definire in quel senso. Un punto di vista neutro, oggettivo, è difficile da trovare cosí come da difendere.
I raduni pubblici sono vecchi quanto la politica. Tuttavia a partire dalla crisi economica del 2007-2009 hanno trovato una nuova motivazione, soprattutto a sinistra. Il movimento Occupy, nato nel 2011 per protestare contro le banche, ha fatto delle manifestazioni pubbliche il suo scopo politico fondamentale e si è appropriato del freddo linguaggio della statistica rendendolo un fattore di protesta, con il famoso slogan «siamo il 99 per cento». Leader di sinistra come Alexīs Tsipras in Grecia, Pablo Iglesias in Spagna e Jeremy Corbyn nel Regno Unito hanno posto un’enfasi politica rinnovata sulla capacità di portare in piazza grandi numeri di persone. Anche in questo caso la dimensione delle manifestazioni provoca emozioni diversificate sia da parte dei sostenitori sia degli oppositori: entusiasmo, sdegno, empatia, disinformazione, speranza e risentimento. I sostenitori di Corbyn hanno spesso lamentato il fatto che le loro iniziative non godano di adeguata copertura da parte dei mezzi di informazione tradizionali, nonostante la partecipazione evidentemente ampia.
Ma di nuovo, quale parametro si dovrebbe utilizzare per valutare l’importanza di una folla? Quanto deve essere grande una manifestazione per diventare una notizia interessante? E che cosa si può definire una prova? La circolazione di fotografie su Twitter, che affermano di mostrare un corteo ma in effetti ne ritraggono un altro (di solito molto piú numeroso), contribuisce ad addensare la nebbia che avvolge la politica delle folle. Questo favorisce lo scherno di chi ritiene eventi del genere irrilevanti dal punto di vista politico, evidenziando il contrasto tra il successo in piazza e quello nell’urna. D’altro canto, l’analisi del risultato inaspettatamente positivo per Corbyn alle politiche del 2017 ha dimostrato che le sue manifestazioni hanno avuto un effetto positivo sul comportamento elettorale, vicino ai luoghi in cui si sono svolte1. Ma chi potrebbe dire esattamente come o perché?
La sensazione di trovarci in una nuova epoca delle folle è rafforzata dalla diffusione e dalla crescente influenza dei social media. Sin dal XVIII secolo, quotidiani ed editori hanno rappresentato una forma di comunicazione «da uno a molti», fornendo informazioni a un pubblico e a lettori specifici. In questo rapporto, i destinatari erano ampiamente passivi e di conseguenza in qualche modo prevedibili. Dall’inizio degli anni Duemila, i social media hanno integrato (e per certi aspetti cooptato) questo sistema con uno stile di comunicazione «da molti a molti», in cui le informazioni si trasmettono come un virus attraverso una rete in modi decisamente piú irregolari. Certe idee o immagini sembrano diffondersi di propria iniziativa, prendendo di sorpresa gli esperti e innescando straordinari ribaltamenti elettorali. Nuove tecniche di vendita e di messaggistica sono state sviluppate per cercare di influenzare i processi virali e mimetici della condivisione di contenuti. Le folle sono un aspetto fondamentale della politica sin dall’antichità, ma prima del XXI secolo non avevano mai disposto di strumenti di coordinamento in tempo reale.
In superficie, il disaccordo sulle dimensioni della folla alla cerimonia di Trump potrebbe sembrare un risibile contrasto tra fatti e finzione, realtà e fantasia. Potrebbe apparire come il tipo di problema che l’autorità degli esperti sarebbe in grado di risolvere facilmente, a patto di trattare gli esperti con sufficiente rispetto. Tuttavia ci fornisce un punto di partenza per capire il nuovo, accidentato terreno politico su cui ci muoviamo, in cui i punti di vista oggettivi vacillano e le emozioni assumono un peso preponderante. L’importanza di una folla dipende largamente da chi la guarda. Che cosa comporta tutto ciò per la politica? E si può comprendere una logica al di sotto di questo nuovo caos?
Una logica c’è, ma per afferrarla dobbiamo prendere sul serio le emozioni. Al tempo stesso, dobbiamo sospendere comodi assunti sulla democrazia rappresentativa. Secondo l’idea diffusa di democrazia di massa, la maggior parte delle persone se ne sta tranquilla a casa lasciando che qualcun altro parli al posto suo: un rappresentante eletto, un giudice, un critico, un esperto o un commentatore di professione. Coinvolge partiti, agenzie, quotidiani e case editrici gestiti da professionisti, che recepiscono in modo sicuro le questioni rilevanti e dove tutti seguono le stesse regole. Perché la democrazia funzioni però, è necessario che per la maggior parte del tempo la grande maggioranza delle persone sia contenta di starsene in silenzio e si fidi di chi parla al posto suo. È questo che, a quanto pare, si è sempre piú restii a fare. Mentre in tutto il mondo la fiducia nei confronti dei politici e dei mezzi di informazione ufficiali è in calo, aumenta il sostegno riconosciuto alla democrazia diretta2. Non c’è ragione di credere che questa tendenza debba invertirsi nel prossimo futuro.
Quando la politica è permeata dalla logica delle folle, si tratta meno di pacifica rappresentanza politica e piú di mobilitazione. Che sia nelle piazze o in rete, le folle non sono delegate da qualcun altro, allo stesso modo in cui un parlamento deve agire delegato dal proprio elettorato o un giudice è il volto del sistema della giustizia. Non si propongono di rappresentare la società nel complesso, come farebbe un «campione rappresentativo» nei sondaggi d’opinione per scoprire che cosa pensa l’intera nazione. L’importanza della folla risiede nell’intensità dell’emozione che ha portato cosí tanta gente nello stesso posto alla stessa ora. Come nel caso delle guerre che dominano l’immaginario dei nazionalisti, le folle consentono ai singoli di diventare (e sentirsi) parte di qualcosa molto piú grande di loro. Questo non è necessariamente negativo ma comporta dei rischi e agisce sui nostri nervi.
La questione politica fondamentale è chi o che cosa abbia il potere di mobilitare le persone. Come hanno scoperto di recente numerose campagne politiche tradizionali sconfitte da contestatori e nuovi arrivati, invocare l’oggettività e l’evidenza raramente smuove la gente in senso fisico o emotivo. Che cos’è dunque che la induce a impegnarsi in modo cosí diretto e che cosa la governa una volta che l’ha fatto? Questa domanda preoccupa pubblicitari, consulenti aziendali ed esperti in pubbliche relazioni, oltre che i politici. Le piattaforme dei social media si contendono il «coinvolgimento» del pubblico, cercando di mantenere il piú a lungo possibile la nostra attenzione con «contenuti» che fungono meramente da esca. Utilizzate come semplici strumenti di mobilitazione e coinvolgimento delle persone, non importa piú se le parole e le immagini rappresentano riflessioni valide o oggettive sulla realtà. È questo tipo di ansia che ora circonda le fake news e la propaganda. Ma è un argomento di cui abbiamo già parlato.
Assembramenti fisici.
Nel 1892, a Parigi, un medico, ricercatore e talvolta antropologo francese di nome Gustave Le Bon fu disarcionato dal suo cavallo e rischiò di morire. Il motivo per cui era accaduto divenne un’ossessione per Le Bon. C’era qualcosa che, studiandolo, si potesse desumere del temperamento di un cavallo? Le Bon iniziò a esaminare fotografie di cavalli in cerca di indizi, nel tentativo di scovare segni della psicologia animale nel loro aspetto fisico. Era fortemente influenzato da Charles Darwin, il cui lavoro sull’espressione delle emozioni degli animali si era ugualmente basato sulla fotografia. La nascita della fotografia aveva dischiuso nuove possibilità scientifiche, permettendo l’analisi oggettiva di facce ed espressioni. Per la prima volta un fuggevole sguardo poteva essere catturato e studiato, aprendo la strada a una piú metodica scienza delle emozioni dove in precedenza c’erano state solo teorie e descrizioni. Lo studio del cavallo condusse Le Bon verso ulteriori questioni psicologiche, indagando come fosse possibile spiegare il comportamento umano in termini di indizi fisici e biologici. L’area della psicologia che gli interessava maggiormente era quella per cui oggi è piú conosciuto: il comportamento della folla.
Le Bon aveva esperienza diretta dell’impatto viscerale e del potenziale di trasformazione delle folle, ed era rimasto profondamente turbato da quello di cui erano capaci. Conclusi gli studi in medicina a Parigi negli anni Sessanta dell’Ottocento, aveva guidato un’unità di ambulanze militari dopo lo scoppio della guerra franco-prussiana nel 1870. L’umiliazione dell’esercito francese, seguita dall’ascesa della Comune socialista di Parigi nell’estate del 1871, contribuí alle inclinazioni politiche profondamente conservatrici di Le Bon, convinto che la Francia fosse stata tradita da uno spirito di pacifismo sanzionato dalle idee socialiste. La fiducia democratica e socialista nel «popolo» portava con sé una negazione della forza militare e dell’orgoglio nazionale che egli riteneva andasse respinta con forza. Ispirato dalle nuove teorie evoluzioniste, Le Bon coniugò la sua antipatia per il socialismo a certe idee profondamente razziste e sessiste riguardo le minacce alla cultura nazionale e al valore militare, riconducendole a volte a una teoria in voga in quel periodo: la craniologia. Trascorse buona parte degli anni Ottanta viaggiando in Asia e Nord Africa, il che gli garantí una grande quantità di nuovo materiale antropologico da catalogare.
Nel 1895 Le Bon scrisse il suo libro piú famoso, Psicologia delle folle, che offriva una visione esauriente seppure profondamente pessimistica delle dinamiche ...