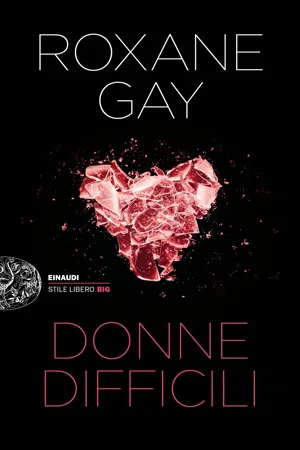Mia sorella decise che dovevamo andare a trovare suo marito: erano separati e lui viveva a Reno. Quando me ne parlò, mi venne subito la luna storta. Dissi: – E io che c’entro?
Carolina si era sposata a diciannove anni. Darryl, suo marito, aveva dieci anni di piú ma una testa piena di capelli, e secondo lui doveva pur significare qualcosa. Il primo anno avevano vissuto con noi. Mia madre lo definiva «mettersi in piedi», ma loro passavano gran parte del tempo a letto, quindi io ne avevo dedotto che «mettersi in piedi» fosse un eufemismo per «fare sesso». Quando finalmente avevano traslocato, Carolina e Darryl erano finiti in una stamberga che aveva la tappezzeria verde pisello e un balcone con la ringhiera mezza staccata, come un dente marcio. Io andavo a trovarli dopo le lezioni all’università locale. Di solito Carolina non era ancora rientrata dal suo turno di volontariato, per cui la aspettavo guardando la tv e bevendo birra tiepida con Darryl, che a quanto pareva un lavoro non riusciva a trovarlo e stava lí a fissarmi, ripetendomi che ero carina. Quando lo riferivo a mia sorella lei rideva e scuoteva la testa. Diceva: – Con gli uomini c’è poco da fare, ma lui non ti darà nessun fastidio, te lo garantisco –. Aveva ragione.
Darryl aveva deciso di trasferirsi in Nevada, prospettive migliori disse, e disse a Carolina che lei era sua moglie e doveva seguirlo. Essendo sposato con mia sorella non aveva bisogno di lavorare, ma c’erano situazioni in cui dava prova di un incoerente tradizionalismo. A Carolina non piace sentirsi dire cosa deve fare e non aveva intenzione di lasciarmi. Io non volevo andare in Nevada. Risultato, lei era rimasta e loro due si erano ritrovati a vivere separati pur essendo marito e moglie.
Stavo dormendo – il braccio di Spencer, il mio ragazzo, pesante e caldissimo sul torace – quando Carolina bussò. Il rapporto con Spencer lasciava parecchio a desiderare per molte ragioni, non ultima la sua mania di parlare per battute di film, convinto di passare cosí per un cinefilo piú credibile. Lui mi scosse ma io gli diedi le spalle con un grugnito. Siccome non rispondevamo, Carolina entrò in camera nostra senza essere invitata e mi scivolò accanto. Aveva la pelle umida e stranamente fredda, come se avesse corso in pieno inverno. Sapeva di lacca per capelli e profumo.
Mi baciò la nuca. – È ora di andare, Savvie, – sussurrò.
– Non ne ho nessuna voglia.
Spencer si coprí la faccia con un cuscino e mormorò qualcosa di incomprensibile.
– Non farmici andare da sola, – disse Carolina con voce rotta. – Non farmi stare qui, non un’altra volta.
Un’ora dopo eravamo sull’interstatale, direzione est. Io mi ero appallottolata contro lo sportello, la guancia premuta contro il vetro. Mentre superavamo il confine californiano, mi raddrizzai e dissi: – Ti odio proprio, – però le stringevo il braccio.
Il Blue Desert Inn sembrava un luogo dimenticato da Dio e dagli uomini. Arabeschi neri e verde scuro di muffa coprivano lo stucco delle pareti. L’insegna al neon CAM RE L BE E crepitava nello sforzo di restare accesa. Non c’erano che poche automobili nel parcheggio.
– ’Sto posto è esattamente dove mi aspettavo che andasse a finire tuo marito, – dissi mentre parcheggiavamo. – Se ci vai a letto insieme proprio qui, mi dài una delusione tremenda.
Darryl venne ad aprirci in boxer cascanti e maglietta del nostro liceo. Aveva i capelli negli occhi e le labbra screpolate.
Si sfregò il mento. – Ho sempre saputo che saresti tornata da me.
Carolina gli passò il pollice sulla barba da fare. – Sta’ buono.
Lo scostò per entrare e io la seguii, lentamente. La camera era piccola ma piú pulita di quanto mi aspettassi. Al centro c’era un letto matrimoniale con il materasso infossato; accanto, un tavolino e due sedie. Dal lato opposto, un cassettone di quercia carico di tazze per il caffè da asporto, una macchiata di rossetto.
Indicai il grosso televisore a tubo catodico. – Non sapevo che ne facessero ancora.
Darryl arricciò il labbro superiore. Fece un cenno alla porta di comunicazione con la stanza a fianco. – Meglio che controlli se quella stanza lí è libera –. Diede un paio di pacche sul letto e fece brontolare il materasso quando ci si buttò sopra. – Io e tua sorella avremo da fare.
Nell’ufficio, un uomo fatto con la pancia e una zazzera di folti capelli rossi si piegò sul bancone, batté col dito su una pianta del motel e decantò i meriti di ciascuna camera libera. Io indicai quella vicino alla stanza di Darryl.
– E questa qua?
L’impiegato si grattò lo stomaco, poi si scrocchiò le nocche. – È un’ottima camera. C’è una piccola perdita dal soffitto del bagno, ma tanto uno si sta già bagnando, se è sotto la doccia.
Inghiottii. – La prendo.
Mi guardò da capo a piedi. – Che cosa le serve, due chiavi o un po’ di compagnia?
Feci scivolare sul bancone tre biglietti da venti. – Nessuna delle due cose.
– Come vuole, – disse l’impiegato. – Come vuole.
L’aria nella mia stanza era viziata e umida. Il materasso aveva un’infossatura familiare, come se la stessa persona si fosse spostata da una camera all’altra, lasciandosi dietro il peso del ricordo. Dopo un’accurata ispezione, premetti l’orecchio contro la porta che mi separava da Carolina e Darryl. A sorpresa, c’era silenzio. Chiusi gli occhi. Rallentai il respiro. Non so per quanto rimasi lí cosí, ma sobbalzai quando bussarono con forza.
– So che stai ascoltando, Savvie.
Aprii la porta e guardai storto mia sorella, ferma sulla soglia con le mani sui fianchi. Darryl era sdraiato sul letto, ancora vestito, con le caviglie incrociate. Mi fece un cenno di saluto e un sorrisone.
– In gamba, sorellina.
Prima che potessi parlare, Carolina mi tappò la bocca. – Darryl ci porta a cena fuori, al casinò addirittura.
Passai rapidamente in rassegna quello che avevo addosso: jeans scoloriti con un buco sfilacciato in corrispondenza del ginocchio sinistro e una canottiera bianca. – Non mi cambio.
Il Paradise Deluxe era un pugno in un occhio. La moquette era una sfortunata esplosione di rosso e arancione e verde e viola, le casse a soffitto strombazzavano musica rock. Il casinò era cosparso di slot machine scintillanti, ciascuna emetteva una serie dopo l’altra di suoni acuti che non ricordavano nessuna melodia nota ed erano per lo piú occupate da ubriachi che ragliavano a pieni polmoni schiacciando senza soluzione di continuità il pulsante per far girare i rulli. Mentre attraversavamo il salone in fila indiana – Darryl, Carolina, io – lui faceva cenni di saluto ogni pochi passi, come se fosse il proprietario.
Il ristorante era buio e deserto. Il nostro cameriere, un ragazzino alto alto e secco secco coi capelli unti di gel che gli pendevano sulla faccia, ci tese dei menu infilati dentro cartelline di plastica lercia e ci ignorò per i successivi venti minuti.
Darryl si appoggiò allo schienale, stirandosi e passando un braccio intorno alle spalle di Carolina. – Questo, – disse, – è il paradiso. Fanno la bistecca migliore di Reno, qui. Una carne cosí tenera e succosa che si taglia come burro.
Finsi di essere profondamente assorbita dalla lettura del menu, con la sua gamma di portate economiche a base di carne e roba fritta.
Darryl mi diede un calcio.
Posai il menu. – Devi proprio?
Lui mollò una pacca a mano aperta sul tavolo. – La banda si è riunita.
Mentre aspettavamo, Carolina passava pigramente una mano sulla coscia di Darryl. Lui si accese una sigaretta con delle strane smorfie, lasciando cadere la cenere sul tavolo.
– Non credo che tu possa fumare, – dissi.
Darryl si strinse nelle spalle. – Ho una certa influenza qui. Non mi dicono niente.
Io guardavo fisso la montagnola di cenere che lui stava creando. – Ci dobbiamo mangiare, su questo tavolo.
Lui espirò un filo di fumo perfetto.
Carolina mi sfiorò il gomito e guardò il marito dall’altro lato del tavolo. – Lasciala in pace, – disse.
Darryl e mia sorella si erano sposati davanti a un giudice di pace. Io le stavo accanto, con indosso il mio abito migliore – giallo, smanicato, stile impero – e un paio di Converse alte rosa. A lui faceva da testimone il fratello, Dennis. Il quale non si era neanche preso il disturbo di mettersi un paio di pantaloni lunghi, e indugiava vicino a Darryl e mia sorella in bermuda color kaki. Mentre il giudice blaterava di amore e obbedienza, io fissavo le ginocchia pallide e sporgenti di Dennis. I miei genitori e fratelli stavano tutti rigidi in fila accanto alla madre di Darryl, che masticava rumorosamente un chewing gum. Guai se non aveva una sigaretta in bocca. Dopo dieci minuti di astinenza, si sentiva malissimo.
Una volta scambiate le promesse, ci ritrovammo nel corridoio affollato di gente che andava all’ufficio infrazioni stradali e rinnovava la patente e chiedeva giustizia. Eravamo stati anche noi in quel tribunale tre anni prima a chiedere qualcosa, ma quel giorno non ne parlammo. Facemmo finta di avere tutte le ragioni per festeggiare. Dennis frugò in uno zaino e ne tirò fuori due birre tiepide. Lui e Darryl le aprirono seduta stante. Carolina rise. Un poliziotto con la pancia enorme che gli debordava sopra i calzoni li guardò da sotto le palpebre pesanti, poi si guardò le scarpe. A passi lenti e strascicati tutti si incamminarono verso il parcheggio ma io e Carolina restammo indietro.
Lei premette la fronte contro la mia.
Qualcosa di bagnato e pesante mi ostruiva la gola. «Perché lui?»
«Non andrei bene per un uomo veramente buono e Darryl non è veramente cattivo».
Sapevo con esattezza che cosa voleva dire.
Darryl lavorava di notte, gestiva un piccolo aeroclub poco fuori Reno, il genere di posto frequentato da giocatori d’azzardo e altri delinquenti che avevano disponibilità di liquidi e apprezzavano la discrezione quando dovevano viaggiare. Come fosse incappato in quell’impiego era un mistero. Non sapeva un granché di gestione, né di aviazione o lavoro. Ci invitò a raggiungerlo, quasi temesse che se avesse perso di vista Carolina lei sarebbe potuta scomparire. Un suo amico, Cooper, avrebbe portato birra ed erba. Mentre andavamo all’aeroclub, in macchina io ero seduta dietro e fissavo le lentiggini di Darryl: gli partivano dall’attaccatura dei capelli e gli scendevano per il collo e la spina dorsale formando un’ampia v. Quando Carolina si chinò verso di lui come se non fossero mai stati lontani, io distolsi lo sguardo.
– Non devi lavorare?
Lui si girò e mi sorrise. – Non tanto, con voi due signore ad aiutarmi.
– Potresti riportarmi al motel e ciao.
Carolina si girò a sua volta. – Se torni tu, torno anch’io, – disse, secca. – I patti li conosci.
– Voi due siete ancora attaccate come quei gemelli strambi, com’è che li chiamano, avete presente, tipo i gatti?
Io spulciai un buco dietro il sedile del guidatore. – Siamesi?
Darryl diede una pacca al volante e suonò il clacson. – Siamesi, sí, giusto.
Io annuii e Carolina tornò a guardare la strada. – Una cosa del genere, sí.
Un tempo eravamo giovani.
Dove andava Carolina, andavo io. Ci divideva un anno solo, praticamente niente. I nostri genitori avevano lasciato Los Angeles dopo la mia nascita. Con due figlie, sembrava piú opportuno vivere in un posto piú tranquillo, piú sicuro. Finimmo dalle parti di Carmel, in un quartiere di grandi casitas spagnole circondate da alte querce.
Io avevo dieci anni e Carolina undici. Eravamo nel piccolo posteggio accanto ai giardinetti del quartiere. C’era un furgone con un cielo notturno dipinto su una fiancata – un vivido blu cosparso di punti, perfetti e bellissimi, di luce bianca. Io volevo toccare le stelle brillanti che si susseguivano dal cofano del furgone fino al portello posteriore. Jesse Schachter, l’amica di Carolina, ci venne incontro e si mise a parlare con mia sorella. Il furgo...