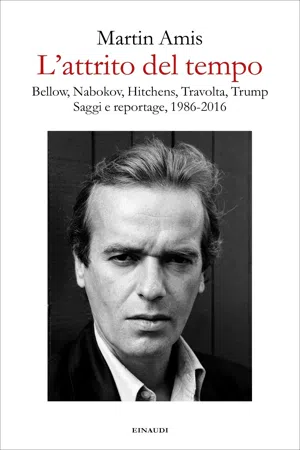La lingua conduce una doppia vita e lo stesso vale per i romanzieri. Parlano con parenti e amici, si occupano della corrispondenza, si districano nella lettura dei giornali, consultano i menu e le liste della spesa, rispettano i segnali stradali, eccetera eccetera. Poi entrano nel loro studio, e lí la lingua esiste in una forma completamente diversa: è il regno dell’artificio e della forma. Credo che molti scrittori sarebbero d’accordo con quello che Vladimir Nabokov (1899-1977) scrisse nel 1974 parlando del suo passato:
per me Parigi, con le sue giornate dalle tonalità grigie e le notti d’inchiostro, era soltanto la cornice casuale delle gioie piú genuine e piú costanti della mia vita: la frase colorita che affiorava nella mente sotto il piovischio, la pagina bianca, rischiarata dalla lampada da tavolo, che mi attendeva1.
Be’, la gioia della creazione è autentica, sebbene non sia fedele (come la quasi totalità dei personaggi femminili di Nabokov, la gioia della creazione, alla fine, non è che una spietata civetta). La scrittura resta un’occupazione molto interessante, ma il destino, o meglio la poderosa «stretta di mano del fato»2, per citare Humbert Humbert, ha previsto una punizione davvero singolare. Gli scrittori conducono una doppia vita. E vanno anche incontro a una doppia morte. È l’inconfessabile segreto della letteratura moderna. Gli scrittori muoiono due volte: una quando muore il corpo, l’altra quando muore la lingua3.
Nabokov buttò giú L’originale di Laura, o quel che ci è pervenuto, in una corsa contro il fato (una serie di brutte cadute, varie infezioni contratte in ospedale e alla fine un collasso bronchiale). Non è «un romanzo in frammenti», come afferma la copertina dell’edizione inglese: si capisce subito che è un racconto piuttosto lungo che si sforza di diventare un romanzo breve. In questa splendida edizione le pagine di sinistra sono state lasciate bianche, mentre su quelle di destra è riprodotto il manoscritto di Nabokov (con la sua energica grafia e l’ortografia traballante: bycycle, stomack, suprize)4 seguito dal testo in caratteri tipografici (infestato di parentesi quadre). Possiamo dire che è piacevole vedere da vicino le famose schede su cui scriveva, ma è anche vero che di Laura in fin dei conti resta ben poco al lettore. «Rombi e fragori aurorali avevano cominciato a scuotere la città fredda e brumosa»5: in queste parole sentiamo un’eco della musica nabokoviana. E nel passo che segue cogliamo un guizzo del divertente e impavido disprezzo nabokoviano nei confronti della nostra «abietta fisicità»6:
Detesto la mia pancia, quell’ammasso di visceri che devo portarmi dietro, e tutto ciò che ha a che fare con essa – il cibo inadatto, il bruciore di stomaco, il plumbeo fardello della stipsi, oppure l’indigestione con la prima scarica di rovente sozzura che sgorga fuori da me in un cesso pubblico7.
Comunque, in generale, Laura è una via di mezzo tra una larva e una pupa (per usare una metafora lepidotterologica): qualcosa di molto lontano dall’imago.
A parte una folata di interesse per l’opera, che a ogni modo fa sempre piacere, temo che l’unico risultato di questo cimelio sarà una leggera esasperazione di quello che già di per sé è un problema infernale. È infernale, per me, perché l’amore che provo per questo genio sconfinato, nonché fonte di sconfinata ispirazione, non ha pari. Eppure Nabokov, nel suo declino, fa sentire a disagio anche il lettore maggiormente in sintonia con lui, in quanto dà l’impressione, dall’alto della sua autorialità, di stigmatizzarne la volgarità, il perbenismo o la tendenza a prendere le cose troppo alla lettera. In Laura non c’è una vera e propria tematica (sarebbe a dire un motivo strutturale o quanto meno ricorrente). Ma notiamo un certo Hubert H. Hubert (un inglese puzzolente che sbava sul letto di una preadolescente), notiamo una vamp di ventiquattro anni con il seno di una dodicenne («con quei pallidi capezzoli strabici e quelle forme sode») e notiamo il sogno febbrile di un amore acerbo («il suo sederino cosí liscio, cosí illuminato dalla luna»). In altre parole, essendo innegabilmente incentrato sulla depredazione sessuale di ragazzine, Laura è imparentato con L’incantatore (1939), Lolita (1955), Ada (1969), Cose trasparenti (1972) e Guarda gli arlecchini! (1974).
Sei romanzi: sei romanzi, di cui due o forse tre sono capolavori monumentali. Bisogna ammettere, quanto meno, che questo problema infernale ha un che di nabokoviano se non altro per la complessità e la scabrosità. Giacché nessun altro essere umano nella storia ha fatto tanto per ritrarre in modo cosí vivido la crudeltà, la violenza e la penosa sordidezza di questo particolare crimine. Il problema, di natura estetica piú che morale, ha a che fare con l’intrinseca malignità degli anni.
Ci serve una parola che non abbia le implicazioni legali del termine «pedofilia», che, tra le altre cose, ha l’ingannevole significato etimologico di «amore per i bambini». La parola che fa al caso nostro è «ninfolessia», che non significa esattamente quello che potrebbe sembrare di primo acchito. È infatti «uno stato di frenesia provocato dal desiderio nei confronti di qualcosa di irraggiungibile», e giustamente il Concise Oxford Dictionary ne circoscrive l’uso a un ambito letterario. La ninfolessia è dunque un tema lecito, e praticamente inevitabile, per questo talento singolare. «Lo stile di Nabokov è in realtà lo stile di un innamorato», osserva lucidamente John Updike: «È l’ardente desiderio di stringere tra le sue braccia pelose una diafana precisione»8. Nell’ultimo Nabokov, però, la ninfolessia precipita nel suo significato etimologico: «dal gr. nympholeptos “catturato dalle ninfe”», sulla falsariga di epilessia («dal gr. epilepsia, che deriva a sua volta da epilambanein “afferrare, attaccare”»).
L’incantatore, ideato nella Berlino degli anni Trenta (con la voce di Hitler che spernacchiava dagli altoparlanti piazzati sui tetti) e scritto a Parigi (dopo la Notte dei cristalli, all’inizio dell’estenuante fuga dall’Europa dei Nabokov), è un romanzo brutalmente riuscito, tradotto magnificamente dal russo, quasi per osmosi, da Dmitri Nabokov nel 1987, dieci anni dopo la morte di suo padre. Dal punto di vista narrativo è logisticamente identico alla prima metà di Lolita: lo stupratore sposa – e forse uccide – la madre della bambina di cui poi si prenderà cura. Al contrario della formidabile Charlotte Haze («la dama dai nobili capezzoli e dalle cosce massicce»), l’anonima vedova dell’Incantatore, dall’enorme corpo asimmetrico per via delle numerose ospedalizzazioni e dei bisturi dei chirurghi, è già cagionevole in modo promettente. Ed è per questo che il suo pretendente scarta a malincuore l’idea del veleno: «E poi, la aprirebbero senz’altro, non fosse che per abitudine»9.
C’è il matrimonio e poi la prima notte di nozze: «appariva del tutto evidente che per lui (il piccolo Gulliver)» era fisicamente impossibile affrontare «quei molteplici dirupi» e «il disgustoso sbandamento del bacino massiccio». Ma «nel bel mezzo dei discorsi di commiato che avevano per tema un’emicrania», le cose prendono una piega completamente inattesa:
cosí che poi fu sorprendente scoprire il cadavere della gigantessa domata come per miracolo e contemplare il corsetto moiré che nascondeva quasi del tutto la cicatrice.
Molto presto la madre muore davvero e l’incantatore rimane solo con la sua dodicenne: «il lupo solitario si apprestava a indossare la cuffia da notte della nonnina».
In Lolita Humbert ha «vigorosi rapporti sessuali» con la sua ninfetta almeno due volte al giorno per due anni. Nell’Incantatore c’è un solo episodio di godimento, non invasivo, voyeuristico, masturbatorio. Nella camera d’albergo la bambina drogata dorme ed è nuda; il protagonista comincia «a passare la sua bacchetta magica sopra quel corpo», misurandola «con un regolo incantato». A un certo punto lei si sveglia, vede «la sua rampante nudità» e lancia un urlo. Quando ormai la sua ossessione è ridotta a una macchia via via piú fredda sull’impermeabile che si è infilato in fretta e furia, il nostro incantatore corre in strada, cercando di disfarsi in tutti i modi di un mondo «già visto fino in fondo» e «ormai inutile». Un tram gli si para davanti sferragliando, e sotto
quel mastodonte sempre piú grande, ghignante, megatonante […] quella fragorosa ferraglia, immediata visione cinematografica di pene infernali – ecco, trascinami sotto, lacera la mia fragilità – viaggio bocconi, con la faccia schiacciata giú […] non farmi a pezzi, mi stai maciullando, basta! Ginnico zigzag di un lampo, spettrogramma degli istanti di un tuono – e la pellicola della vita si spezzò.
Dal punto di vista morale L’incantatore è un libro diabolicamente schietto. Lolita, invece, è delicatamente cumulativo; ma nel suo giudizio sull’abominazione di Humbert è di sicuro piú severo. Per dimostrarlo basta mettere in evidenza semplicemente due punti chiave. Il primo è la tragica sorte della protagonista. Nessun lettore che non sia già preparato noterà che a pagina due del libro a cui dà il nome è descritta la triste fine di Lolita: «La moglie di “Richard F. Schiller” è morta di parto», dice il «curatore» nella Prefazione, «dando alla luce una bambina senza vita […] a Gray Star, un insediamento del piú remoto Northwest»; e il romanzo è quasi finito quando la moglie di Richard F. Schiller (sarebbe a dire Lo) fa la sua fugace apparizione. Ed è qui che ci accorgiamo, a bocca aperta, dell’entità dell’azzardo che Nabokov si è preso puntando cosí in alto. «Strano a dirsi, non è possibile leggere un libro», ha affermato (davanti a un leggio), «si può soltanto rileggerlo»10. Nabokov sapeva che Lolita sarebbe stato riletto un’infinità di volte. Sapeva che avremmo finito per assorbire la sorte di Lolita, la sua infanzia e la sua femminilità rubate. Gray Star, ha scritto, è «la capitale del libro»11. «Gray Star» (stella grigia), «lampi silenti», «fumo torpido», «fuoco pallido» e, sí, perfino «rovente sozzura»: è questa aggettivazione vaga il contrappunto nabokoviano.
Il secondo aspetto fondamentale è la descrizione di un sogno ricorrente che comincia a opprimere Humbert dopo la fuga di Lolita (è scappata con il cinico e carnale Quilty). È anche la dimostrazione che lo stile, la prosa stessa, è in grado di controllare la moralità. A chi verrebbe mai voglia di fare qualcosa che ha come conseguenza incubi del genere?
Lolita mi perseguitava nel sonno, ma vi appariva sotto le spoglie improbabili e ridicole di Valeria o di Charlotte [le sue ex mogli], o come un incrocio tra le due. Quel fantasma composito veniva da me, togliendosi un velo dopo l’altro, in un’atmosfera di grande malinconia e disgusto, e si adagiava in una posa di apatico invito su un’asse stretta o un divanetto rigido, la carne dischiusa come la valvola di gomma della camera d’aria di un pallone. Mi ritrovavo, la dentiera in frantumi o irrimediabilmente perduta, in orrende chambres garnies dove mi venivano offerti tediosi festini di vivisezione, che di solito terminavano con Charlotte o Valeria in lacrime tra le mie braccia sanguinanti, mentre le mie labbra fraterne le baciavano teneramente in un onirico caos di bric-à-brac viennese venduto all’asta, pietà, impotenza e parrucche marrone di tragiche vecchie appena uccise nelle camere a gas.
Quest’ultima frase, con la sua chiara allusione, ci ricorda con quanta dolorosa diffidenza Nabokov ha scritto del crimine piú atroce del secolo. Suo padre, distinto uomo di stato progressista (odiato da Trockij), fu ucciso a Berlino da un delinquente fascista; e Sergej, il fratello omosessuale, morí in un campo di concentramento nazista («Che gioia sapere che stai bene, che sei viva e che il morale è alto», scrisse Nabokov dagli Stati Uniti alla sorella Elena in Unione Sovietica nel novembre del 1945. «Povero, povero Serëža…!»). La moglie di Nabokov, Vera, era ebrea, e di conseguenza era ebreo anche il figlio (nato nel 1934); è molto probabile che, se non fossero riusciti a scappare dalla Francia (nel maggio del 1940, con la Wehrmacht a poco piú di cento chilometri da Parigi), i Nabokov sarebbero finiti tra le diverse migliaia di persone considerate di razza impura e consegnate al Reich dal governo di Vichy.
Che io sappia, nelle sue opere di narrativa Nabokov ha scritto dell’Olocausto per almeno un paragrafo solo una volta: nell’incomparabile Pnin (1957). Altri riferimenti, come in Lolita, sono fugaci. Si prenda, per esempio, la perfezione di questa frase da Segni e simboli, l’ispiratissimo racconto di sei sole pagine composto nel 1948 (è la descrizione di una matriarca ebrea):
La zia Rosa, una vecchia pignola, spigolosa, dagli occhi stralunati, che era vissuta in un tremulo mondo di cattive notizie, bancarotte, incidenti ferroviari, escrescenze cancerose, fino a quando i tedeschi non l’avevano messa a morte, insieme a tutti quegli altri di cui si era data pensiero12.
Pnin si spinge oltre. A una festa di emigrati nell’America rurale, una certa signora Špoljanskij, parlando di sua cugina Mira, chiede a Timofej Pnin se ha saputo della sua «fine orribile». «Sí, certo», risponde Pnin. Il mite Timofej resta seduto da solo nel crepuscolo. E Nabokov ci regala questo:
Gli accenni della loquace signora Špoljanskij avevano evocato l’immagine di Mira con forza inconsueta. Era una cosa sconvolgente. Solo nel momento del distacco, alla fine di un male incurabile, con la lucidità mentale della morte imminente, sarebbe stato possibile farvi fronte. Per poter vivere secondo ragione, Pnin aveva insegnato a se stesso […] a non ricordare mai Mira Beločkin, non in quanto di per sé la rievocazione di un amore giovanile, banale e breve, minacciasse la sua serenità spirituale […], ma perché, volendo essere sinceri con se stessi, era impossibile credere che sussistesse una qualsiasi coscienza, e di conseguenza una qualsiasi consapevolezza, in un mondo in cui erano possibili cose come la morte di Mira. Bisognava dimenticare – perché non ci sarebbe stato modo di convivere con il pensiero che quella giovane donna piena di grazia, fragile e tenera, con quegli occhi, quel sorriso, quei giardini e quelle nevi sullo sfondo, era stata portata su un carro bestiame in ...