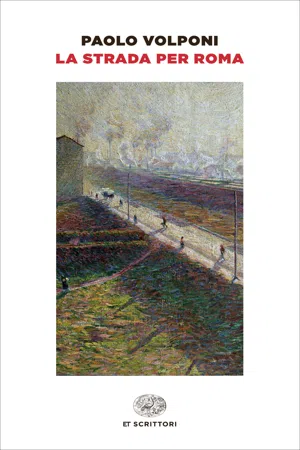![]()
![]()
L’uva esposta nella vetrina del negozietto della Pennabianca, il piú povero di Urbino, era già appassita e da qualche giorno abbandonata anche dalle vespe. Ormai per la strada di Santa Lucia veniva una tramontana bagnata, con un’ala salina sopra i tetti e i cornicioni, che rinfrescava la luce vecchia e ammorbidiva la polvere lasciata dall’estate. La luce restava anche dopo il tramonto, perduta tra i vertici dei tetti e cadeva solo, ormai nella notte, con l’ultimo stormo dei piccioni. Sotto, la strada cambiava per la seconda volta, con il buio che spalancava gli androni e le bocche dei vicoli e portava avanti i portoni e la corte dei frati. L’ultima lampadina che s’accendeva, mentre tutto dai frati sarebbe rimasto al buio, era quella del negozietto.
A quell’ora passava Guido, dopo aver chiuso i libri sul suo tavolino, chiusa la finestra tra i tetti verso il mare di Cattolica, scese le scale, chiusa con un colpo la porta di casa. Sulla strada un sollievo, e l’aria fresca dalle volte di Sant’Andrea, dalle fontane di cui il vento spandeva il filo. Guido guardava casa sua, le finestre una per una come una faccia, e si liberava di tutte le stanze che erano dietro, amandole come in un ricordo avventuroso e indulgente; ferme e fatte come sempre, ma con un altro respiro e di diverso odore. In quell’attimo ricostruiva il passaggio dalle stanze all’ingresso, alla grande sala da pranzo, fino alla porta segreta nella tappezzeria che portava nella sua camera. I fiori di carta, uno a fianco dell’altro, e il senso di vertigine che dava la loro prospettiva, di caduta nel vuoto; la maniglia, lo spigolo sottile di noce della porta, lo spiraglio e, sotto, le mattonelle del pavimento dal suono ben diverso dei mattoni della sala. Entrato e ricevuta sul braccio la vestaglia appesa dietro la porta, la prima cosa è la finestra. La finestra è grande al centro e la sua luce divide la stanza; da una parte il letto, la cassa in fondo, i due quadri religiosi e la fotografia della madre; dall’altra il tavolino, l’armadio e lo scaffaletto dei libri. Sul tavolo i libri del giorno, il necessario per scrivere, gli appunti e il manoscritto della tesi.
Anche quella sera Guido, appena fuori di casa, si riscaldava della sua presenza che lasciava in casa; si commuoveva e abbracciava se stesso; si assolveva per non essere riuscito a studiate fino al punto prestabilito. Cancellava un’altra giornata ansiosa, la sua insoddisfazione, le pause davanti alla finestra o sul libro aperto. Le pause, ogni volta che cantava Elena o che per la casa entrava o usciva; quelle pause che lo allontanavano da se stesso, che lo rapivano anche fuori del paesaggio di colline e poggi, con qualche albero in cima che spingeva ancora piú lontano, che rilanciava una curva per il cielo, all’infinito curve come all’infinito coppi sui tetti di Urbino, dalla parte di Lavagine, sotto la sua finestra. Nella strada Guido pensava che avrebbe studiato dopo cena, che in quel momento era libero e che poteva avviarsi.
Passava davanti al negozietto della Pennabianca, mentre andava verso la piazza, con i guanti infilati e annodata la cintura del soprabito, e guardò l’uva appassita; ripensò come tutte le sere da circa un mese: «Quando l’uva della Pennabianca sarà secca, il professore mi avrà risposto con un giudizio sulla tesi. Quando l’uva non ci sarà piú io saprò quello che dovrà succedere».
Riprese la marcia con il timore della risposta, ma anche consolato della presenza in vetrina del cestino dell’uva. La Pennabianca era dietro il banco e non si sarebbe mossa in quel momento per andare a togliere quel cestino. Arrivò davanti alla farmacia dello zio materno, aprí la porta a vetri e come sempre mise un attimo la testa dentro per salutare.
Da quel punto della strada si potevano vedere le luci del negozio di suo padre. Guido non girò la testa, ma mentalmente guardò quelle luci e le loro sfumature tra i telai della porta sino al selciato, al biancore degli scalini di pietra. Si voltò solo quando fu sicuro di non scorgere di fronte la figura del padre: aspettò che in mezzo apparisse l’ombra dell’uomo che gli stava sempre accanto, sempre pronto a seguirlo, a rispondergli come a tacere. Allora le luci erano già attenuate e non avevano piú quella crudezza che per tanti anni lo aveva torturato. Era la luce piú forte della città quella del negozio di suo padre; una macchia fredda, accanita, che lo sorprendeva ogni volta, come se l’arrestasse nel momento di compiere una mancanza.
Ripresa la semioscurità della strada, allungò il passo perché già vedeva, sotto il loggiato piú corto della piazza, la figura di Ettore. Mentre si avvicinava all’amico, Guido lo guardava e pensava: «È un ragazzo; siamo ancora giovani, siamo ancora in tempo. Ventidue anni, abbiamo ancora tre anni davanti».
Guido era torturato da un senso d’irrequietezza, senza un solo tratto fermo, che cominciava nel momento in cui sapeva di non essere piú un ragazzo. Ricordava gli anni del trapasso al liceo, gli abiti smessi, i giuochi, le compagnie folte, tutte le prove che aveva superato. Soprattutto gli sforzi di stomaco provati ai discorsi osceni dei piú grandi. Aver superato lo stimolo a vomitare era una delle prove piú convincenti della nuova età; adesso sarebbe dovuto riuscire a fare discorsi d’amore senza crudeltà.
Si avvicinò all’amico e lo salutò. Ettore gli domandò: – Ti ha scritto il professore?
– No, – rispose, – e spero che non mi arrivi piú la lettera in questa settimana.
I due amici si accesero le sigarette e cominciarono la passeggiata. Il corso e il loggiato che lo affiancava erano pieni di gioventú che andava a spasso. Fra tutti, a gruppi, a coppie, in fila, non c’era in quella parte della città uno che avesse piú di venticinque anni. Erano tutti studenti, appena all’inizio dell’anno scolastico, allegri, con i vestiti nuovi e con i vecchi e nuovi compagni. La nebbia circolava fra di loro trasmettendo l’intesa e se ne illuminava. Avevano, tutti i ragazzi, impermeabili o cappotti, ai primi di novembre; le ragazze soprabiti e maglie. Tutti arrivavano con il giro fino ai torrioni sulle mura, dove la notte e il vento erano soli.
Guido ed Ettore si diressero verso il corso sapendo che a metà del loggiato si sarebbe unito a loro Alberto.
Guido disse: – Non ho voglia d’imbarcare Alberto, stasera. Se no ricomincia con i suoi discorsi d’amore e ci chiede dieci volte se lui può fidanzarsi con una studentessa.
Ma quando furono all’altezza del caffè frequentato da Alberto, Guido si fermò e si rivolse verso le colonne del portico: – Cammina, – disse. – Avanti, Alberto, racconta come ti va –. La sua decisione non aveva potuto resistere, perché la passeggiata era fatta apposta per tutti, proprio per annullare ogni tentativo e problema individuale, per amalgamarli con quella società che brulicava, per impastarli come la nebbia ai fiati di tutti. Cosí si poteva averne coscienza e scaricarne il peso, la crudeltà che stava annidata dentro il cuore, nel profondo delle stanze, dei vicoli e del silenzio familiare. Alberto era un amico molto leggero, remissivo, sopportava tutto, qualsiasi aggressione e qualsiasi crudeltà.
Guido poteva raccontargli che aveva voglia di uccidere suo padre e che pensava di farlo in un modo, che arrivava a spiegargli fino alle minuzie, che Alberto diceva: «è giusto, è giusto, ti capisco». Subito dopo poteva accettare l’idea di violentare una ragazza, di fuggire da Urbino o di andare a rubare alla Cassa di Risparmio, sempre con la stessa convinzione.
Quella sera, uscendo dal portico, disse: – E passata la Cancellieri –. Tutta la serata fu rapita dalla ricerca della Cancellieri. Guido ed Ettore la cercarono dappertutto, per le strade della passeggiata, con agguati alla fine del corso e ispezioni nei negozi. Non la incontrarono e poterono calmarsi solo quando cominciarono a parlarne. Ettore domandò: – Quando sarà tornata? Dove abiterà?
– A casa sua, – disse Guido, – nel piú bel palazzo di Urbino.
– L’hai mai visto dentro? – domandò Ettore.
– Sí, al ginnasio, e poi ho rivisto il cortile anche qualche mese fa.
– È vero che è di Bramante?
Piú facile che sia di Francesco di Giorgio Martini. Il duca Federico mentre si costruiva il suo palazzo avrà detto al suo architetto di fare anche la casa del suo consigliere, Bartolomeo Cancellieri. E gli diede il terreno proprio dalla parte dei Cancellieri, di quei terreni in alto che davvero custodiscono la città come una cancellata. Il primo Cancellieri aiutò il duca Federico a liberarsi del fratellastro Oddo Antonio, con una rivolta che precipitò il giovane Oddo dalle finestre del palazzo; intanto Federico accorreva da Gubbio. Cancellieri fu il primo a rivolgersi a Federico, chiedendo clemenza per tutti e offrendogli il ducato.
– Altro che palazzo gli avrà regalato!
– Poi ci fu un Cancellieri poeta, Gian Leone, e un altro, architetto militare. Avevano le piú belle terre d’Urbino, fino a Fossombrone, e la metà dei ponti sul Metauro.
– Per questo la Cancellieri si faceva sbattere dagli inglesi sotto le volte di Risciolo o al Pontaccio, – disse Alberto.
– Non è vero; aveva sedici anni in quel tempo.
– Sedici anni o no, lavorava con la bocca. Dagli inglesi tutti prendevano le sigarette, ma la Cancellieri prendeva certi sigari.
– È cosí bella che non può aver fatto queste cose. Nel quadro del padre di Raffaello dove tutta la famiglia Cancellieri prega ai piedi del trono della vergine, c’è una ragazzetta in ginocchio e con le mani giunte che le assomiglia perfino nel broncio.
– Anche questa s’inginocchiava, al Pontaccio davanti agli inglesi.
Guido e Ettore capivano di recitare una parte e forzavano la loro audacia per arrivare a scavare la verità e comunque a formarne una attraverso l’esaltazione d’ogni particolare e d’ogni parola. Alberto serviva bene fornendo gli spunti con innocenza. Costruivano sulla bellezza e sulla superiorità della Cancellieri. Ne respiravano l’aria lungo tutta la passeggiata.
– Con questa nebbiolina mi accontenterei di tenerle le mani sotto la maglia e di darle poi un bacio sulla bocca nell’androne del Pozzo Nuovo. Ma c’era sempre un odoraccio quando ci andavo.
– La bocca della Cancellieri dovrebbe sapere di qualcosa, perché razzolare tra quelle lane dei calzoni che avevano gli inglesi doveva essere abbastanza saporoso. In quelle botteghe dei calzoni, sotto i bottoni d’osso, tenevano sempre la cioccolata, sigarette, saponette e dentifricio per la Cancellieri.
– Già l’androne di Marcucci odorava un poco anche di dentifricio.
– L’acidità dell’immondezza e il fiorire della calcina.
Fiorisce la calcina a casa Cancellieri,
il tempo l’ha invasa e solo ieri...
– Basta la notte per farti farneticare, – disse Guido. Erano in quel momento usciti dal corso verso i torrioni per esplorare l’oscurità. La Cancellieri come i forestieri isolati avrebbe potuto violare i termini della passeggiata. Ascoltarono un momento tra la nebbia, al confine tra le luci del centro cittadino e il buio della campagna che ingoiava le mura e i quartieri pensili verso l’Appennino.
Non sentirono alcun passo: la ruota del vento li turbò e voltarono di nuovo verso l’interno luminoso, in zona di sicurezza. Accesero tutti e tre le sigarette. Decisero di spostarsi verso il Duomo e anche fino al buio infinito che avvolgeva casa Cancellieri. Non guardarono ment’altro che la speranza di vedere la Cancellieri. Ogni tanto nel vuoto appariva loro un gesto della Cancellieri, suggerito da una striscia di luce, dallo spiraglio della porta di un negozio. Non cercavano nella folla perché sapevano che lei non camminava tra gli altri, con la loro andatura. Un gruppo di ragazze si buttò contro Guido, ma egli continuò la sua strada senza guardarle, divincolandosi. Ettore taceva e Alberto camminava staccato di un passo guardando gli altri due, diviso come per difendersi da ciò che stava per capitare ai suoi compagni. Arrivarono al Duomo e si diressero davanti alla libreria, dove c’era piú luce.
– Questa piazza è fra le piú belle del mondo. Qui bisognerebbe avere il coraggio di fermare la Cancellieri; su quegli scalini dove i suoi sono sempre passati come padroni. Se avessi una spada, lo farei con un inchino. Il tempo è sempre quello e anche questa nebbia.
– Cancellieri ti manderebbe dietro due sbirri a farti la pelle, perché tu Corsalini non sei che il figlio di un commerciante.
– Allora il duello per le strade dell’Ospedale. Io li ammazzo e una suora mi passa un velo dalle grate di Santa Chiara per pulirmi una ferita al braccio. Il giorno dopo la Cancellieri va alla ricerca del velo insanguinato.
– Sí, per pulirsi la bocca dopo i suoi duelli con gli inglesi.
– Vedi quell’angelo a sinistra, sul Duomo? È sempre quello da quattrocento anni. Non si muove, guarda per aria con i suoi riccioli e con la sua tunichetta, sempre allo stesso modo. Cosí è la Cancellieri. Niente la tocca. Pensa le sue nonne quante ne avranno fatte, con i contadini e con i soldati. Eppure le Cancellieri sono sugli altari; sono le piú belle, come questa città, che non si corrompe né si commuove.
La città era ferma, rigida nelle ombre del Duomo e del Palazzo Ducale. I Santi non si vedevano navigare in alto tra la nebbia. Dal palazzo arcivescovile veniva un rumore, allargato dalle volte dell’androne e dalle folate nebbiose, come se qualcuno si buttasse a cavallo verso i vicoli di Porta Maia.
I tre giovani erano fermi a presidiare la luce della libreria; i passanti erano sempre meno ed erano già spariti anche gli ultimi della passeggiata.
– Solo libri di poesia si vendono qui, – disse Ettore guardando la vetrina, – solo poesie, critica di poesie, libri di pittura, e libri di scuola.
– È giusto, – disse Guido.
– No, non è giusto. Ci vogliono altre cose. Hai letto Gramsci? Questa è una società perduta e le poesie sono solo degli alibi.
– Ma certo. Che cosa vuoi di piú, qui? Bisogna andarsene; lasciare tutto com’è e andarsene a lavorare da un’altra parte. Raffaello se ne è andato a undici anni e non è piú tornato.
– Non è questo che voglio dire. La società italiana è perduta; dappertutto; anche a Roma, forse come qui. Che cosa vedi davanti a te se ti metti a pensare all’Italia?
– Ma se penso all’Europa?
– Ancora meno, vedi, salame; il buio delle miniere, qualche re, l’industria, le sigarette svizzere.
– E allora?
– Allora basta con le poesie. Bisognerebbe scrivere un romanzo, o soltanto leggerlo, che mostri questa società sopravvissuta...
– Toute l’âme résumée.
– Che cosa vuol dire?
– Niente: vuol dire tutta l’anima résumée. Mi sembrerebbe bello. Un grande riassunto. La professoressa al ginnasio ci chiedeva le résumées.
– Ecco, sempre, ti ricordi, ti ricordi?
– Andiamo avanti, se no la Cancellieri non la vediamo piú.
Avanzarono insieme un’altra volta e ancora dopo il primo passo si accesero le sigarette. Scesero le scalette di Palazzo Passionei e raggiunsero piazzale Cancellieri. Da lí avrebbero dovuto vedere le mura della città, il vallone di Schiavonia, la collina di San Bernardino, a sinistra il monte della Cesana e a destra i terreni di Cancellieri.
Non vedevano niente. Sentivano solo salire dalle vallate un’aria scoperta di campagna, quel freddo immacolato che avevano sentito quando si erano spinti fuori le mura, anche prima d’inverno.
La notte era intera e non lasciava scampo a nessuna cosa. Stavano zitti anche loro e Guido ed Ettore capivano che la notte non avrebbe fatto passare la Cancellieri. Il palazzo era chiuso e non sarebbe stato aperto per nessuno. Dopo che avevano fissato questa realtà, sentirono una voce rintronante che affiorava dal basso. Una inferriata a livello della strada faceva una luce come la traccia viscida di una lumaca. Si chinarono tutti e tre e poterono intravvedere una parte della cantina di casa Cancellieri. Veniva un odore di vino in fermento che l’aria notturna arrestava nel vano della finestra. Parlava un vecchio da solo, o con qualcuno che stava da un’altra parte; parlando batteva le botti con un martello di legno e le segnava con un gessetto. I tre amici si smarrirono del tutto e non seppero piú cosa cercare, davanti a quella finestra che da sola apriva la notte al posto del paesaggio fino all’Appennino; sola e profonda piú della notte stessa.
Alberto all’improvviso chiuse le labbra tra le mani e lanciò un grande fischio. Tutti e tre si diedero alla fuga per i vicoli con un rumore che spezzava le porte; anche loro quasi urlavano, tirando il respiro. Avevano nella gola le parole confuse di un’impressione che non potevano dominare. Si calmarono quando videro le luci della Posta. Arrivati in piazza, ormai ricomposti, si salutarono. Guido ed Ettore si diressero verso le loro case, mentre Alberto che cenava con i suoi molto presto, quando cenava, prima ancora della passeggiata, si ributtò sotto il loggiato deserto.
Guido andava dritto a casa per la cena; sapeva che quella camminata sarebbe stata una parentesi vuota prima di tutti i pensieri e i rancori che gli sarebbero saltati addosso appena seduto a tavola davanti a suo padre, a fianco di Elena. Eppure un pensiero lo colse: toute l’âme résumée, e fe...